Capita di rattristarsi quando muore un grande musicista. La morte di Geri Allen ci rattristò ancora di più perché la pianista era ancora giovane (aveva compiuto da poco sessant’anni, per l’esattezza il 12 giugno scorso ed è scomparsa il 27), perché oggi morire di tumore a quell’età presuppone che qualcosa non sia andato per il verso giusto, forse una terapia che non ha funzionato, forse una trascuratezza (sua o dei medici?). Chissà. A parte questo, siamo tristi perché se n’è andata una delle voci più importanti della musica afroamericana contemporanea.
Perché ci ritornano in mente le note di That Girl, una magnifica versione del brano di Stevie Wonder che Geri aveva deciso di incidere in un album del 2013, «Grand River Crossings»: una sintesi del suo concetto di musica che pescava nella grande tradizione per andare oltre, alla ricerca di qualcosa che, dopo lunghe peregrinazioni, torna a riaffermare la centralità dell’Africa, del blues. In quello stesso album la pianista rendeva omaggio a Detroit, nel cui sobborgo di Pontiac era venuta al mondo, e assieme al suo mentore, il veterano trombettista Marcus Belgrave, si produceva in assolo dall’intensità struggente.
Perché Geri Allen è stata una delle grandi donne del jazz moderno, un’artista che ha rimarcato la componente femminile di questa musica, la sua sensualità, il suo sentimento più romantico sfatando, se ce ne fosse ancora bisogno, il luogo comune che il jazz è una musica che quasi sempre si declina al maschile. L’abbiamo potuta ascoltare più volte dal vivo e i ricordi che abbiamo di lei, oltre a quello della sua musica – mai banale e sempre intensa – e del suo modo di confrontarsi col pianoforte usando uno stile personalissimo, percussivo ma allo stesso tempo lirico, tracciano l’immagine di una donna di grande bellezza, elegante, dal portamento fiero, di poche parole ma di forte comunicativa musicale.

All’inizio degli anni Novanta Geri Allen apparve spesso in Italia, e a Bari – la città di chi scrive – inaugurò un jazz club (lo Strange Fruit) con un concerto del trio che gestiva assieme a Charlie Haden e Paul Motian. In quel periodo Geri era incinta: all’epoca era sposata con il trombettista Wallace Roney, dal quale in seguito finirà per divorziare. I tanti spettatori che ebbero la fortuna di assistere a quella serata si resero subito conto, e c’è chi ne parla ancora oggi, che quella musica era destinata a lasciare il segno nella memoria collettiva.
Ma Geri Allen, come all’epoca non tutti sapevano, era sulla scena quasi da una decina d’anni. I più attenti si erano fatti incuriosire dalle frequenti citazioni, sulle riviste specializzate, di un acronimo – M-Base – concepito dalla fertile mente di Steve Coleman. Il sassofonista di Chicago, intento a cercare un sostegno teorico alla sua esigenza di dare nuove regole all’improvvisazione, celava dietro tale acronimo un apparentemente enigmatico «Macro-Basic Array of Structured Extemporizations», che negli anni avrebbe tentato di spiegare con risposte spesso più oscure della domanda di partenza (chi voglia cimentarsi con l’ardita dialettica colemaniana può comunque provare sul sito internet dell’artista: m-base.com/what-is-m-base).
In soldoni, si trattava di un movimento nato come risposta da parte dei giovani musicisti di Brooklyn (e soprattutto del quartiere di Bedford-Stuyvesant, abbreviato spesso in Bed-Stuy) alla rapidissima elevazione di Wynton Marsalis allo status di icona del jazz e al suo già latente conservatorismo. M-Base nacque da un confronto tra Steve Coleman e il cornettista Graham Haynes (figlio di Roy) e, a metà anni Ottanta, seppe raggiungere un’immediata popolarità decidendo di non chiudersi in una torre d’avorio ma scendendo in strada a trarre ispirazione dalla realtà quotidiana. M-Base fu una scuola di musica e di vita, un laboratorio, un’orchestra aperta che ribadiva la priorità del ruolo della blackness nella missione artistica di artisti destinati, quasi tutti, a scrivere di lì a poco pagine importanti del jazz contemporaneo.
La sintesi pensata da Coleman non disdegnava l’uso di linee di basso e figurazioni ritmiche mutuate dall’hip-hop e dal funk, e i musicisti nell’orbita del collettivo erano tutti giovani promettenti che sono ancora oggi in circolazione: Greg Osby, Cassandra Wilson, Ravi Coltrane, Roy Hargrove, Craig Handy, i chitarristi Kevin Eubanks e David Gilmore, il bassista Reggie Washington, il batterista Marvin «Smitty» Smith e diversi altri. Al pianoforte e alle tastiere sedeva quasi sempre Geri Allen. Ma per lei M-Base fu un momento di transizione, per quanto basilare, di un lungo percorso musicale.

Il suo stile pianistico rendeva già un forte omaggio all’intensità percussiva di Cecil Taylor e di Thelonious Monk; eppure, come sempre accade nel jazz, era la stratificazione di una serie di influenze che partendo dalle collaborazioni con Steve Coleman e con il flautista James Newton rendeva ragione di linee intricate e spigolose ma anche di momenti di grande romanticismo.
Il suo pianismo è stato amore per la drum thing della musica africana ma anche attenzione alle note «non suonate» e ai silenzi di un Count Basie oppure alle coloriture tonali di Duke Ellington. Poche volte come in Geri Allen la tradizione e l’avanguardia hanno saputo convivere l’una accanto all’altra: i suoi fraseggi erano liberi e scorrevoli, sia quando suonava all’interno della struttura sia quando dava l’impressione di volerne uscire. La sua grande maestria ritmica e armonica le consentiva di suonare figurazioni nel registro grave e ostinati di grande originalità utilizzando modulazioni metriche, spostamenti ritmici e dissonanze di notevole effetto.
Il tutto era caratterizzato da una spiccata sensibilità per le radici africane del jazz e della musica nera. Qualcuno ha anche paragonato il suo pianoforte a una m’bira, l’idiofono africano da cui è poi derivata la kalimba, e questo lascia comprendere l’inclinazione percussiva del suo stile. Non è un caso che si fosse pensato di farla interagire, come sarebbe accaduto all’Orto Botanico di Milano, con altri due giganti dello strumento, McCoy Tyner e Craig Taborn, due generazioni a confronto con lei a rappresentare il filo di congiunzione. Ed è un grande peccato non aver potuto assistere a un evento così rilevante.
Molti pianisti moderni recano oggi la sua influenza: in particolare Vijay Iyer, uno dei pochi ad aver saputo interiorizzare l’estetica M-Base nella propria musica e ad aver spinto ancora più avanti la sintesi tentata da Steve Coleman.

Riassumere il percorso artistico di una musicista così influente è impresa ardua. Il viaggio di Geri era iniziato molto presto, a sette anni, sotto la guida di Marcus Belgrave. Dopo gli studi a Detroit e una laurea in etno-musicologia con il sassofonista Nathan Davis si trasferì a New York per prendere lezioni da Kenny Barron. Nella Big Apple fu notata da Oliver Lake, Lester Bowie e Joseph Jarman; fu quest’ultimo a farla debuttare su disco nel 1983, con l’album «Inheritance». Entrò quindi nel collettivo M-Base, col quale incise svariati dischi («On The Edge Of Tomorrow», «World Expansion», «Motherland Pulse», «Sine Die»). Nel frattempo, giunta in Europa con il gruppo di James Newton, aveva già esordito come leader con «The Printmakers» (Minor Music, 1983, con Anthony Cox e Andrew Cyrille).
Accumulò poi numerose apparizioni in album di Lake, Pheeroan akLaff, Woody Shaw, Franco Ambrosetti e divenne richiestissima da musicisti di fama come Ralph Peterson, Dewey Redman, Charlie Haden e Paul Motian. In seguito suonò con Betty Carter e compose la suite Sister Leola, An American Portrait su commissione del Jazz At Lincoln Center. Fu chiamata, nel 1994, a far parte del quartetto acustico di Ornette Coleman, che nel 1996 le restituì la cortesia su un album per la Somethin’ Else intitolato «Eyes… In The Back Of Your Head». Nello stesso anno vinse il prestigioso Jazzpar Prize e, per l’occasione, scrisse la suite Some Aspects Of Water, poi incisa per la Storyville.
Ovviamente Geri ha suonato e registrato spesso con l’allora marito, Wallace Roney, su dischi importanti come «Along Came Jones» (1997, con Lonnie Plaxico al contrabbasso) e «The Gathering» (1998, con Robin Eubanks al trombone). Suonò anche con Charles Lloyd, che di lei serba un affettuoso ricordo, nel magnifico e rarefatto «Lift Every Voice» (2002, ECM). Ma vanno citati ancora gli altri tre Minor Music, «Home Grown», «Open All Sides In The Middle», «Twylight»; poi «The Nurturer» inciso per la Blue Note nel 1990 con Marcus Belgrave e Kenny Garrett, «Zodiac Suite: Revisited» dedicato a Mary Lou Williams – che la pianista interpretò nel film di Robert Altman, Kansas City – con Buster Williams, Billy Hart e Andrew Cyrille, «A Child Is Born» con Dave Holland e Jack DeJohnette e l’ultimo «Perfection», in trio con David Murray e Terri Lyne Carrington.
Background pianistico di alto livello, tocco e tecnica sopraffina, uno stile, come dicevamo prima, capace di passare da dolcezze estreme a sequenze aggressive, non privo di tentazioni sperimentali. Dopo la scomparsa di Kenny Kirkland, e prima dell’arrivo di Brad Mehldau, Geri Allen è stata il riferimento più importante del piano jazz contemporaneo.
Sentiremo la sua mancanza, e la sentiremo soprattutto perché con lei si allontana un modo di intendere il jazz, un approccio che travalica le definizioni e i generi per esplorare la musica nella sua essenza, nella sua radice più profonda. La sua è la generazione che si è formata ascoltando James Brown, Stevie Wonder, Kool & The Gang e tutta la musica nera a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta.
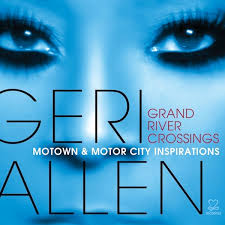 È un mondo che la pianista ha voluto omaggiare nel bellissimo e sottovalutato, «Grand River Crossings» citato a inizio articolo. Ascoltatelo, quel disco. Ascoltatelo con attenzione. È un piccolo scrigno di gioielli preziosi con una superba versione di Save The Children di Marvin Gaye. In quel disco scoprirete il mondo di Geri Allen, musicista che non era ossessionata dal culto delle radici e della storia del jazz e neanche dalla parola «avanguardia» ma mirava, riuscendoci, a sintetizzare tutto ciò in una personale e colta visione della musica.
È un mondo che la pianista ha voluto omaggiare nel bellissimo e sottovalutato, «Grand River Crossings» citato a inizio articolo. Ascoltatelo, quel disco. Ascoltatelo con attenzione. È un piccolo scrigno di gioielli preziosi con una superba versione di Save The Children di Marvin Gaye. In quel disco scoprirete il mondo di Geri Allen, musicista che non era ossessionata dal culto delle radici e della storia del jazz e neanche dalla parola «avanguardia» ma mirava, riuscendoci, a sintetizzare tutto ciò in una personale e colta visione della musica.
«Jazz è una parola che non fa parte del mio vocabolario», amava dire. «Non mi piace perché non sono stati i musicisti a scegliere di definire così la loro arte, e quindi preferisco non attribuire questo nome a ciò in cui sono coinvolta».
Il giorno successivo alla scomparsa di Geri, Enrico Rava ha scritto queste parole: «Una tristezza infinita… Geri Allen se n’è andata ieri pomeriggio. Una pianista meravigliosa e una bellissima persona. Dolce, profonda, affettuosa, curiosa. Era molto, molto malata. Sapeva di non avere molto da vivere ma aveva voluto comunque fare con me il tour di maggio perché, mi aveva confidato, suonare era ormai l’unica cosa che la faceva stare bene e le faceva dimenticare per un attimo la sua condizione disperata. Era commovente vedere come, dal momento in cui si sedeva al piano, l’energia rifluiva in lei, gli occhi le si illuminavano e mi regalava un sorriso che non riuscirò a dimenticare. Un grande insegnamento la forza con cui ha affrontato il tour con tutti quei viaggi e quegli spostamenti faticosi. Per me un colpo durissimo anche se me l’aspettavo, ma si spera sempre nel miracolo. Il miracolo non è avvenuto e io sono così triste che non riesco a scrivere altro».
Nicola Gaeta

INTERVISTA TRATTA DAGLI ARCHIVI DI MJ
Parla Geri Allen: la mia musica non ha limiti

Nel marzo 1988, Musica Jazz dedicò a Geri Allen la copertina, un lungo saggio e un’intervista.
Ecco cosa ci disse allora la pianista.
Geri Allen vive a Brooklyn, ed è qui che siamo andati a incontrarla per meglio conoscere questo nuovo personaggio del mondo del jazz. È un successo crescente – negli Stati Uniti ma anche in Europa – quello della trentenne pianista di Detroit, che un articolo del New York Times, intitolato «Nuovi volti per la nuova stagione», includeva nell’agosto scorso [1987] come unico rappresentante del jazz tra le «stelle» di sicuro avvenire in ogni campo della vita americana. A New York si parla molto di lei e diverse case discografiche stanno cercando di accaparrarsela, così come sempre nuovi leader: alla già lunga lista delle sue collaborazioni si aggiunge ora il nome di Wayne Shorter, per una tournée che toccherà in marzo anche l’Italia.
Ma tu, Geri, che ne pensi?
Non mi aspettavo nulla di tutto questo, assolutamente. Il bello della nostra professione è che non mancano le sorprese. Lo è stato quell’articolo, così come la telefonata di Shorter. È meraviglioso ed entusiasmante soltanto il sentire parlare di un artista di quel calibro. Chi l’avrebbe mai detto? Ai primi dell’ottobre scorso ho registrato, a New York, un album per la Soul Note con Charlie Haden e Paul Motian, ed ecco che, del tutto inaspettato, è comparso in studio Ornette Coleman in persona, un’altra grossa sorpresa, te lo posso garantire.
Essere una donna del jazz ti ha creato dei problemi?
Tutto sommato considero la mia esperienza piuttosto positiva, ma mentirei dicendo che non ho incontrato ostacoli. Più d’una volta sia il pubblico sia i colleghi m’hanno rivolto delle frasi pesanti, imbarazzanti. Proprio perché avevano a che fare con una donna.
Come nasce un tuo pezzo?
In modi diversi, ma spesso «sogno» la musica: mi sveglio improvvisamente e cerco di catturare quel suono percepito sognando. Può essere un testo o un motivo, dunque la base è naturale. La parte intellettuale apparirà in un secondo tempo.
Come descriveresti la tua musica?
Non lo farei mai. Sono certa che ciascun individuo, ascoltandola, prova delle sensazioni diverse.
 Parliamo ora delle tue formazioni.
Parliamo ora delle tue formazioni.
Il mio Open On All Sides è essenzialmente un ottetto con la vocalist Shahida Nurullah e con David McMurray a sax soprano e flauto, Rayse Biggs alla tromba, Tani Tabbal alla batteria, Jaribu Shahid al contrabbasso, Gerald Savage al trombone (nel disco c’è invece Robin Eubanks) e Sadiq Bey alle percussioni. Tutti questi colori e timbri concorrono a formare un sound universale, che mi serve per gli arrangiamenti e per evidenziare tanti piccoli dettagli. Sovente mi capita d’utilizzare soltanto pianoforte, contrabbasso e batteria.
Anche tu, a volte, diventi cantante…
Uso la voce come colore; direi che è soprattutto un recitare.
Perché il tuo ultimo disco s’intitola «In The Middle»?
Il mio lavoro ha un centro. Per il mio gruppo, Open On All Sides, non esistono limiti, come indica il suo nome: facciamo una musica molto profonda che combina stili diversi – come il sound Motown di Detroit, Stevie Wonder e Marvin Gaye – con il jazz ortodosso. Ognuno di noi ha assimilato, in passato, una gran quantità di stilemi musicali.
E tu, quanti tipi di musica hai suonato finora?
Moltissimi: africana, dance, ho perfino accompagnato Mary Wilson, una delle Supremes. Io comunque sono molto interessata all’evoluzione della musica nera, del Sud America, dei Caraibi, e via dicendo.
 Com’è nato il tuo primo album da leader, «The Printmakers», uscito nel 1985, con Anthony Cox al basso e Andrew Cyrille alle percussioni?
Com’è nato il tuo primo album da leader, «The Printmakers», uscito nel 1985, con Anthony Cox al basso e Andrew Cyrille alle percussioni?
Ero arrivata in tour in Europa con il quartetto di James Newton, assieme ad Anthony e Andrew. Stephan Meyner, che tempo prima avevo conosciuto a New York perché organizzava tournée europee (soprattutto in Germania e Austria) di jazzisti americani ed era venuto a cercare nuovi talenti, si era finalmente convinto a fondare una propria etichetta e mi ha chiesto di farne parte. Abbiamo registrato a Stoccarda nel febbraio 1984 e il disco è uscito l’anno seguente. Poi, nel gennaio 1985, sono tornata in Europa e, a Ludwigsburg, ho inciso «Home Grown» in solitudine. Nel 1986, a Detroit, ho portato in studio l’ottetto Open On All Sides mentre adesso sto lavorando a un album che si intitolerà «Twylight», imperniato sul mio trio con Jaribu e Tani più qualche ospite. A suo tempo avevo dedicato «The Printmakers» a tutti quegli artisti incontrati alla Howard University di Washington, quando studiavo laggiù, e che hanno influenzato il mio lavoro: pittori, scultori, cineasti. Parecchi, poi, hanno trovato il successo a New York.
Dunque tu credi alla fusione delle diverse forme artistiche…
Ah, certamente. Vado spesso al cinema, e qui a New York siamo fortunati perché arrivano film da tutto il mondo. Poi mi piace recarmi a visitare le mostre fotografiche e le gallerie d’arte.
Tu sei una delle principali esponenti, oltre che animatrice, della cosiddetta «Scuola di Brooklyn» che annovera, tra gli altri, Steve Coleman, Greg Osby, Jean-Paul Bourelly, Vernon Reid e Marvin «Smitty» Smith. Che cos’è esattamente questo gruppo di artisti?
Vedi, Brooklyn è molto più rilassante di Manhattan; ci sono alberi, giardini; la vita è più tranquilla e più adatta ai musicisti. C’incontriamo abbastanza spesso. Ci scambiamo le idee e analizziamo il business, le nuove tecnologie, e quant’altro ci tocca da vicino. È, se vogliamo, un’alternativa a Manhattan, dove l’ambiente dei club è piuttosto deprimente.
Ormai è risaputo che diverse grandi compagnie discografiche vorrebbero averti in esclusiva. Pensi di accettare le loro proposte?
Ho intenzione di proseguire lentamente, scalino dopo scalino; la mia opera ha bisogno di tanta libertà.
Quella che sembri aver trovato nella casa tedesca Minor Music…
Sì, Stephan Meyner ama rischiare e non cerca il prodotto commerciale, per cui ho potuto incidere le mie cose senza altre intrusioni.
Come giudichi il pubblico italiano?
Assai ricettivo. Sono stata in Italia alcune volte, con James Newton, con Mino Cinelu e con la Liberation Music Orchestra di Charlie Haden, a Roma, Milano, e sulle belle spiagge del Sud. Adoro la vostra cucina e l’ospitalità.
Ti senti più a tuo agio quando guidi un tuo gruppo o nei panni della sidewoman? Dico spesso che sono le parti a formare il tutto. Ho imparato e continuo a imparare molte cose stando vicina a James Newton, Joseph Jarman, Charlie Haden, Paul Motian, Lester Bowie, Steve Coleman. E quando faccio ritorno al mio gruppo mi scopro musicalmente arricchita.
Vedo qui, sul tuo tavolo di casa, la rivista Essence, destinata «alla donna nera d’oggi». E tu, sei impegnata politicamente?
Non è un mistero. In questo momento il clima politico negli Stati Uniti è terribile, fa paura. La gente soffre, regna l’ingiustizia, il razzismo si tocca con mano. L’industria discografica trascura i neri, la MTV dà spazio a Mick Jagger e ad altri bianchi che da sempre copiano gli artisti afroamericani. La Black Rock Coalition, un collettivo di artisti fondato da Vernon Reid e del quale faccio parte, denuncia apertamente queste ingiustizie e forse qualcosa sta cambiando: nel gruppo di Sting, per esempio, ci sono Kenny Kirkland e Branford Marsalis. Sono ancora tanti i problemi da risolvere: il Sudafrica, il crack, una droga terribile, le adolescenti incinte … Per me la musica è il rimedio più sicuro per tenere lontani i pericoli: i giovani musicisti scoprono che si può aver successo non solo vendendo droga.
Giuseppe Ballaris
