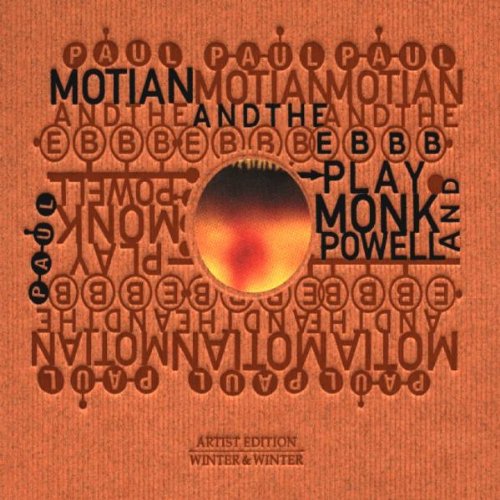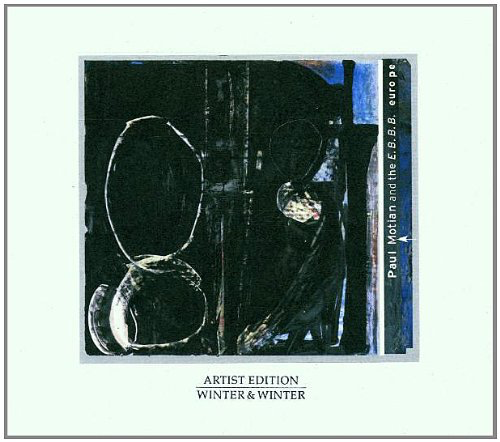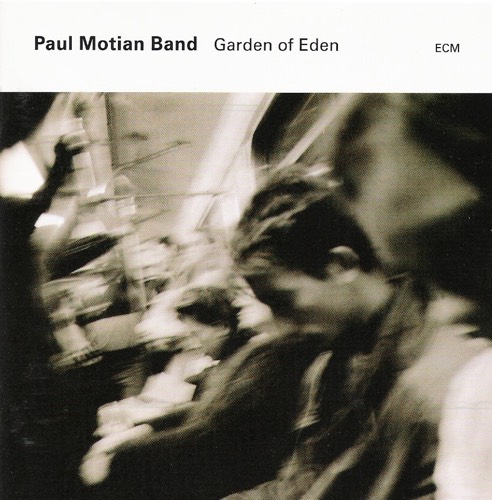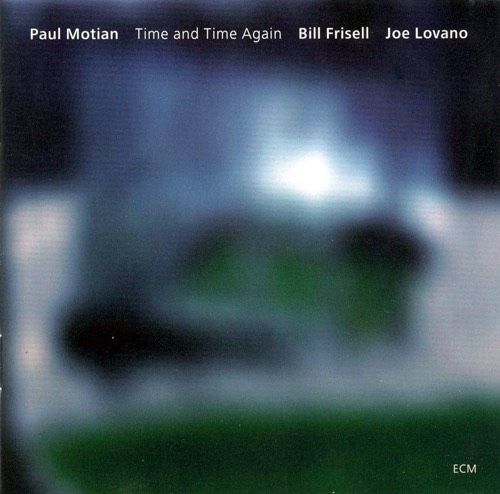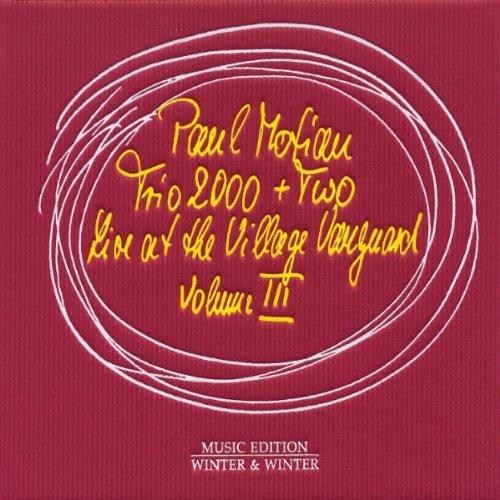Leggi la prima parte della Guida all’ascolto
I cd fondamentali
«Motian in Tokyo», JMT, 1991
Il prevalere di nuovi pezzi originali nel repertorio (otto su dieci) e il carattere essenziale, mai dispersivo, di tutte le esecuzioni fanno di questo primo live del trio immortalato su disco l’equivalente di una nuova tappa in studio. Stessa freschezza di contenuti e stesso impegno.
Rispetto al precedente «One Time Out», si avverte anzi il ritorno a una musica di dominante melanconica e meditativa. Frisell e Lovano sono al massimo delle rispettive autodeterminazioni stilistiche, ma muovendosi con soluzioni di equilibrio tra libertà e pertinenza quanto mai raffinate: dalle fusioni sonore alle intersezioni e agli assolo. Ovvero il trio è al massimo della sua coesione.
L’effetto di questa maturazione è senz’altro sorprendente in un pezzo come Mumbo Jumbo, dal riff spasmodico quasi al modo di Fiasco (e che dura ben undici minuti) o in Shakalaka e It Is, che pure presentano temi movimentati e malgrado Frisell non faccia certo economia di distorsore. Ma un’aria nuova tira anche nei più numerosi pezzi di natura opposta. L’iniziale From Time To Time, la squisita versione del colemaniano Kathelin Gray (tanto più efficace dell’originale di Ornette con Pat Metheny) e l’articolato Mode VI rigenerano la melanconia motianiana in chiave di un delicatissimo lirismo. The Hoax, breve interludio di Frisell in solo, imprime a quella malinconia una sottile venatura country (una delle direzioni in cui il chitarrista sta operando da leader). L’opportuna rilettura di Two Women From Padua ne chiarisce la complessa melodia, facendola poi sfilacciare in improvvisazioni liberissime ma che non la disperdono mai del tutto. Soltanto Birdsong, di filone liturgico e qui presente in due brevi versioni, rimanda senza differenze a pagine passate (Psalm, Yahllah, It Should’ve Happened A Long Time Ago…). Del resto, i pezzi di questo tipo non hanno mai presentato dispersioni di musicalità, né tanto meno di unità composizione-esecuzione.
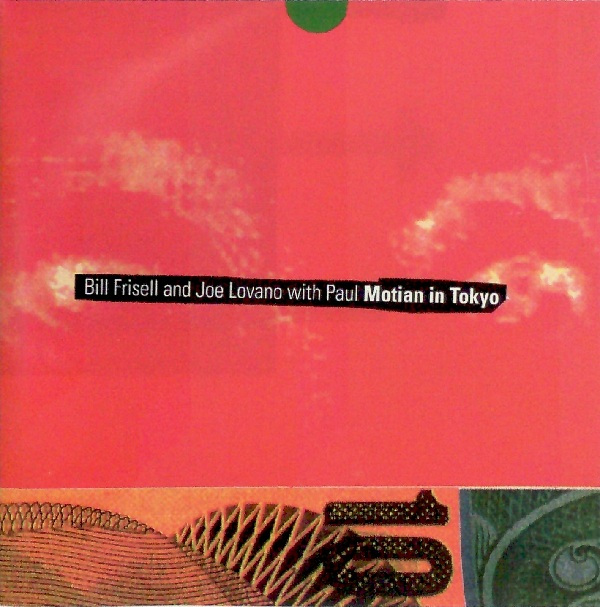
«On Broadway vol. 3», 1991
Lee Konitz come secondo ospite (accanto a Charlie Haden) di questo nuovo pacchetto di standard è naturalmente invitato a nozze. Sono pezzi sui quali ha lavorato e fantasticato per una vita, dai tempi del cenacolo tristaniano. Ma grazie a questo siamo ancora più lontani dal mainstream che nei precedenti volumi della serie: se pure certi squisiti dialoghi sassofonistici che il veterano maestro intesse con Lovano possono rievocare quelli con Warne Marsh, l’effetto di un bello jazzistico sempre ricco e originale scavalca la tentazione di parlare di neo-cool.
Paul Motian provvede a valorizzare Konitz riservandogli in più casi la formula del duetto a lui congeniale. Duetto di sassofoni con Lovano nella lunga introduzione a Weaver Of Dreams, di sassofono e chitarra con Frisell in Crazy She Calls Me e di sassofono e batteria con lui stesso in The Way You Look Tonight. Ma le note di Konitz, poeticissime ovunque, sono anche note moderne e si combinano perfettamente agli stili di Lovano e di Frisell – che infatti non ha bisogno di invocare Jim Hall o Billy Bauer, data la circostanza. E così al singolare senso del tempo che il leader pur sempre coltiva. Il pezzo che più direttamente rimanda al passato è un Pennies From Heaven parafrasato in tonalità minore e con linee incrociate (procedimenti entrambi tristaniani): ma si tratta di un passato precursore, maestro di tensione. Il solo neo del disco, una breve versione di Tico Tico, considerando che è forse impossibile dare dignità a questo tema.
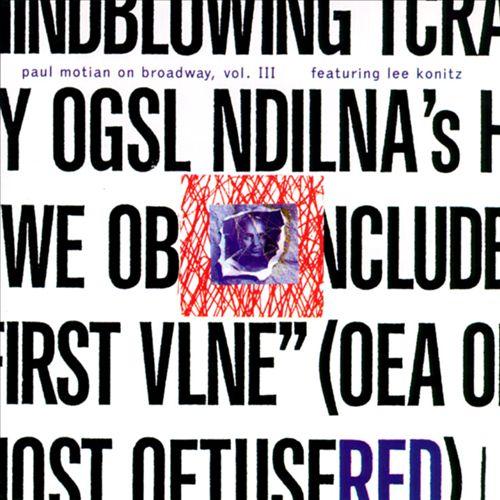
«Trioism», JMT, 1993
Le dieci splendide esecuzioni di pezzi originali che compongono questo disco (di cui otto nati per l’occasione) sembrano tracciare un punto d’arrivo del trio perfettamente complementare a quello che già ci è parso di riconoscere nel live giapponese. Una sorta di completamento del discorso che pertanto richiama in causa i picchi di angoscia e di ferocia, la crudezza dei passaggi eseguiti in duo e in solo e i suoni più brutalmente distorti della chitarra di Frisell.
Malgrado un’alternanza tra pezzi meditativi e concitati più rigorosa, che pertanto distribuisce equamente nel disco le due tipologie, i pezzi che possono dirsi lirici sono dunque pochi. Non l’iniziale rivisitazione di It Should’ve Happened A Long Time Ago né Play, che quasi rimanda a una casta melanconia vivaldiana, come del resto anche Zabel per chitarra sola. Lo è senza dubbio lo splendido Blue Midnight (che non a caso verrà riproposto nella fase più matura della Electric Bebop Band) e con qualche riserva Monica’s Garden, piuttosto affine ai pezzi dagli stati d’animo indefiniti, dubbiosi. Il resto è puro Motian «della crudeltà». Due dei nuovi originali, Cosmology e Congestion, sono temi contorti che discendono chiaramente da Jack Of Clubs, qui infatti riproposto nella sua versione più concisa. In Remembrance Of Things Past, di un’angoscia cupamente mediorientale, è eseguito con Dewey Redman al posto di Lovano, il cui suono sarebbe evidentemente risultato troppo tondo. Endgame, dal tema ridotto a due scale discendenti, chiude il disco all’insegna dell’assurdo, il vuoto emotivo dello stato nevrotico.
«Trioism» è l’ultimo disco del trio registrato in studio prima del suo scioglimento, pur essendo soltanto il quarto del trio allo stato puro, senza ospiti. Ma queste erano state le scelte di Motian. Difficile che il trio non avesse esplorato tutto il possibile.
«Flight Of The Blue Jay», Winter & Winter, 1996
Il tempo impiegato da Paul Motian per maturare la regia della Electric Bebop Band (nata quattro anni prima e con alle spalle due dischi dal carattere non molto marcato) si traduce improvvisamente in un risultato memorabile qual è senz’altro questo disco.
Motian compositore si limita a firmare l’eponimo prologo, minimale e ineffabile. Perché l’intento del progetto è esclusivamente registico, appunto: rimacinare il seme del più importante jazz passato attraverso concezioni contemporanee del suono e del tempo. Ciò che per Motian si pone come un tratto nuovo – dopo averlo appena abbozzato con il quintetto – è quindi l’idea di ispessire il fronte melodico raddoppiando sassofono e chitarra e selezionando interpreti di ciascuno strumento che si muovano grosso modo sulle stesse altezze di ottava, ma di cui si distinguerebbero (o si distinguano?) necessariamente – per timbro, fraseggio, gusto, dettagli dell’impostazione tecnica – le linee improvvisate. Funzione che sembrano assolvere nei modi più felici sia i tenoristi Chris Potter e Chris Cheek (il primo solo lievemente più enfatico del secondo) che i chitarristi Kurt Rosenwinkel e Brad Shoeppach (sebbene entrambi un po’ revivalistici e sulla linea più di Billy Bauer che non di Jim Hall) – Steve Swallow al basso elettrico si avverte ancora poco.
Sicché, dopo quel prologo motianiano (così poco trascurabile che Jean-Marc Padovani lo includerà nel repertorio del suo recente omaggio al batterista), sfilano per il disco versioni freschissime di grandi temi come Pannonica, Light Blue e Work di Monk, Celia di Powell, l’originario Milestones di Davis e John Lewis, Conception di Shearing, intercalati da due squisiti originali di Rosenwinkel che suonano contemporaneamente retrospettivi e attuali. E sfilano tra sassofoni e chitarre che si rincorrono, intrecci di tutte le linee che conducono a nuova vita i principi tristaniani e – cosa in fondo più normale ma non per questo da svalutare – assolo individuali puntualmente azzeccati, intelligenti, trasversali, ricchi di amore per il pezzo in questione.
Insomma, parlare di mainstream sarebbe drammaticamente riduttivo. Anzi depistante.
«Play Monk And Powell», Winter & Winter, 1998
Paul Motian approfondisce e particolarizza il discorso di «Flight Of The Blue Jay» con un repertorio dedicato unicamente a composizioni di Monk e di Powell, selezionate oltretutto con notevole acume.
Il chitarrista Steve Cardenas, subentrato a Schoeppach, si differenzia un po’ di più dal baueriano Rosenwinkel; e le linee di basso di Swallow – unico elemento esteticamente «elettrico» del gruppo – si fanno relativamente più evidenti. Ma l’alta qualità del disco, forse persino migliore del precedente, deriva da un lavoro più attento – e ancora una volta affettivamente ricchissimo – da parte di tutti. Il progetto d’insieme, a parte il drumming del leader, può apparire un po’ meno originale. Sopravvivono belle intersezioni di sax e chitarra e bei passaggi in duo di sassofono e basso o sassofono batteria, ma pochissime le intersezioni tra le linee dei sassofoni (la più suggestiva è in I’ll Keep Loving You) e senza dubbio preponderanti gli assoli individuali e gli exchanges.
Naturalmente, trattandosi di questo gruppo e di pezzi di Monk e di Powell, comprese chicche poco battute come Blue Pearl (di Powell) e Boo Boo’s Birthday (di Monk), il disco non può essere che «bello» a tutti gli effetti. Mai banale. Bisognerebbe prenderlo così e basta. Al limite, escludendo dal giudizio la ridondante incorniciatura pseudo-rumoristica del Parisian Thoroughfare finale.
«Europe», Winter & Winter, 2000
Pietro Tonolo (che suona anche il soprano) subentra a Potter nel duo di sassofoni, Ben Monder a Rosenwinkel in quello di chitarre e Anders Christensen a Swallow al basso elettrico, mentre Motian sta chiaramente inseguendo nuove idee circa il senso della Band. Tanto che il disco è per forza disomogeneo, fatto di episodi come sempre interessanti ma orientati in più direzioni.
Il monkiano Oska T. che fa da ouverture rievoca/cita con un unisono di chitarre e sassofoni il suono della versione originale di Monk con orchestra al Lincoln Center. Due altri pezzi monkiani (Introspection e il più spigoloso Gallop’s Gallop), insieme a 2300 Skidoo di Herbie Nichols, sono versioni fresche di grandi temi come quelle dei due dischi precedenti. Di intensa tenerezza è poi la riproposta di If You Could See Me Now, standard che da questo momento si rivela particolarmente caro a Motian. Il parkeriano Bird Feathers suscita invece suoni chitarristici quasi alla Frisell, i quali naturalmente si esasperano tra la libera improvvisazione di tutto il gruppo nella nuova versione di Fiasco, per nulla meno caustica dell’originale in trio.
Ma sono forse due pezzi lirici e di esecuzione prevalentemente corale a riservarci i momenti di maggiore originalità della Band: la nuova versione di Blue Midnight, naturalmente tanto più prodiga di elementi di quella di «Trioism», e il modale, sensibilissimo New Moon di Steve Cardenas. Sono d’altronde i pezzi in cui Motian più si avverte come regista e meno come batterista: ruolo che nel resto del disco sembra aver svolto in modo piuttosto camaleontico.
Il punto è che nessuna di queste nuove esecuzioni può dirsi debole o di routine. Al contrario!
«Holiday for Strings», Winter & Winter, 2001
La scelta di includere nel repertorio e assumere come cover la vecchia canzone Holiday For Strings, proveniente da un’area della musica popolare americana ben distinta da quella degli standard, ci offre una chiave di lettura dell’intero disco, dal quale sono infatti assenti gemme del jazz passato. Perché qui Paul Motian è in vena di soffermarsi su stati dell’essere diversi da quelli estremi, più capillari e in qualche modo de-specializzati rispetto a quelli che il jazz ha più comunemente a portata di mano. Cioè stati della musica sospesi tra ambigue evocazioni, melanconie diluite nell’atmosfera e qualche momento di palese, commosso sentimento.
Forse per questo, i pezzi appaiono in più casi concatenati tra loro. Il nuovo originale Arabesque, posto in apertura, sembra fare da preludio al vecchio 5 Miles To Wrentham, ben meritevole di una versione sonoramente più ricca dell’originale, che a sua volta fa da preludio a un pezzo originariamente obliquo quale Morpion, il cui tema, enunciato più lentamente, fa sfociare la sua linea pseudo-spiraloidale in un’esecuzione di dominante estatica. E in questo clima si inserisce il bell’originale di Monder Luteous Pangolin, con sbiaditi echi di barocco britannico.
Tra questo blocco di pezzi e il successivo fa da spartiacque una nuova versione di Look To The Black Wall che ne chiarisce l’impianto tematico ma per svilupparsi con begli assoli bop. Dopodiché siamo all’eponimo Holiday For Strings, portato a una tale ricchezza di armonia e di suoni da sembrare un originale di Motian, e a una versione di Endgame, che trasforma il pezzo da patafisico in quasi ascetico. Ma questo status di surrealtà non risulta disturbato né dalla puntata «sentimentale» di It Never Entered My Mind (sul filone delle tenere versioni di If You Could See Me Now e I’ll Keep Loving You), né dallo spigoloso Roundup di Cardenas, chiaramente ispirato da precedenti composizioni del leader, e riaffiora in pieno nel finale Oh, What A Beautiful Morning, riesumato dalle pieghe più melense del musical.
Ovviamente, l’altissima qualità musicale di questo disco (ciò malgrado sottovalutato) non è soltanto quella di un progetto. L’ascolto ci rivela costantemente l’impegno e il sentimento di tutti i membri della Band attraverso la bellezza di assolo che si stagliano dagli ensemble, di ensemble in sé stessi, di linee incrociate di sassofoni e chitarre (rese più suggestive dalle loro maggiori differenze introdotte rispettivamente da Tonolo e Monder) e dal loro stupefacente collegamento aereo al cuore pulsante di Motian, alla sua sorvegliatissima extrasistole.
«Garden Of Eden», ECM, 2004
Nella band (ormai non più chiamata Electric Bebop Band) si verificano alcuni cambiamenti: il robusto Tony Malaby sostituisce Tonolo e affianca Cheek, che qui suona anche il contralto, ai due chitarristi si aggiunge l’arguto Jakob Bro e Jerome Harris sostituisce Christensen al basso. Ma più di questo in sé – e nonostante l’aggiunta di una terza, eccellente chitarra – è ancora una volta l’energia che Motian suscita nei suoi compagni a contribuire direttamente all’assetto musicale e sonoro di questo straordinario disco che, anziché rispecchiare un progetto o un indirizzo omogeneo, appare in tutto come una summa della sua esperienza di leader, compositore, batterista, interprete contemporaneo del grande jazz passato, poeta e filosofo della musica.
È infatti un disco che contiene di tutto. Dalle corroboranti riletture di due capolavori mingusiani (Pithecanthropus Erectus e Goodbye Pork Pie Hat) al rinvenimento di una recondita canzone di Jerome Kern (Bill) e a tanti originali vecchi e nuovi (compresi uno di Cheek e uno di Cardenas) di cui ciascuno merita attenzione. Decisamente importanti le rivisitazioni di Etude, Mumbo Jumbo e Prelude, che costituiscono approfondimenti delle loro materie tematiche di forte stimolo anche per i solisti, e almeno altrettanto i quattro nuovi originali del leader, che sono insieme retrospettivi e propositivi. Endless, Garden Of Eden e Manhattan Melodrama dissodano e rimescolano i germi più intimi e psichici del percorso compositivo motianiano; Mesmer riprende dopo decenni il motivo della melodia popolare ma con un effetto tristissimo.
Un aspetto interessante è che i due pezzi dovuti rispettivamente a Cheek (Desert Dream) a Cardenas (Balata), per quanto visibilmente ispirati dal mondo di Motian, appaiono impregnati ciascuno di un sano legame a quello strumentistico del proprio autore. Qualcosa come sarebbe potuto accadere nei gruppi di Mingus, se non fossero stati altri tempi.
«Time And Time Again», ECM, 2006
Ricostituito per iniziativa di Manfred Eicher quasi dieci anni dopo le ultime propaggini della sua attività storica, il trio con Frisell e Lovano sembra tutt’altro trio. Frisell si mantiene sempre in prossimità di un timbro naturale, vicino a quello di Jim Hall, lasciando più evidenza a Lovano, che è cambiato molto meno, a parte una sonorità divenuta più pastosa; in ogni caso affascinante. La musica è infatti delicata, melanconica, evanescente, e nel primo disco inciso («I Have The Room Above Her» del 2004) non basta una breve versione di Dance – naturalmente la più «tranquilla» mai esistita – a interromperne un certo effetto di monotonia. Per nulla memorabili appaiono oltretutto i numerosi pezzi composti dal leader per l’occasione.
Fermo restante questo registro emotivo-musicale, qualcosa in più si ottiene dal successivo «Time And Time Again», registrato due anni dopo. Almeno la sensazione di un maggiore affiatamento nel gruppo, la qual cosa consente di apprezzarne il diverso volto in chiave di estrema raffinatezza dell’interplay e del montarsi delle parti in duo e in solo.
Ciò nonostante il repertorio è ancora dominato da frutti di un Motian minore e pochissime sono le esecuzioni di effettivo rilievo. In particolare, una nuova versione di In Remembrance Of Things Past, che forse a buon diritto riporta il pezzo a una lancinante melanconia (al posto della drammaticità passionale impressagli a suo tempo da Dewey Redman), l’interessante originale di Lovano Party Line, astratto e spigoloso, quasi alla Giuffre, e l’eponimo Time And Time Again, un apparente non tema, ben condotto da Lovano e che finisce per citare, o forse svelare come sua fonte armonica, il meraviglioso 5 Miles to Wrentham.
«At The Village Vanguard», voll. 1/2/3, Winter & Winter, 2006
Dopo il debutto in studio del 1997 («Trio 2000 + One», con ospite Kikuchi e, solo in qualche pezzo, Steve Swallow), il trio 2000 era presto diventato per Motian una formula di musica-nella-vita, utilizzata per serate dal vivo e, a partire dal 2003, principalmente in locali newyorkesi, sotto casa. Una formula quasi situazionista, con la quale aggregare al gruppo stabile (Motian, Chris Potter e Larry Grenadier ma di fatto anche Kikuchi) chi, per qualche motivo, ci poteva stare e improvvisare assieme.
Ma almeno la musica ripresa da queste tre serate al Vanguard – purtroppo le sole immortalate fra tante – ci si presenta come una prova estrema di quanto il rapporto tra composizione e improvvisazione concepito da Motian sia tutt’altro che un’ipotesi teorica e una strategia ostile alla libertà del contributo individuale all’esecuzione di gruppo. A parte l’indomito Fiasco, dal quale non si può derivare che una produzione di suoni indistintamente nevrotici, ciò che sembra verificarsi è che tanto le atmosfere di temi dai tratti marcati e più o meno dolenti (Standard Time, Olivia’s Dream, Morrock, Last Call, The Third Walk, The Divider e Ten, tra i nuovi; The Sunflower, The Hoax e Gang Of Five, tra i vecchi) quanto lo spirito un po’ décadent che emana da un paio di vecchie canzoni popolari (Till We Meet Again e And So To Sleep Again) – e che Kikuchi trapianta volentieri anche nel ricorrente If You Could See Me Now – letteralmente «ispirino» le libere improvvisazioni di Potter, di Greg Osby (ospite in tutti i pezzi) e di Mat Maneri (presente solo nell’ultima serata). Non sono improvvisazioni tematiche, se non per qualche brevissimo scorcio, ma la sensazione che si ha all’ascolto è che non portino mai fuori dal pezzo, neppure nei passaggi in cui si sovrappongono, a rischio di caos sonoro. Si arriva anzi a godere di questi suoni liberi e di questo continuo susseguirsi di situazioni impreviste come se si ascoltasse una jam session del passato, con appena qualche riserva sulla pertinenza della viola di Maneri.
Paul Motian ha sempre inteso esercitare così la sua funzione di leader e, forse per questo, è sempre stato piuttosto restio a immortalare la sua musica dal vivo. Qui, in ogni caso, della sua energia non sembra sia andato disperso nulla.
«Lost in A Dream», ECM, 2009
Ancora dal vivo e ancora al Vanguard, Paul Motian realizza la sua alchimia feconda in un modo ancora diverso, avendo a fianco un Potter che è insieme concentratissimo e deciso a suonare col cuore e un pianista in vario modo enfatico quale Jason Moran, che nessuno avrebbe mai immaginato adatto a un suo gruppo.
Circa due terzi del disco ci ripresentano infatti la musica di Motian come soprattutto lirica, intensamente lirica, e non a caso coincidono con i pezzi in cui meglio si inserisce il pianismo di Jason Moran, pur sempre proveniente da un’altra cultura del jazz. Ma quanto questo fosse nelle intenzioni del leader lo dimostra il carattere dei due soli pezzi nuovi, Casino e l’eponimo Lost In A Dream, modali e melanconici senza picchi di disperazione, e lo sottolinea la scelta di pezzi vecchi come il già lirico Blue Midnight e i sempre suggestivi Mode VI, Birdsong e Cathedral Song, all’origine dominati piuttosto dalla desolazione ma che proprio la presenza del piano trascina al lirismo. Per non dire di Be Careful, It’s My Heart, unico standard presente nel repertorio, in cui Potter stilizza il tradizionale suonatore di ballad. Naturalmente in un’accezione tutt’altro che negativa.
Il trio appare invece arbitrario nei tre pezzi costituzionalmente estranei a questo registro. Ten, che perde l’identità dolorosa tanto ben vissuta nella versione del Trio 2000 con Kikuchi e Osby; Drum Music, che finisce per sussistere effettivamente come pezzo di batteria, visto l’esercizio di stile che compete sia a Potter che a Moran nell’esposizione del tema; Abacus, pure assorbito da un lungo assolo del leader, con la differenza che Potter, indotto dall’africanità delle armonie, sfodera un po’ del Coltrane studiato in gioventù.
Peccato che questa volta Motian non sia andato fino in fondo. Ne sarebbe valsa la pena.
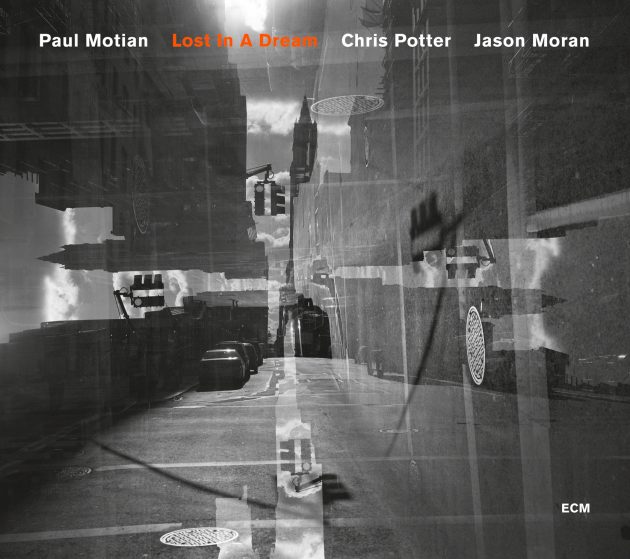
Paolo Vitolo
Leggi il dossier Paul Motian: la musica della batteria