Ci sono vocaboli nella storia del jazz che sono a dir poco abusati, veri e propri stereotipi utilizzati in modo eccessivo e talvolta improprio. Uno dei più battuti è certamente il termine «rivoluzione», e probabilmente tutti abbiamo letto testi che parlano del free jazz vedendo apparire, dopo poche righe, proprio quel termine: peraltro stimolato e in parte giustificato dalla forte connotazione socio-politica di cui si è tinto negli anni Sessanta, legata alla cosiddetta «protesta nera». Qualcosa di analogo successe già nel dopoguerra col bebop (per certi versi una fase musicalmente ancor più rivoluzionaria), quasi che si trattasse di eventi in musica improvvisi e traumatici capitati tra capo e collo, disegnando scenari di rottura netta col passato e relativa tradizione e invecchiando così istantaneamente qualsiasi cosa prodotta in precedenza. Sembra quasi che il jazz, prima di tali fasi, non potesse essere considerato un’arte degna di tal nome, il che sarebbe un evidente falso confutabile con facilità ma che gode inspiegabilmente ancora di un certo credito in larghe fasce di «appassionati».
Siamo dunque sicuri che sia corretto esprimersi in certe modalità quando si parla di jazz e, in particolare, di cultura musicale afro-americana? L’impressione è piuttosto che le cose vengano interpretate in modo eclatante ma un po’ superficiale, forse perché manca la progressione costante degli eventi propria di chi quelle fasi le ha invece vissute, o più semplicemente per difetto di approfondite conoscenze in materia.
Nel caso specifico del free jazz, l’omonimo disco di Ornette Coleman del dicembre 1960, considerato dai più una sorta di spartiacque tra tradizione e modernità in ambito di musica improvvisata, ha certamente contribuito a favorire una impressione di rottura pressoché traumatica col passato, specie se si è arrivati al suo ascolto senza una adeguata cognizione del pregresso, ma quel disco ha rappresentato più che un semplice oggettivo inizio di nuovi scenari musicali, anche un primo logico punto d’arrivo, una tappa di un percorso iniziato ben prima, sia per lo stesso Coleman che per il jazz più in generale e comunque ancora intriso di elementi della più profonda tradizione jazzistica che invece si è inteso derubricare, o comunque non sottolineare.

Quello inaugurato da Coleman è stato in realtà uno solo (per quanto fondamentale) dei percorsi intrapresi da diversi musicisti a lui coevi, in uno scenario di sperimentazioni musicali da tempo in corso e da far risalire almeno alla metà degli anni Cinquanta, individuando diversi precursori che hanno costruito progressivamente un processo a contributo plurimo in modalità assai meno discontinue di quanto usualmente raccontato e tali da condurre alla definizione di un approccio certo innovativo, «liberato» da certi schemi rigidi e stereotipati, per quanto non privo di strutture formali ma comunque in continuità sotto diversi aspetti con la propria tradizione. Il punto è che è possibile verificare, sia nella musica dei protagonisti di allora sia in quella prodotta dai jazzisti contemporanei (perlomeno quelli afro-americani), come tali fasi – portatrici di alcune discontinuità più che di autentica rottura – siano state dapprima metabolizzate a livello linguistico e poi progressivamente congiunte con il resto, finendo col tempo per far parte di quella stessa tradizione con la quale si supponeva di rompere.
È infatti difficile oggi ascoltare anche un musicista proveniente dal cosiddetto modern mainstream che non utilizzi stilemi e modalità esecutive proprie delle istanze innovative anni Sessanta ma entrate a far parte del vocabolario comune e consolidato nei musicisti dei decenni successivi. Dunque nessun reale trauma definitivo con la tradizione, semmai un allargamento delle possibilità e una revisione continua della stessa alla luce dei nuovi approcci che mano a mano si sono alternati e che le successive leve di improvvisatori del jazz hanno saputo assemblare nella loro musica.
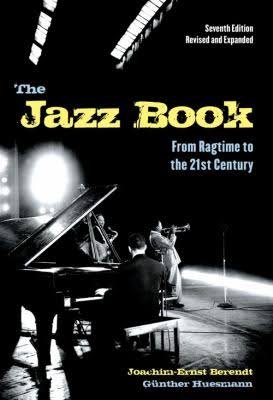
Molto acutamente, Joachim-Ernst Berendt sottolineava nel suo Libro del Jazz, parlando di armonia: «Il jazz degli anni Settanta e dei decenni successivi (…) unisce la libertà del free jazz alle possibilità armoniche degli stili jazz precedenti. La novità armonica è rappresentata dal virtuosismo e dalla maestria con la quale vengono trattate armonie di varia origine (…) la libertà non sta più nell’atonalità ma nella maestria con la quale si coordinano diversi sistemi (…). Per libertà si intende quindi anche la scelta fra libertà e rinuncia a essa. Questo concetto è superiore al carattere missionario e settario dell’idea di libertà nel free jazz degli anni Settanta, che condannava tutta la musica “non libera” come retriva non soltanto musicalmente, ma anche politicamente, socialmente e moralmente, togliendo così la possibilità di suonare musica esteticamente considerata bella».
È dunque chiaro che se si parte dalla validità dell’ipotesi della rottura si è portati in modo quasi naturale a giudicare chi ripropone vecchi schemi e materiali rivisitati come un «tradizionalista», «conservatore» e «reazionario» (per quanto spiriti revivalisti e conservatori nel jazz non siano mai mancati), termini infatti abusati oggi e spesso ingenerosi nel giudicare una larga schiera di improvvisatori afro-americani che invece si muovono in modo contiguo e coerente con le peculiarità metodologiche della propria tradizione musicale.
Gli è che si è preferito per troppo tempo raccontare (o forse era solo più facile) la storia del jazz per fasi stilistiche «progressive» abbastanza nettamente distinte, individuando alcune menti geniali che paiono in tal modo aver inventato quasi dal nulla la loro musica. È accaduto nella narrazione di Louis Armstrong, con Charlie Parker, per finire proprio con Ornette Coleman, ma tutto ciò ha poco a che vedere con i reali avvenimenti e con la cultura di loro appartenenza, che si è sempre mossa in un cosiddetto «continuum» e per contributi plurimi in un comune bacino di riferimento, sfruttando più la comunicazione orale che quella scritta, propria invece della musica accademica.
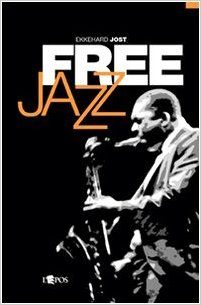
Non a caso il musicista e musicologo tedesco Ekkehard Jost nel suo Free Jazz, scriveva già nei primissimi anni Settanta: «Nel jazz non sempre risulta appropriato ascrivere il merito di definire nuovi principi creativi o di abbandonare i precedenti a una sola persona o ad una ristretta cerchia di innovatori all’avanguardia che impongono i nuovi termini di riferimento, presto accettati da un’ampia schiera di “compagni di viaggio” per le proprie creazioni. Soltanto in rarissimi casi la corrispondenza biunivoca fra progresso musicale e opera di un singolo “genio” (endemico difetto di prospettiva di un settore della storiografia jazz votato al “culto della personalità”) rende giustizia della rete di interrelazioni sottesa al formarsi di una nuova tendenza stilistica».
In che cosa si può allora parlare di rottura col passato? Sostanzialmente molto meno di quanto non si dica, o perlomeno secondo un processo di «allontanamento» da certi schemi e certe regole in realtà molto più progressivo che traumatico. Forse l’aspetto più evidente è stato il distacco dalla ineludibilità dell’aspetto ritmico e dal concetto di swing, determinando una relazione ritmica diversa, più variegata e meno definita tra la cosiddetta sezione ritmica e gli improvvisatori, ma in generale non si può parlare di abbandono assoluto, bensì di un ampliamento delle possibilità, poiché l’intreccio ritmico si è complicato, passando da una rigida quadratura del beat e al rispetto assoluto della metrica a una concezione decisamente più poliritmica e persino polimetrica, energeticamente intensa, non necessariamente legata quindi a una scansione ritmica fissa e al solo swing. I proverbiali cambi di ritmo e di metro nella musica dei collettivi di Charles Mingus, con tanto di accelerazioni e decelerazioni controllate, in questo senso già segnalavano una tendenza verso una liberazione ritmica più radicale. Né si può negare la revisione dei ruoli tradizionali assegnanti agli strumenti verso una idea decisamente più paritetica. In particolare quelli della sezione ritmica, come il contrabbasso, escono più decisamente che in passato dai compiti definiti di scansione e di dettatura dell’indirizzo armonico al solista, diventando protagonisti essi stessi di interventi solistici alla pari dei classici fiati. Musicisti come Charles Mingus e Max Roach possono essere considerati dei precursori in tal senso, poiché hanno contribuito moltissimo all’ampliamento delle potenzialità d’uso dei loro rispettivi strumenti, messo a punto poi da contrabbassisti e batteristi delle generazioni successive. Si pensi, per esempio, a brani come Drums e Percussion Discussion, registrati al Café Bohemia di New York a fine 1955, che manifestano dialoghi improvvisati tra basso e batteria fuori dagli usuali schemi dell’epoca e sui modelli prossimi al free in largo anticipo sui tempi. Senza contare dell’allargamento verso un campionario assai vasto di ogni genere di strumento, ben oltre le solite ritmiche piano-basso-batteria e front line costituite da trombe, tromboni e sassofoni, tipiche del bop e post-bop.
Sul piano del materiale compositivo da utilizzare per l’improvvisazione, occorre evidenziare un enorme allargamento delle fonti disponibili, andando oltre gli schemi armonici e metrici standard tipici della canzone, del blues, del gospel, grazie alla scoperta in quel periodo della musica mondiale, con particolare riferimento alla musica del mondo arabo e indiano. Quest’ultima soprattutto per la inusuale varietà ritmica che proponeva (utilizzata magnificamente, per esempio, da un musicista avanzatissimo e inclassificabile di quegli stessi anni, come Don Ellis) e la prima suggerita dalla conversione di molti musicisti afro-americani all’Islam con l’assunzione di nomi arabi, in evidente contrapposizione alla religione imposta dai bianchi. Lo scambio con culture «altre» ha così permesso il superamento del costante, quasi esclusivo, confronto dialettico con la musica e la cultura del mondo bianco occidentale di provenienza europea.
 Dal punto di vista armonico, sicuramente l’oltrepassare la barriera della tonalità e relativi vincoli dell’armonia funzionale è avvenuto in modalità diversificate e con più regolarità solo dopo l’avvento di «Free Jazz» di Ornette Coleman, ma non si può dire che non vi fossero stati già fondamentali esempi, nemmeno così infrequenti, negli anni antecedenti a quella incisione. Musicisti come Lennie Tristano, Charles Mingus, George Russell e Cecil Taylor avevano già preparato la strada verso lo spazio libero della atonalità, o comunque di un non rigido rispetto del sistema tonale, peraltro non da intendere esclusivamente in senso accademico. Si potrebbe infatti osservare che il jazz ha sempre avuto in sé una «tradizione atonale»: gli shouts», i field hollers, il blues arcaico e tutto quanto facente parte delle profonde radici della musica degli afro-americani contenevano qualcosa di «atonale», se non altro perché essi stessi non conoscevano la tonalità europea o non l’avevano imparata. A stretto rigor di termini le cosiddette blue notes sono «atonali», non a caso rifunzionalizzate in terze e settime minori quando suonate sulla tastiera di un pianoforte. Nel jazz, l’intonazione temperata è sempre stata accettata fino a un certo punto, ma con l’avvento di musicisti come Jackie Mc Lean e Eric Dolphy l’imperfezione del tono diventa una modalità esecutiva sullo strumento più sistematica, in grado di umanizzarne il suono e rendere inconfondibile il timbro di ciascun solista. Lo stesso Ornette Coleman utilizzava i suoi caratteristici passaggi in tonalità libera ben prima di conoscere l’atonalità europea tramite John Lewis e Gunther Schuller nel 1959, durante gli studi fatti nel Massachussetts, presso la Lenox School Of Jazz del Music Inn. Dunque, la tendenza crescente verso la liberazione dalle limitazioni imposte dal sistema tonale, in specie nell’improvvisazione, permea un po’ tutta la storia del jazz e certo esplose poi nei tormentati anni Sessanta.
Dal punto di vista armonico, sicuramente l’oltrepassare la barriera della tonalità e relativi vincoli dell’armonia funzionale è avvenuto in modalità diversificate e con più regolarità solo dopo l’avvento di «Free Jazz» di Ornette Coleman, ma non si può dire che non vi fossero stati già fondamentali esempi, nemmeno così infrequenti, negli anni antecedenti a quella incisione. Musicisti come Lennie Tristano, Charles Mingus, George Russell e Cecil Taylor avevano già preparato la strada verso lo spazio libero della atonalità, o comunque di un non rigido rispetto del sistema tonale, peraltro non da intendere esclusivamente in senso accademico. Si potrebbe infatti osservare che il jazz ha sempre avuto in sé una «tradizione atonale»: gli shouts», i field hollers, il blues arcaico e tutto quanto facente parte delle profonde radici della musica degli afro-americani contenevano qualcosa di «atonale», se non altro perché essi stessi non conoscevano la tonalità europea o non l’avevano imparata. A stretto rigor di termini le cosiddette blue notes sono «atonali», non a caso rifunzionalizzate in terze e settime minori quando suonate sulla tastiera di un pianoforte. Nel jazz, l’intonazione temperata è sempre stata accettata fino a un certo punto, ma con l’avvento di musicisti come Jackie Mc Lean e Eric Dolphy l’imperfezione del tono diventa una modalità esecutiva sullo strumento più sistematica, in grado di umanizzarne il suono e rendere inconfondibile il timbro di ciascun solista. Lo stesso Ornette Coleman utilizzava i suoi caratteristici passaggi in tonalità libera ben prima di conoscere l’atonalità europea tramite John Lewis e Gunther Schuller nel 1959, durante gli studi fatti nel Massachussetts, presso la Lenox School Of Jazz del Music Inn. Dunque, la tendenza crescente verso la liberazione dalle limitazioni imposte dal sistema tonale, in specie nell’improvvisazione, permea un po’ tutta la storia del jazz e certo esplose poi nei tormentati anni Sessanta.
Cecil Taylor, Charles Mingus, Eric Dolphy, John Coltrane e Miles Davis, oltre naturalmente allo stesso Coleman quando è comparso sulla scena a fine anni Cinquanta, hanno tra gli altri preparato il terreno, percorrendo strade differenti per giungere a un concetto di libertà in musica, assai ampio e variegato, ciascuno seguendo una propria precisa estetica e un proprio percorso evolutivo, non necessariamente traumatico. Tutti però hanno contribuito ad allargare le potenzialità del jazz sia in termini compositivi che improvvisativi, secondo le proprie idee e la propria visione di musica, disegnando un quadro di possibilità sfruttate poi ampiamente dai musicisti delle generazioni successive, sino ai nostri giorni.

Quanto al significato marcatamente politico e sociale associato al movimento free, esso ha contribuito molto a far parlare i più di «rivoluzione» e di rottura col passato anche in termini musicali, ma a ben vedere le cose si sono manifestate in modalità meno lineari e più articolate di come si sono spesso raccontate. Il concetto base che ha mosso il jazz, assegnandogli un connotato di «ribellione» (più che di «rivoluzione»), partendo, al minimo, dai tempi di Parker, Gillespie e Monk, è quello di «libertà» o «liberazione» da schemi musicali abusati, ormai frusti, e inevitabilmente questo poteva essere interpretato come lo specchio musicale della situazione sociale e di vita degli afro-americani, ma non si poteva parlare di totale identificazione tra le due cose, al più di naturale intreccio. Quel che si avverte nitidamente, se proprio si vuole parlare di «rivoluzione», è lo sganciamento dell’improvvisazione, solistica o collettiva che dir si voglia, dalle limitazioni armoniche imposte dalle usuali strutture formali, più che dalla tradizione in toto: niente più rigidi accordi prestabiliti e relative progressioni proprie della forma blues, delle canzoni, dei rhythm changes su cui erano abituati a operare i boppers e gli hard boppers, secondo schemi in molti casi divenuti solo dei comodi cliché.
Del resto vi è in musica un risvolto puramente intellettuale che ha coinvolto anche diversi musicisti bianchi. Basti pensare, per esempio, come Lennie Tristano avesse già annunciato i prodromi di un processo di liberazione musicale scevro da istanze politico-sociali che, per quanto egli potesse condividere, non poteva sentirle sulla propria pelle e vivere le stesse istanze libertarie degli afroamericani. Una liberazione operata soprattutto sul piano armonico e strutturale, rilasciando nel 1949 testimonianza – in largo anticipo sui tempi – nei due famosi brani incisi per la Capitol, Intuition e Digression. In quei brani si avvertono propositi e atteggiamenti non dissimili da quelli che si manifesteranno più di dieci anni dopo, cosa che peraltro lo stesso pianista italo-americano non si stancò di rivendicare sino alla morte. Per non parlare del suo successivo Descent Into The Maelstrom del 1953 (ma pubblicato solo nel 1972), un brano davvero visionario sovrainciso per più pianoforti in cui Tristano sembra anticipare le future intenzioni atonali di un Cecil Taylor e di una considerevole fetta del pianismo successivo più avanzato. Grandi musicisti bianchi come Jimmy Giuffre, Paul Bley, Don Ellis e Steve Lacy hanno saputo abbracciare certe istanze musicali senza forzatamente farsi partecipi in prima persona di quelle politiche e sociali dei loro colleghi afro-americani.

Quanto alla protesta nera in sé, probabilmente non è corretto enfatizzare un connotato politico-sociale esclusivamente legato all’avvento del free jazz, comportando tra l’altro l’adozione di un’analisi critica troppo incentrata sugli aspetti sociologici e poco su quelli musicali. Certo, all’epoca i tempi erano maturi per l’esplosione della protesta, ma a loro modo i neri hanno sempre combattuto per la loro causa, compatibilmente con le «condizioni al contorno» che erano loro permesse nelle diverse epoche. Nessuno infatti può seriamente pensare che nei decenni precedenti i musicisti afroamericani non avessero combattuto per i propri diritti, ciascuno a proprio modo e nelle condizioni storiche permesse.
 Da Louis Armstrong a Duke Ellington (un autentico nazionalista afroamericano sotto le mentite spoglie della sua eleganza e dei suoi sorrisi da navigato intrattenitore), da Charlie Parker e Dizzy Gillespie, passando per Miles Davis, Charles Mingus e Sonny Rollins (non si dimentichi la sua Freedom Suite del 1958, dove Rollins appose sulla copertina della prima edizione dell’album la seguente frase, poi sparita nelle ristampe: «L’America è profondamente radicata nella cultura nera: i suoi colloquialismi, il suo humor, la sua musica. Quale ironia che il nero, che più di ogni altro può reclamare come propria la cultura americana, venga perseguitato e represso; che il nero, il quale ha esemplificato le umanità nella sua stessa esistenza, venga trattato con inumanità») arrivando sino all’eclatante Max Roach di «We Insist! Freedom Now Suite» del 1960, è documentabile nel jazz la lotta per il riconoscimento dei diritti civili. Si può dire in fondo che gli afro-americani lo abbiano sempre fatto, sin dai tempi della schiavitù, e che per gradi siano arrivati a certi livelli «esplosivi» in quegli anni Sessanta secondo un progressivo percorso di liberazione durato forzatamente alcuni secoli.
Da Louis Armstrong a Duke Ellington (un autentico nazionalista afroamericano sotto le mentite spoglie della sua eleganza e dei suoi sorrisi da navigato intrattenitore), da Charlie Parker e Dizzy Gillespie, passando per Miles Davis, Charles Mingus e Sonny Rollins (non si dimentichi la sua Freedom Suite del 1958, dove Rollins appose sulla copertina della prima edizione dell’album la seguente frase, poi sparita nelle ristampe: «L’America è profondamente radicata nella cultura nera: i suoi colloquialismi, il suo humor, la sua musica. Quale ironia che il nero, che più di ogni altro può reclamare come propria la cultura americana, venga perseguitato e represso; che il nero, il quale ha esemplificato le umanità nella sua stessa esistenza, venga trattato con inumanità») arrivando sino all’eclatante Max Roach di «We Insist! Freedom Now Suite» del 1960, è documentabile nel jazz la lotta per il riconoscimento dei diritti civili. Si può dire in fondo che gli afro-americani lo abbiano sempre fatto, sin dai tempi della schiavitù, e che per gradi siano arrivati a certi livelli «esplosivi» in quegli anni Sessanta secondo un progressivo percorso di liberazione durato forzatamente alcuni secoli.
Scorrendo gli eventi storici e studiando meglio le dinamiche sociali e comportamentali, ci si rende conto che al di là dei naturali e più spinti moti reattivi di ribellione, dissenso e protesta, l’atteggiamento degli afroamericani non è stato mai davvero eversivo e in contrapposizione alla società americana, ma per lo più giustamente «arrabbiato» e risentito, cercando sempre di affermare i propri diritti, mossi dall’intento di liberarsi dalla emarginazione razziale, anelando all’accettazione prima e integrazione poi nella società americana, con l’obiettivo di arrivare a godere di pari opportunità rispetto ai bianchi.
«L’America è profondamente radicata nella cultura nera: i suoi colloquialismi, il suo humor, la sua musica. Quale ironia che il nero, che più di ogni altro può reclamare come propria la cultura americana, venga perseguitato e represso; che il nero, il quale ha esemplificato le umanità nella sua stessa esistenza, venga trattato con inumanità» Sonny Rollins
La conservazione dei contenuti emotivi e la forza degli elementi espressivi tradizionali costituiscono un dato incontrovertibile di continuità tra tradizione jazzistica e free jazz, rivestendo un ruolo musicale di rilievo, molto più di quanto normalmente si considera in ambito accademico. Soprattutto occorre evidenziare il mantenimento di un saldo rapporto dei musicisti afro-americani di quegli anni con le proprie profonde origini legate con il blues e gli spiritual, in perfetta linea peraltro con tutto il resto della loro cultura musicale. Basti pensare ad Archie Shepp in dischi come «The Way Ahead», dove egli esprime gli umori della protesta nera eloquentemente sulla base di un semplice blues canonico (Damn If I Knew), oppure nel successivo There is a Balm in Gilead (su «Blasé»), uno spiritual cantato da Jeanne Lee con l’accompagnamento di Lester Bowie alla tromba e dello stesso sassofonista.
 Shepp è, per certi versi, il musicista più emblematico nel rappresentare la tesi della continuità tra free e tradizione, rapporto che non solo non è mai stato assente nella sua musica, nemmeno nei momenti musicalmente più «feroci», ma si è addirittura esteso nei decenni successivi, prima con dischi per molto tempo incompresi in cui egli rileggeva a suo modo il r&b e la musica popolare nera (tutti i dischi Impulse! a cavallo tra fine anni Sessanta e inizio Settanta: da «For Losers» a «Kwanza», da «Attica Blues» a «The Cry of My People»), poi nelle incisioni dei decenni successivi, in cui si dedica esplicitamente a una rilettura dei grandi maestri della tradizione jazzistica e dei maggiori compositori del jazz, per arrivare ai nostri giorni. La stragrande maggioranza della critica ha parlato a questo proposito di una svolta conservativa e tradizionalista di Shepp, non riuscendo a cogliere invece l’estrema coerenza delle sue scelte che erano tese a valorizzare in toto la musica di propria appartenenza etnica, senza distinzioni di genere.
Shepp è, per certi versi, il musicista più emblematico nel rappresentare la tesi della continuità tra free e tradizione, rapporto che non solo non è mai stato assente nella sua musica, nemmeno nei momenti musicalmente più «feroci», ma si è addirittura esteso nei decenni successivi, prima con dischi per molto tempo incompresi in cui egli rileggeva a suo modo il r&b e la musica popolare nera (tutti i dischi Impulse! a cavallo tra fine anni Sessanta e inizio Settanta: da «For Losers» a «Kwanza», da «Attica Blues» a «The Cry of My People»), poi nelle incisioni dei decenni successivi, in cui si dedica esplicitamente a una rilettura dei grandi maestri della tradizione jazzistica e dei maggiori compositori del jazz, per arrivare ai nostri giorni. La stragrande maggioranza della critica ha parlato a questo proposito di una svolta conservativa e tradizionalista di Shepp, non riuscendo a cogliere invece l’estrema coerenza delle sue scelte che erano tese a valorizzare in toto la musica di propria appartenenza etnica, senza distinzioni di genere.
Allo stesso modo, la musica di Albert Ayler si rivela nel suo essere dissacratoria, pregna degli stessi elementi emotivi, seppur in misura e modalità espressive differenti rispetto a quelle di Shepp (lo testimonia un album basato su motivi tradizionali come «Goin’ Home», 1964), utilizzando anche richiami alla tradizione bandistica di New Orleans. Il suono di Ayler è lacerante ed esprime una rabbia ben diversa, spinto com’è al limite del rumorismo; eppure egli riporta al centro dell’attenzione la melodia, facendo spesso uso di marcette militari e semplici motivi folk riletti nel suo personalissimo stile. In modo analogo a Shepp, nell’ultimo suo periodo di vita Ayler si lancia in una rilettura del r&b in dischi come «New Grass», che hanno anche qui colto di sorpresa, se non lasciato di stucco, la critica dell’epoca, incapace di trovare altra abusata argomentazione se non quella di una improbabile svolta commerciale del sassofonista. Quel che invece par di cogliere è che per gli afro-americani non esistevano (ed evidentemente non esistono) separazioni e steccati tra un supposto «jazz colto» e il resto della loro musica popolare, perché nella sostanza il jazz stesso era ed è un ramo facente parte dello stesso albero, cresciuto dalle comuni radici culturali.
Analogo discorso, e forse anche a maggior ragione, si può fare per quello che è considerato il protagonista storico di questa svolta musicale, ossia Ornette Coleman, la cui musica è profondamente legata al blues e alla musica popolare. E non poteva essere altrimenti, visto che Coleman era originario di Fort Worth, nel Texas, terra come poche altre negli Stati Uniti di grandi tradizioni musicali, di folk, di r&b, di bluesmen e di grandi sassofonisti (come i cosiddetti honkers) profondamente intrisi di blues feeling. Diverse composizioni ornettiane aderiscono allo schema blues: Alpha, Tears Inside, Turnaround, Ramblin’, Blues Connotation, Broadway Blues, solo per citarne alcune, ma è difficile non rintracciare il blues e il r&b anche nella successiva musica dell’Art Ensemble of Chicago e in quella dei maggiori esponenti dell’AACM. Pressoché tutti i membri dell’associazione provengono da esperienze in quel popolarissimo ambito, le cui tracce musicali sono perfettamente udibili e integrate nella loro opera.

Proprio per tale ragione Ekkehard Jost sottolineava nel suo libro l’importanza degli elementi emotivi/espressivi, comunque di problematico riporto sul pentagramma: «Nel jazz raramente le emozioni giocano un ruolo puramente secondario rispetto a un processo creativo altrimenti razionale; al contrario, spesso risultano prioritarie sia per chi suona, sia per chi ascolta. Pertanto, descrivere solo ciò che può essere riprodotto tramite la notazione musicale e altre soluzioni grafiche sarebbe piuttosto improduttivo». Considerazione alla quale si potrebbe aggiungere l’aggettivo «limitante», in quanto pare evidente come un’analisi condotta esclusivamente in termini di notazione comporti un chiaro errore di traduzione, dovuto a una metodologia descrittiva in musica, valida in altri contesti culturali ma non completamente adottabile (e adattabile) intorno al jazz e al suo mondo, per quanto strumento comunque indispensabile a documentarne l’esito. Forse anche in questo sta la difficoltà di replicare il jazz con esecutori differenti, in modo analogo all’ambito accademico.
Sempre in tema di elementi emotivi e di forza espressiva, occorre osservare che anche i suoni striduli e certo rumorismo tipici del free jazz non sono considerabili una novità priva di precedenti nel jazz, in quanto essi basilarmente derivavano dalle tecniche adottate dagli honkers e dai sassofonisti r&b degli anni Quaranta e Cinquanta che ne facevano largo uso, in modo discontinuo ma di fatto sistematico nello sviluppo del discorso musicale. Nel free jazz questo ha finito per diventare prassi esecutiva. Viceversa, sarebbe per esempio difficile comprendere lo stile di un John Coltrane (che infatti aveva coltivato le prime esperienze con un maestro del r&b come Earl Bostic) e il relativo lavoro sugli armonici e sul timbro dello strumento, così essenziale per le leve sassofonistiche successive, senza la conoscenza di quel genere popolare e in voga nel periodo indicato.
Con il free jazz si manifesta poi un altro elemento legato profondamente alla tradizione jazzistica, ossia il ritorno alla prevalenza dell’improvvisazione collettiva, tipica dello stile New Orleans, rispetto all’individualismo dell’hard bop, che esaltava il virtuosismo e le doti solistiche dell’improvvisatore di turno, impegnato sempre più acrobaticamente a districarsi, un chorus dopo l’altro, tra i meandri armonici del materiale tematico: un lungo percorso, questo, iniziato da Louis Armstrong nella seconda metà degli anni Venti e portato pressoché alle estreme conseguenze dai maggiori protagonisti dell’hard bop anni Cinquanta. Tutto questo, associato alla liberazione dagli eccessivi vincoli dell’armonia funzionale, comportava la necessità di ricavare differenti livelli e modalità d’intesa tra i musicisti, non più legati forzatamente alla rigidità degli schemi metrici e del numero di chorus stabiliti per improvvisare, ma più a segnali musicali o riferimenti armonici meno vincolanti e persino ambigui rispetto a quelli più rigidi del sistema tonale, come per esempio i cosiddetti centri tonali o i legami motivici.
In questo senso, un ruolo decisivo lo ha avuto Charles Mingus, specie nei gruppi con Eric Dolphy, che si è sempre mosso in termini di improvvisazione collettiva utilizzando livelli di intesa tra i musicisti apparentemente impalpabili ma ben presenti. Ma più o meno tutti i musicisti accennati e coinvolti in tale innovativo processo hanno costruito nuovi riferimenti comuni per poter suonare assieme, adattandoli alle singole proposte musicali. Se si parte infatti dal presupposto che quasi ogni musicista coinvolto in quel periodo di grandi mutamenti a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta ha contribuito a sviluppare la necessità di ottenere una maggiore libertà in musica, finalizzata soprattutto all’improvvisazione, ci si rende conto di come tale processo si sia sviluppato con evidenti caratteristiche di progressività, che hanno limitato di molto le apparenti traumatiche discontinuità introdotte dal free jazz.

«Nel jazz non sempre risulta appropriato ascrivere il merito di definire nuovi principi creativi o di abbandonare i precedenti a una sola persona o ad una ristretta cerchia di innovatori all’avanguardia che impongono i nuovi termini di riferimento, presto accettati da un’ampia schiera di “compagni di viaggio” per le proprie creazioni» (Ekkehard Jost).
Innanzitutto, occorre rilevare che nel percorso temporale che va dalle innovazioni del bebop di metà anni Quaranta a «Free Jazz» di Coleman (se lo si intende utilizzare come primo punto d’arrivo), il jazz si è spostato da un massimo di complicazione armonica verso una sua progressiva semplificazione, al fine di favorire la libertà solistica, passando per l’hard bop di Art Blakey e Horace Silver fino a giungere al jazz modale di Miles Davis e John Coltrane, che riduceva lo schema armonico ai minimi termini, utilizzando ancora strutture AABA a trentadue battute ma associando a ciascuna sezione una sola scala su cui improvvisare, e consentendo di passare alla sezione successiva semplicemente con un trasporto di semitono della scala (So What per Davis), o addirittura usando un’unica scala per l’intero brano (Spiritual, per Coltrane). La libertà viene ricercata anche procedendo all’esposizione di temi essenziali su cui improvvisare melodicamente, fino a giungere alla scomparsa di un tema vero e proprio: avviene in Flamenco Sketches, dove la durata dell’improvvisazione non è più legata al numero di chorus ma è affidata al libero arbitrio del solista stesso, con cambi di modo annunciati dal gruppo e identificati dal solista di turno tramite segnali musicali codificati. Il che comporta un livello di intesa e di ascolto reciproco superiore, poi diffusamente utilizzato nel free dei decenni a seguire. Davis è stato un musicista chiave di tale percorso, se si pensa che, partendo in anni giovanili dall’esperienza nel quintetto di Charlie Parker, si è poi reso protagonista della svolta «semplificativa» hard bop (Walkin’) legata al blues e al gospel fino ad arrivare ai dischi «modali» come «Milestones», «Kind of Blue» e così via.
D’altro canto lo stesso «rivoluzionario» Ornette Coleman, da buon discepolo di Charlie Parker, è partito comunque da alcuni schemi basilari e dagli scheletri formali utilizzati dal bop: i brani, spesso velocissimi, sono quasi sempre suonati all’unisono da sax e tromba e seguono la tipica formula tema-improvvisazioni-tema. Le composizioni, per quanto melodicamente oblique, sono spesso costruite sulle strutture delle canzoni a 32 battute (su diciotto sue composizioni incise per la Contemporary, ben dieciseguono lo schema AABA, così come brani registrati in seguito per la Atlantic, vedi Chronology), anche se accompagnate da accordi tonalmente incoerenti e sviluppate da improvvisazioni che ne rifiutano le implicazioni armoniche. Un’incoerenza armonica in parte eliminata rinunciando al pianoforte fin dalle registrazioni successive al disco d’esordio. Coleman non disdegnava pure di interpretare a suo modo qualche standard reso celebre nel jazz da Bird (Embraceable You). Il suo sassofonismo, certamente derivato da Parker (Ornette aveva avuto occasione di ascoltare più volte a Dallas Buster Smith, che notoriamente era stato uno dei riferimenti strumentali citati dallo stesso Bird), sapeva poi esprimere poesia e grande lirismo.
Non si potrebbero descrivere diversamente brani come Lonely Woman, Peace, Beauty Is A Rare Thing, Just for You o Sadness. Quindi la sua concezione musicale, in apparenza così rivoluzionaria, possedeva realtà tutti gli elementi del jazz del passato e del presente, solo rielaborati in un modo davvero nuovo e soprattutto «free», nel senso pieno del termine. Non a caso nella sua musica sono rintracciabili anche degli elementi cosiddetti latin (si pensi a composizioni come Una Muy Bonita o a Latin Genetics) raramente riscontrabili, se non del tutto assenti, in altri maestri del cosiddetto free jazz e delle successive avanguardie, che si sono invece sempre più avvicinate alla musica accademica contemporanea distanziandosi da certe fondamentali influenze peculiari della tradizione jazzistica: un percorso per certi versi opposto a quello inaugurato dai primi esponenti del free, che si erano per lo più mossi in contrapposizione ai criteri della musica colta europea.
In questo senso, Cecil Taylor è considerato uno dei protagonisti del periodo; e per lui, più che per altri, sembrerebbe lecito parlare di svolta netta col passato, manifestandosi esplicitamente nella sua musica quella tensione tra impulso emotivo e complessità strutturale indotta dalla assimilazione delle tendenze della musica contemporanea americana ed europea. Questo, rispetto agli altri protagonisti coevi, potrebbe anche avere una spiegazione biografica. Taylor proveniva da una famiglia del ceto medio nero newyorkese, dove il pianoforte era di casa e in cui veniva incoraggiata l’istruzione musicale in qualsiasi direzione tranne che verso il jazz, ritenuto carriera poco desiderabile. I suoi studi giovanili al New England Conservatory di Boston lo videro certo prendere confidenza con le opere di Bartók, Stravinskij, Schönberg, Berg e Webern, ma gli fu comunque possibile venire in contatto anche col blues e il jazz sfruttando la presenza in quella città di grandi jazzisti come Jaki Byard, Gigi Gryce, Charlie Mariano, Serge Chaloff e Sam Rivers, che si esibivano regolarmente nei club del luogo. Tuttavia, sarebbe erroneo riconoscere in Taylor un maggior distacco dalla tradizione musicale della propria etnia rispetto agli altri innovatori del periodo.

Quel che si avverte nitidamente, se proprio si vuole parlare di «rivoluzione», è lo sganciamento dell’improvvisazione, solistica o collettiva che dir si voglia, dalle limitazioni armoniche imposte dalle usuali strutture formali, più che dalla tradizione in toto: niente più rigidi accordi prestabiliti e relative progressioni proprie della forma blues, delle canzoni, dei rhythm changes su cui erano abituati a operare i boppers e gli hard boppers, secondo schemi in molti casi divenuti solo dei comodi cliché.
Per citare Gianni Morelenbaum Gualberto: «Vi sono stati tempi nei quali si volevano persino trovare affinità fra i Klavierstücke di Stockhausen e il pianismo di Cecil Taylor, senza avvertire che certe pratiche linguistiche potevano ben approdare a risultati esteriormente simili ma provenendo da percorsi, tradizioni, intenzioni, scopi e desideri affatto diversi, agendo in un contesto storico in cui determinate pratiche e determinati processi erano ormai globalmente in contatto fra di loro. Pochi linguaggi hanno saputo come il jazz approfittare del progresso tecnologico e dei mezzi di comunicazione (cresciuti assieme al jazz nel Novecento), basandosi comunque sulla propria tradizione estetica, fornendo così alla cultura americana una chiave di lettura e di affermazione unica, innovativa, originale (…) Una lezione profonda, radicale, che ha coniato un nuovo modo di pensare, peculiarmente americano, di cui, dopo decenni e decenni trascorsi all’ombra dell’oppressiva cultura europea, hanno fatto e fanno uso molti compositori americani di qualsiasi estrazione etnica. Oggi non deve stupire che vi siano compositori africano-americani, da Anthony Davis e George Lewis, a Tyshawn Sorey che conoscano meglio Stravinskij o Boulez di James Brown, e compositori bianchi che abbiano assimilato molto più Muddy Waters che non Schönberg. Il jazz, più di qualsiasi arte africano-americana, ha saputo varcare le più diverse soglie linguistiche, rendendo la diversità e l’unione fra le diversità una pratica indispensabile più ancora che lecita e contribuendo a definire in modo inequivocabile l’identità culturale americana».
Non v’è dubbio che vi sia in Taylor un approccio percussivo alla tastiera in nessun modo considerabile di derivazione accademica, ma piuttosto di chiara impronta afro-americana. C’è molto Ellington nel pianismo di Cecil Taylor, come vi è di Monk e pure di Dave Brubeck riguardo la sua densità armonica (come da ammissione dello stesso pianista). Soprattutto vi è in lui un senso della tradizione che per molto tempo è stato sottovalutato. Le tracce possibili e plausibili dei compositori accademici citati alla fine non sono molto diverse da quelle rintracciabili in Duke Ellington, Charles Mingus e di tante altre figure del jazz più innovativo di quegli anni, secondo le peculiarità di un linguaggio volutamente composito e trasversale al più alto e ineluttabile grado. In effetti, sul piano ritmico manca in Taylor la caratteristica tipica del jazz antecedente, ossia lo swing, sostituito e compensato dinamicamente da un’energia esecutiva che viene continuamente variata di intensità: ma, come giustamente osservava Ekkehard Jost: «Lo swing inteso in senso tradizionale – come elemento ritmico essenziale del jazz – cessa di esistere quando i solisti suonano in tempo libero senza alcuna identità metrica definita». Tutto ciò ha fatto parlare molti e per lungo tempo di «non-jazz» circa la sua musica, ma, parafrasando lo stesso Jost, è solo quando il procedere del ritmo non è determinato né dallo swing né dall’energia che la musica di Taylor può essere avvicinata a quella dell’avanguardia europea.
Potremmo qui andare molto oltre, valutando altri musicisti che hanno abbracciato successivamente l’estetica free o considerando anche quelli delle generazioni successive. Potremmo per esempio citare le esperienze di Sun Ra e i diffusi agganci nella sua musica a elementi della profonda tradizione jazzistica. Le influenze dalle opere di Duke Ellington, di Fats Waller e in particolare di Fletcher Henderson, nella cui band aveva peraltro suonato, sono ampiamente rilevabili nella sua discografia. O ancora, che dire del rinnovato interesse da parte di Henry Threadgill di certe procedure compositive proprie del ragtime o della musica di Jelly Roll Morton (si pensi a dischi come «Rag, Bush And All» del 1989 oppure «Airlore», registrato con il trio Air giusto dieci anni prima)?
In tutti i casi, i rapporti stretti tra tradizione e innovazione nel jazz paiono davvero non essere mai mancati e sono ancora oggi ben presenti, pur nella inevitabile dispersione dovuta al plurimo e sempre più serrato dialogo culturale imposto dagli effetti della globalizzazione.
Riccardo Facchi
