
Stefano Battaglia, sono sempre più i giovani che frequentano i conservatori e i corsi di specializzazione ma, assistendo ai concerti, si ha l’impressione che non siano così curiosi di conoscere la musica e le esecuzioni altrui e che il pubblico stia inesorabilmente invecchiando. Come valutare questo gap nel mondo del jazz?
L’invecchiamento della platea è dovuto al desiderio. La musica ha bisogno di desiderio, come per qualsiasi tipo di nutrimento, sia interiore che organico. La musica è come il cibo, il sesso o la preghiera: è un meta-linguaggio e ci eleva sopra la parola e, anche senza conoscerne vocabolario e sintassi, arriva e pervade e arriva a tutti, indistintamente. La musica oggi è dappertutto ed è tutta lì, quasi sempre gratuita, come se fosse una sorgente inesauribile cui accedere senza alcuna volontà o sforzo. Dunque tutti ricevono di continuo, più o meno consapevolmente, messaggi e informazioni musicali che vengono assorbiti, assimilati e registrati dal sistema percettivo individuale (diverso come tutto da individuo a individuo, s’intende). Ebbene, quando un individuo sta dentro la musica per tutto il giorno o per un certo numero di ore, senza volerlo e magari senza nemmeno accorgersene, la sua fame è sepolta, viene meno il suo desiderio di musica, e lui nemmeno sa il perché. Il silenzio, paradossalmente, sarebbe la cura ideale per riportare la gente nelle sale da concerto e per tornare a essere un bene prezioso. Mezzo secolo di capitalismo sfrenato ci ha insegnato che le cose gratuite non hanno valore: l’acqua può essere sprecata, tanto è gratis, guardare un fiore è gratis quindi possiamo strapparlo, sentire il suono delle onde è gratis, e adesso anche la musica è gratis. E l’uomo non dà più valore a queste cose, e seppellisce tutto questo con le sue spazzature. E in cambio ti promette la rappresentazione del fiore, del mare o della musica, magari in un bel documentario da guardare a casa. Io sarei per l’abolizione della musica da ogni tipo di piattaforma mediatica gratuita, web compreso. Il rito ha bisogno di esclusività, se fosse sempre domenica ci mancherebbe il lunedì. La musica è da sempre un nutrimento: se si lascia una tavola perennemente imbandita di qualsiasi tipo di alimento, cucinato in qualsiasi modo e nello stile di ogni parte del mondo, è sicuro che si assisterà per qualche tempo a un esercito di bulimici impegnati a soddisfare ogni appetito. Non costa nulla. Dopo qualche tempo però assisteremmo all’implosione, all’assenza di desiderio di cibo. Offrire tutto gratis è un modo per non promettere nulla, e soprattutto per non far scegliere, al contrario di quello che si è portati a pensare: perché devo scegliere cosa ascoltare, se posso ascoltare tutto?
E così all’epoca del web l’appassionato ascolta una sola volta mille dischi, anziché ascoltare mille volte lo stesso disco, producendo un tutto teorico che si traduce filosoficamente in un nulla e da un punto di vista pratico in una mancata maturazione del sistema percettivo ed emotivo. Di fatto non ha mai dovuto realmente scegliere cosa ascoltare, e questa mancata responsabilità è un dramma per l’identità. Ma queste sono solo le mie parole e se le porta via il vento, perché la politica culturale è stata già fatta, lasciata in balia del mercato che sembra essere l’unica cosa che interessa alla nostra civiltà. La realtà è che la nuova umanità ascolta musica tutto il giorno al computer, al telefono, nei bar, nei ristoranti, nei supermercati, alla televisione, nelle pubblicità, eccetera. Il più delle volte nemmeno si rende conto di ascoltarla, è abituata a uno standard sonoro-acustico assai basso e quasi sempre gratuito. Generalizzando, non si può pretendere che alla sera queste persone spendano altro denaro per ascoltare un concerto. Se ogni secondo di musica sul web costasse il doppio di un concerto, sono certo che torneremmo ad avere appassionati di musica ai concerti. Io stesso, che cerco di proteggermi in ogni modo dagli orrori del consumismo e dall’overdose di informazioni, fossi in loro spenderei i miei soldi per cancellare tutto ciò che il sistema percettivo è costretto a subire: meglio una passeggiata in montagna. Per non rischiare di sembrare snob, arrivo a dire che persino gli stadi di calcio sono vuoti per lo stesso motivo, dal momento in cui chiunque può quotidianamente guardare dieci partite al giorno di ogni campionato possibile immaginabile.
Non sorprendiamoci che i teatri soffrano! Tutto ci si rovescia addosso a casa, e la gratuità di certi beni è lo specchio di una civiltà capitalistica che ha basato tutto il suo sviluppo sul denaro e il possesso. Per cui un giovane pensa di «non pagare alcun prezzo» all’altare della gratuità, anzi pensa di essere furbo a possedere qualcosa che «non gli è costato nulla». E’ portato a considerare che la cosa importante è «non tirar fuori soldi» anziché curare e risparmiare il Tempo e lo Spazio. E’ come volere il tavolo in noce in casa e pretendere di salvare anche l’albero con cui lo si costruisce. Si sceglie il tavolo? Benissimo, l’albero non c’è più. Ma almeno il tavolo andrebbe pagato, diamine, perché così assomiglierebbe a una scelta reale. Se invece anche il tavolo fosse gratis sarebbe troppo comodo, e per gli alberi non vedrei un grande futuro! All’ipocrisia della finta gratuità si paga un prezzo assai più alto e inestimabile, sintetizzabile in tre parole: libertà, identità e, appunto, desiderio. Che produce automaticamente musica senza libertà, senza identità e priva di desiderio. E’ la tragedia di media e web.
Inversamente proporzionale all’invecchiamento delle platee, la musica jazz (grazie a interconnessioni tecnico-espressive con il rock, l’electropop, il rap, i dj e altro ancora) dialoga sempre più strettamente all’interno di progetti musicali contemporanei. Quale futuro vedi per il jazz? Arricchendosi in maniera idiomatica e inglobando di tutto, comunque una sua innata peculiarità, rischia adesso di perdere la sua identità o dimostra di essere sempre più vivo?
È sempre stato così e lo sarà per sempre. Si possono fermare il tempo o un corso d’acqua? Proviamo: Ecco che l’acqua si devia, penetra nel terreno e salta fuori da un’altra parte, satura di minerali diversi. Il fiume è la musica, non il jazz. Il jazz è una delle sue tante spontanee deviazioni. È la natura delle cose, tutto si trasforma. Sono più in pena per i ghiacciai, i leoni o il popolo siriano che per il jazz. La musica è viva perché tutti abbiamo bisogno della musica, dall’alba dell’uomo e per sempre, e se anche dovesse scomparire l’ultimo musicista impareremmo ad ascoltare gli uccelli o il vento, o insegneremo il contrappunto ai droni. Questi argomenti sono rischiosi perché basati su una parola, il jazz, che non ha senso oppure ha significati diversi e soggettivi. Non ho particolarmente a cuore né il passato né il futuro della parola jazz, mi sembra un’argomento di sessant’anni fa, da quando cioè il jazz si è disintegrato centrifugo in mille musiche diverse. Se domani abolissero questa parola, proverei per qualche ora un leggero e romantico disagio ma il mondo andrebbe avanti lo stesso. E’ un’opportunità di mercato: a nessun musicista interessa dare un nome a ciò che fa. E’ come se io facessi cento figli e, assomigliando tutti un poco a me, magari una leggera similitudine, li chiamassi tutti Stefano, come me. Che senso ha?
Ogni brano, ogni improvvisazione è parte di noi, e ognuna avrà una propria ispirazione, diverso titolo, ragioni diverse, influenze molteplici. Perché qualcuno che mi è estraneo deve per forza darle un nome? Ciò che conta è che la musica resta, e per fortuna il jazz ha sviluppato tutte le sue tradizioni nell’era del disco, per cui tutti i suoi capolavori sono lì e non ce li leva nessuno. Sta a noi decidere se quella tradizione è anche (solo?) un repertorio e uno (uno?) stile da rappresentare nei secoli dei secoli o se è una musica in continuo divenire, anche indipendente da elementi idiomatici caratteristici. Le contaminazioni non sono una realtà d’oggi, e come in qualsiasi linguaggio il jazz ha prodotto lungo il suo sviluppo un suo classicismo, un suo romanticismo, un suo modernismo e così via. Ma la parola in sé è solo evocativa, come una madeleine proustiana. Come quando si dice musica classica e, con essa, si pretende di mettere insieme settecento anni di tradizioni e stili completamente diversi. Non sono parole vuote, beninteso, ma il simulacro di qualcosa che semplicemente non esiste perché non ha confini oggettivi, troppo grande e vasto da contenere, o non c’è più perché si è trasformato in altro, o ancora perché non è possibile cristallizzare, fermare. Tutto cambia ed è in divenire. Ed è giusto così, altrimenti non ci sarebbe stato il jazz e neanche la musica barocca! Ancora una volta la scelta è tra rappresentazione e manifestazione: del jazz a me interessa la possibilità di manifestare parti essenziali dell’uomo. Com’è accaduto a Armstrong e a Parker, ho l’occasione di vivere il mio presente, veicolare la mia passione per la musica e i miei talenti, qui e ora. «Qui» inteso come il luogo in cui mi è capitato di nascere e vivere e come ogni luogo in cui mi capita di esprimermi; «ora» inteso come epoca, dunque diversa da quella epifanica del jazz ma anche come «in questo preciso istante». Penso che nella cosiddetta musica classica o musica di repertorio, come anche in certo teatro, la rappresentazione abbia un valore esistenziale e sempre lo avrà: ascoltare una invenzione a due voci o assistere a una tragedia shakespeariana regala significato e appartenenza alla parte migliore di una civiltà che lascia traccia di sé attraverso un testo. Testo che vive solo se rappresentato nel tempo.
Nel jazz il testo esiste già rappresentato nel momento stesso della sua manifestazione. Proprio perché inventato nel momento, il jazz rappresentato e dunque replicato come testo estrapolato dal qui e ora, lo considero assai meno avvincente e convincente se confrontato a una partitura o a un testo, che sia Bach o Shakespeare, perché svuotato dell’urgenza espressiva del suo esecutore-autore-interprete. Non credo che sia una musica di repertorio, nonostante il suo repertorio ce l’abbia eccome. Questa è solo un’ opinione, naturalmente, ma vediamo bene come la rappresentazione del jazz sia più che mai in auge, con un suo circuito internazionale piuttosto vivo, un repertorio ampio, popolare (le songs di Broadway e Hollywood) e specifico (gli autori di jazz), e persino, a chi interessa, con la possibilità di riascoltare le improvvisazioni degli eroi della tradizione mediante trascrizioni e assimilazione. E mi sembra che in molti si stiano dedicando a questo: che la si chiami offensivamente imitazione, banalmente cover jazz o più seriosamente musica classica afro-americana poco importa, il risultato è comunque la rappresentazione: a volte sublime, altre mediocre. Non ho mai avuto a cuore questo tipo di prassi e ignoro se sono lontanamente un musicista di jazz: a me interessano la musica e il presente, dunque la manifestazione.
La musica è sempre esistita e sempre esisterà e il presente è l’unica cosa che possiamo vivere. E’ un’attitudine da riconquistare, specie per un improvvisatore, nell’era dove tutti tendono a vivere la vita di qualcun altro che sta in un altro luogo, in un altro tempo (il passato). Quello che si può dire riguardo al jazz in senso stretto, idiomatico, è che una parte della comunità afro-americana durante il modernismo ha scelto di fermarsi per costruire una musica classica afroamericana. La cosa è facilmente comprensibile e persino condivisibile, ma solo in astratto: in pratica, dunque artisticamente parlando, è stata una catastrofe, perché il jazz è una musica hic et nunc, nata a braccetto con il disco che sembra fatto apposta
per fermare le improvvisazioni e cristallizzarle in eterno: le sue «partiture classiche» sono già state definitivamente scolpite, «manifestate» dai loro stessi autori-improvvisatori, e non c’è necessità di riletture di tipo rappresentativo. E’ ovvio che chi suona Armstrong oggi lo suona tecnicamente meglio dello stesso Armstrong, avendolo studiato al college magari per dieci anni: ma che senso ha? Che ne è del significato? Dell’urgenza espressiva? Dei valori profondi dell’improvvisazione, legata indissolubilmente al presente individuale, all’interno di un contesto geo-socio-culturale unico e irripetibile? Negli ultimi anni, al jazz è mancato proprio il contributo propulsivo, la spinta della comunità afro-americana, perché mentre i giovani jazzisti al college studiavano a memoria gli assolo dei nonni, chi tra loro aveva urgenza espressiva ha scelto altri linguaggi e non il jazz per esprimerla. Il jazz sembra essere diventato per loro il simbolo di un’altra classe sociale già inserita, non certo la voce di chi ancora deve autoaffermarsi, ma quella delle università e del doppiopetto, un po’ come è successo da noi nello iato creatosi dal cliché musica classica-aristocrazia e rock-jazz-democrazia. Il risultato è che espressivamente Clifford Brown suona assai più potente di un Wynton Marsalis e sintatticamente oggi suona ancora avanguardia un «classico» come Roscoe Mitchell, nonostante l’Aacm abbia più di quarant’anni! Ma questo perché ciò che suonano o suonavano se lo sono inventato loro, e questa verità è l’unica cosa che mi interessa tra ciò che si muove sotto la parola jazz.

Le tue radici stilistiche affondano nel fertile terreno della musica classica. Hai avuto un esordio precocissimo e pluripremiato come pianista concertista, esibendoti in tutta Europa. Altrettanto precocemente hai iniziato a dedicarti all’improvvisazione di matrice jazzistica. Com’è scattata questa passione? È stata un’urgenza che hai accolto sentendo esaurirsi lo spazio espressivo che avevi percorso fino a quel momento?
In realtà ho praticato l’improvvisazione fin da subito, dall’infanzia. Il jazz è arrivato molti anni dopo, verso i quattordici anni, in una fase già avanzata dei miei regolari studi pianistici. L’improvvisazione al pianoforte fu da subito uno scrigno contenente una doppia rivelazione: la musica che si rivela attraverso la scoperta del suono e, al contempo, il sé che si rivela attraverso la musica e i suoni. Col senno di poi, nient’altro che una pratica meditativa o una unconscious consciousness dell’infanzia. Fin da subito il jazz fu lo spazio privilegiato attraverso cui esprimermi, e il pianoforte lo strumento ideale per rivelarmi alla musica e a me stesso. Senza averne alcuna coscienza suonavo tutto il giorno, e le ore di studio disciplinato erano di certo assai inferiori a quelle che dedicavo a «giocare» con il piano.
In breve si formò una sorta di stanza magica, un nuovo utero nel quale mi sentivo protetto e allo stesso tempo esploratore. Sperimentavo la mia vita emotiva nel suono, e attraverso il suono imparavo a essere. Era un dialogo complementare tra la disciplina dedicata all’interpretazione, ciò che già esiste e che va rispettato nei dettagli, e ciò che ancora non esiste, è misterioso e in divenire. Una mano tesa verso le tradizioni e i linguaggi, l’altra sprofondata nell’esplorazione di sé. Come interprete, tutti gli sforzi erano tesi a dar luce alla creatività del compositore, alla forme perfette, alla sintassi precisa, ai codici di scrittura narrativamente esaurienti, talvolta sofisticati: dunque di totale annullamento dell’ego a favore della partitura, che doveva bastare a sé e non aveva bisogno di personali interpretazioni. Per contro il jazz, specie quello così contaminato e deflagrante degli anni Settanta con il quale sono cresciuto, fungeva da grande equilibratore della mia formazione, in naturale connessione con le mie ore di sperimentazione infantile, l’espansione del mio personale universo sonoro. Era il luogo giusto al momento giusto, semplicemente l’unica musica che consentiva di immaginare la creatività come un processo individuale in divenire. Ancora oggi questa funzione è la caratteristica che più mi interessa del jazz, tanto che fatico a considerarmi un jazzista in senso idiomatico.
La conoscenza del linguaggio del jazz è arrivata più tardi, per la curiosità di sapere da dove arrivassero i miei eroi di quegli anni e quali fossero le tradizioni che li avevano influenzati, in una sorta di percorso a ritroso. Tecnicamente l’iniziazione è avvenuta nel 1978, quando acquistai due dischi di piano solo pur non avendo la benché minima idea di chi fossero gli esecutori e soddisfacendo così la mia ossessiva ingordigia di musica per pianoforte. Si trattava di «Facing You» di Keith Jarrett e di «Open, To Love» di Paul Bley: furono sconvolgenti e decisivi a ogni livello, una vera e propria iniziazione, per l’appunto! Ancora oggi rimangono due miei punti di riferimento, dopo più di trent’anni e non so quante migliaia di ore di ascolto di musica di ogni genere.

Accanto alla tua attività di musicista sei riconosciuto a livello internazionale come docente del Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale presso Siena e come caposcuola di tecnica dell’improvvisazione. Nei tuoi corsi e seminari, che svolgi in tutta Italia oltre che a Siena, adotti una disciplina rigorosa che abbraccia conoscenze quali la tecnica strumentale, la fisica acustica, l’introspezione psichica, la rappresentazione emozionale, la gestualità, la creatività che si intreccia con la razionalità.
Amo condividere la ricerca, specie quando c’è passione e talento. Mi sorprende sempre l’essere considerato da molti un maestro, perché in realtà ho sempre la sensazione di essere io a imparare molto, ogni volta che ascolto i miei allievi e metto le mani sullo strumento assieme a loro. Il discorso sull’improvvisazione è molto serio e merita una lunga riflessione. È una prassi antica come il mondo: eppure tutti i linguaggi che ne fanno uso tendono a volerla «possedere», imponendo riferimenti idiomatici e stili propri, sconfiggendo l’ideale valore meta-linguistico della musica attraverso il quale individui di provenienza e radici culturali diverse possono comprendersi a un livello profondo. Invece abbiamo un’incomunicabilità tra gli stili e le stagioni, addirittura all’interno di uno stesso linguaggio; è una sconfitta ma anche una riflessione che la comunità della musica dovrebbe pur fare, prima o poi. Altrimenti la sua ambizione di poter «parlare a tutti» rimarrà ideale. In estrema sintesi, il nucleo del problema si gioca attorno a queste due parole: manifestazione e rappresentazione.
Se la rappresentazione ha bisogno di idiomi, modelli, stili, precisi codici e, inevitabilmente, un repertorio, la manifestazione musicale dovrebbe invece poter parlare a tutti liberamente e a tutti dire qualcosa – il suo cosa, indipendentemente da come lo dica – attraverso qualsiasi stile e linguaggio. Tornando al metodo, si tratta dunque di costruire una sintassi precisa, che disciplini lo studio e la forma e che lasci non solo totale libertà espressiva ed estetica ma anche idiomatico-stilistica. Generalmente i maestri tendono ad appartenere a questa o a quella tradizione e, automaticamente, a riverberarsi e riverberare, specchiarsi e specchiare, proiettando sugli studenti quelle che sono le loro passioni e abilità attraverso il normale transfert allievo-maestro. Se entrambi non sono più che attenti si compie una piccola tragedia pedagogica perché l’individuo, come dice la parola, non-si-può -dividere. E, come in ogni tipo di relazione interpersonale, l’identificazione può essere veicolo di una maturazione positiva (stima, ammirazione, emulazione) e negativa (competizione, invidia, gelosia): in entrambi i casi per un artista, cioè per chi vuole manifestare il proprio sé individuale e unico attraverso un’arte, essa è sempre inevitabilmente pericolosa se non dannosa. Inesorabilmente, direi.
Dunque il maestro illuminato è colui che si mette di lato e non al centro, capisce su che cosa e come sia più utile focalizzare il lavoro per (e non sul) lo studente, nei diversi periodi e lungo le diverse fasi che attraversa, in base ai suoi specifici talenti, alle sue caratteristiche psicofisiche, al suo universo emotivo e alla sua cultura musicale. Un lavoro difficile e faticoso: dunque è raro vederlo attuare. Servono molta passione, determinazione, tanta pazienza e soprattutto uno spazio, non solo in senso fisico. Preferisco per questo sentirmi autonomo e coordinare dei laboratori di ricerca piuttosto che entrare a insegnare in un conservatorio. Un luogo di studio e sperimentazione completamente autonomo anche rispetto alle logiche della professione, così piene di tranelli, confusione e mediocrità. È necessario crearlo prima di tutto dentro di sé, un tale spazio, e poi proteggerlo. Ecco: i miei laboratori, attivi dal 1996, sono un luogo protetto, un necessario bilanciamento ai possibili disastri della didattica. L’individuo è tridimensionale: ha un corpo, una mente e uno spirito. La musica, il suo possibile veicolo espressivo, per sprigionare tutta la sua potenza deve avere la stessa tridimensionalità. Il triangolo perfetto, così difficile da costruire, è formato dall’ethos («Perché suono? Che cosa cerco da questa esperienza?») dal logos («Che cosa suono? Che cos’è carne e sangue della mia musica? Quali sono i linguaggi che mi piacciono, che voglio imparare, gli strumenti e le tecniche che voglio acquisire per esprimermi?») e dal pathos («Come lo suono? Quanto di me, del mio corpo, della mia mente e del mio spirito, riesce a passare attraverso la musica?»).
Qualsiasi accademia è costretta a ottimizzare e a non soffermarsi su queste riflessioni individuali, che sono la ragione d’essere di un musicista – e della musica che suona – e la ragione per cui la musica viene suonata e, possibilmente, ascoltata. La scuola, invece, sceglie per l’individuo, si sostituisce a esso attraverso un suo ethos proprio e astratto, un logos di appartenenza che ha un propria sintassi e un consequenziale repertorio, un programma unificante che in potenza possa funzionare su tutti indistintamente, come se tutti avessero dunque lo stesso corpo, la stessa mente, e, ancor più grave, lo stesso spirito. La scuola non ha sempre tempo di occuparsi dell’individuo, dell’interpersonale: dunque tralascia sempre qualcosa, facilmente riempiendo la mente di informazioni, talvolta – non sempre bene – lavorando sul corpo (le tecniche funzionano se applicate al corpo individuale, e non a un corpo unico astratto) ma quasi sempre lasciando sofferente lo spirito, la crescita emotiva, le motivazioni, i talenti specifici individuali, tutti gli aspetti decisivi su un livello di esecuzione. Come se si scegliesse, per opportunità, di far provare un sacco di vestiti all’individuo, nella speranza che almeno uno di questi gli possa andar bene, così che non ci sia bisogno di occuparsi di ciò che sta dentro a quel vestito. Viene quindi formato un plotone di professionisti della musica, dimenticando che la società non ha bisogno di quei numeri mentre avrebbe tanto bisogno di persone capaci di esprimersi gioiosamente, per restituire alla musica e al musicista un ruolo decisivo all’interno della società: quello di dar voce alle infinite individualità che compongono l’espressione di una civiltà culturale. Dunque la manifestazione di una civiltà, non la sua rappresentazione.
Va detto che per circa trecento anni questo sistema ha comunque funzionato nella cosiddetta musica classica occidentale, trattandosi di un linguaggio con un codice di scrittura abbastanza sofisticato e preciso. E, in ovvia assenza di registrazioni, la funzione degli interpreti era quella eroica di salvaguardia: portare su un’ideale arca le zone più sublimi dell’espressione di una civiltà. Da quando poi la scrittura si è modificata ulteriormente nel senso della complessità e delle diversità, diciamo dal dopoguerra in poi, persino la musica di natura accademica soffre di continuità e di qualità interpretative. Figuriamoci il jazz, che nasce nel momento, che si nutre di improvvisazione e dunque detesta la rappresentazione, la replica, la serialità. Una cosa muore dopo che si è detta, e domani sarà diversa. Dunque il gap di cui parli è un’effetto inesorabile del tentativo di rappresentazione del jazz, tentativo più opportuno per l’accademia che non per il jazz in sé come linguaggio. La scuola moderna ha bisogno del jazz perché crede così di pagare il prezzo del «modernismo», per errori commessi cent’anni fa, quando ha cessato la sua opera di accompagnamento dell’espansione del linguaggio (non importa se evoluzione o involuzione, secondo i punti di vista ideologici, comunque cambiamento), e di rivolgersi univocamente verso il repertorio di tradizione. Repertorio di cui ha bisogno per poter divulgare il linguaggio che si propone di insegnare. Il punto è che il jazz non è una musica di repertorio, sebbene abbia ovviamente le sue molteplici tradizioni, un suo classicismo, un suo modernismo, persino un suo romanticismo. Ma, se tutto questo viene svilito in un repertorio, lo spirito stesso del jazz muore, e questo è un nodo inestricabile nel rapporto tra jazz e accademie.
L’improvvisazione, con i suoi parametri costitutivi – timbro, ritmo, melodia, armonia – e quelli espressivi ed evocativi, è un mezzo espressivo completo?
Direi potenzialmente completo, sì. Che è già molto ambizioso, perché vorrebbe dire che anche l’individuo che si esprime lo è. Io mi limiterei a dire che è un mezzo espressivo totalizzante, quindi esprime in potenza tutto l’individuo e non solo parti di esso: ogni sua zona è messa in vibrazione e veicolata. Ma se l’individuo è chiuso, o sviluppato parzialmente, ecco che l’oggetto della sua espressione è consequenzialmente involuto e limitato. Infatti esiste la sublime improvvisazione ma anche la pessima improvvisazione. L’improvvisazione rimane comunque il veicolo privilegiato per la verità individuale presente: ci sei tu e il tuo strumento e ci sei adesso, e con lui devi raccontare qualcosa che sia unico come la tua identità.
C’è la tua manifestazione, e non una qualche rappresentazione più o meno veritiera di te. E, a sua volta, la musica è un’entità unica e indivisibile, qualsiasi sia il vestito (il linguaggio, lo stile) che la riveste; con un suo corpo, una sua mente, un suo spirito. E i parametri che citi sono la sua voce, la sua carne il suo sangue, la sua materia costituente. Io sono sempre più interessato alla musica in questo esclusivo senso, come manifestazione, rivelazione e svelamento, come possibile canale espressivo universale, senza alcuna volontà di appartenere ad alcuna comunità precisa. E l’improvvisazione, quanto e più della composizione, è certo la prassi privilegiata per creare musica senza alcun tipo di barriere idiomatico-stilistiche.
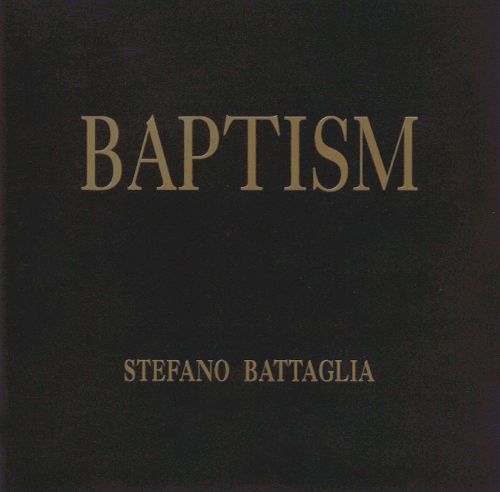
Come musicista il tuo bagaglio di esperienze sembra essere inesauribile. La tua ricerca in piano solo è testimoniata da una moltitudine di concerti generosi, tanto coinvolgenti quanto complessi e introspettivi le cui radici affondano in un humus culturale fertilissimo intrecciato a una cifra espressiva molto riconoscibile. Una mezza dozzina di album raccolgono questo percorso e due mi hanno colpito in modo particolare. Uno è «Signum» del 1999 ed è tutto di brani improvvisati, quasi una seduta analitica che scandaglia nel più profondo il tuo mondo interiore; l’altro è «Baptism» del 1993, omaggio nato sul fake book di pianisti jazz emblematici, tra cui Lennie Tristano e Bill Evans.
Sono due lavori assai diversi: il primo, per il quale ho ricevuto un premio dalla stampa spagnola, è della fine degli anni Novanta e fa parte di un progetto ambizioso di registrazione nelle pievi romaniche, con una qualità particolare della ripresa sonora. Erano sei lavori e, dopo l’uscita dei primi due («Il Cerchio Interno» e «Signum»), purtroppo l’etichetta è implosa, non sopravvivendo alla crisi del cd. Invece «Baptism» è stato registrato durante le pause di una seduta in studio con Lee Konitz, con il quale ho collaborato a lungo negli anni Novanta, in duo e in gruppo. Anche quelle sono tutte libere improvvisazioni, tabula rasa, appunto, ma la presenza in studio di Lee fu evidentemente un’influenza pesante a livello inconscio. Quando finivo un pezzo e alzavo gli occhi verso la regia lo scorgevo impassibile, con quella sua espressione imperscrutabile dietro gli occhiali, e pensavo che fosse un disastro, mentre poi mi arrivava dalla cuffia qualche suo commento lapidario e confortante… Perciò c’è una dedica esplicita a Tristano, uno dei miei eroi della tradizione. «Baptism» è stato ristampato in Giappone e recentemente, durante un tour, l’ho scoperto essere un disco di culto in Corea e in Giappone. Decine di persone sono venute a farselo autografare dopo i concerti e ne ero sbalordito, trattandosi di un vecchio lavoro che avevo rimosso. In Italia immagino sia scomparso o difficilmente rintracciabile, almeno credo.
Il piano solo è il mio ambiente privilegiato, quello più naturale. In fondo è la stessa condizione di quando avevo cinque anni… Posso esprimermi liberamente senza alcun tipo di materiale di partenza, nemmeno formale. Questo tipo di performance la chiamo tabula rasa, appunto: credo sia l’esperienza più esaltante per un improvvisatore. Lo schermo è bianco e provo a raccontare una storia, qui e adesso. Quando, per qualche ragione, non mi sento completamente a mio agio (lo strumento, la sala) allora ricorro a delle strutture morfologiche o evocative nelle quali rimango comunque libero di trovare la musica nel momento presente ma con una forma extra-musicale prevista, disciplinata. Come una traccia che mi impone una certa azione, utile soprattutto quando capita di dare concerti in condivisione con altri gruppi e, dunque, si deve tener conto di opportune limitazioni nella durata della performance. Altrimenti mi può capitare di suonare anche tre ore di fila!
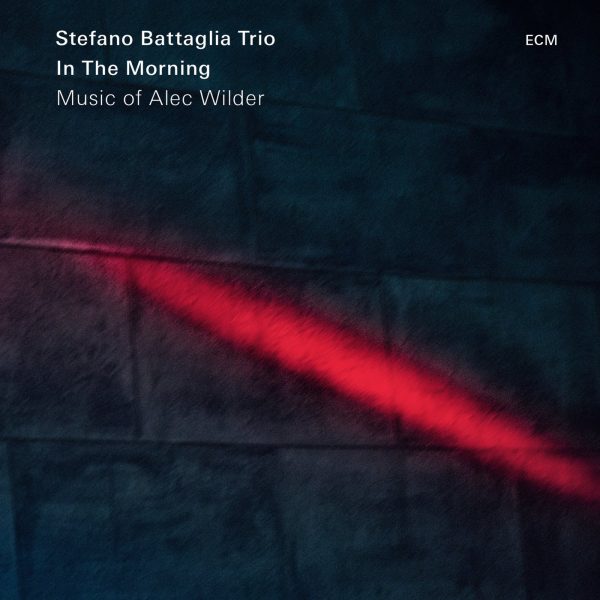
Da una decina di anni collabori con l’etichetta Ecm, prestigiosa casa discografica tedesca incentrata sulla musica contemporanea, e per la quale hai fin qui inciso sei album densi e ispirati. L’uscita dell’album dal vivo «In The Morning», in cui proponi brani di Alec Wilder, segna il tuo ritorno all’interpretazione di standard americani, dopo gli album degli anni Novanta dedicati a Bill Evans. Quanto continua a essere importante, oggigiorno, proporre standard?
Da quando si suona jazz in tutto il mondo, standard è una parola oramai un po’ vuota e che rimane viva per pura pigra inerzia, magari per evocare qualche capolavoro della tradizione. La usavano gli americani cinquant’anni fa per definire un repertorio, per lo più di canzoni dei musical di Broadway e Hollywood con i quali erano cresciuti nell’età dell’oro della radio e del cinema. Ma il jazz non può , non deve essere musica di repertorio. La parola in sé implica una naturalezza, una semplicità, un’abitudine. Oggi, al contrario, non c’è nulla di più difficile che suonare con significato e intensità una canzone di Broadway degli anni Venti, riuscendo a essere espressivo e originale: immaginare che per un musicista nato negli anni Novanta a Seoul sia «standard» una canzone di Porter del 1929 o anche un brano di Parker del 1947 è una irreale forzatura, esattamente come pensare che Haydn sia «standard» per uno studente di Kolkata. C’è una sorta di arroganza della globalizzazione, che pretende di affermare che migliaia di anni di diverse civiltà culturali, con radici profonde e tra di loro separate e autonome, vengano annullati da meno di un secolo di voli intercontinentali e da un ventennio di internet. Ci piacciono ancora quelle canzoni? Se sì, quali? Tutte? Affrontiamole, impariamo i loro contenuti profondi, musicali e letterari, e lavoriamoci dall’interno con serietà e onestà, sapendo di non essere né a Chicago negli anni Trenta né a New York negli anni Sessanta: dunque considerando che quel lavoro è stato già fatto in modo sublime da decine di interpreti di quel tempo, da chi in quegli anni cresceva con le radio che passavano quella musica tutto il giorno. Di quel mondo ci è rimasto davvero poco. E questo ci suggerisce di provare a fare qualcosa che ancora non è stato fatto, così da portare avanti un discorso specifico anziché ripetere (un po’ meglio o un po’ peggio, non conta) le cose già fatte da altri. Quante canzoni ci sono nel mondo? Quanti standard nuovi possiamo regalare al futuro della musica, per i musicisti del 2500? E, naturalmente, non è importante cosa fai ma come lo fai.
Giusto per ricordare quanto debba essere profondo e totalizzante il lavoro di interpretazione degli standard, ricordo bene cosa si diceva a proposito all’inizio degli anni Ottanta: dopo Bill Evans e Miles non si può far più niente di meglio, con queste canzoni. Poi è arrivato Keith Jarrett con il suo trio e ci ha detto: ma le avete mai sentite suonate così? La sua scelta gli ha regalato riconoscimenti e popolarità e ci ha donato uno dei più grandi improvvisatori e interpreti del Novecento. Ma pochi ricordano che, contemporaneamente, ci ha sottratto uno dei più originali compositori del jazz di oggi, tanta è stata totalizzante la sua concentrazione su quel repertorio. E, pur nel godimento generale, un prezzo lo abbiamo pagato tutti: noi e lui. A noi mancano quarant’anni di sue composizioni, a lui la possibilità di espandersi ulteriormente come compositore attraverso nuove collaborazioni e possibili sodalizi. E, a eccezione degli eterni Rollins, Haynes e Konitz, quella di Jarrett, Peacock e DeJohnette, assieme a Shorter, potrebbe essere in effetti l’ultima generazione che si è abbeverata alla sorgente pura del jazz avendo suonato con Blakey, Miles, Evans.
Chiunque sia venuto dopo dà la sensazione di «poterlo fare» ma non sembra una reale esigenza espressiva: certe volte è amore per la tradizione, altre volte mancanza di coraggio o, semmai, il desiderio di appartenere a una comunità, di partecipare a un classicismo: «Ce la posso fare, lo faccio quindi esisto, sono nel fiume della tradizione e faccio parte di questa comunità». La sensazione, dopo quasi un secolo, è che accanto a molte perle vi siano molti standard sopravvalutati, molte di quelle canzoni sono estremamente semplici, alcune mediocri, ed è sufficiente ascoltarne una decina di buone versioni, non mille. Proprio per questo, invece, molto Hoagy Carmichael e quasi tutto Alec Wilder sarebbero da riscoprire e suonare di più. Molto raro, con loro, incappare in un testo stupido o in una melodia banale. L’impianto armonico è sempre sofisticato e, anche quando la progressione armonica è standard, le orchestrazioni sono sempre sorprendenti. Non essendo americano, mi sono deciso ad affrontare seriamente la tradizione di Wilder proprio perché ero colpito dai suoi contenuti profondi e avevo la mente libera da versioni di riferimento. E ho deciso di affrontare concerti e registrazioni proprio intravedendo un vuoto interpretativo attorno alla sua opera.
Appunto. Il poliedrico mondo musicale di Alec Wilder (1907-1980) è stato spesso sottovalutato. Era un compositore preparato e arguto, instancabile viaggiatore e appassionato della natura, uomo erudito e curioso. Ha lasciato un vastissimo catalogo, patrimonio della cultura americana, costituito da musica da camera e operistica, musica per bambini, partiture per film sperimentali e documentari, per il teatro e il balletto, per la trasposizione in musica di opere letterarie e poetiche, solo per citare alcuni lavori. Fin dal 2000 ne studi il repertorio. Come nasce il tuo interesse per Wilder?
Si parla sempre della «scuola dei cinque» grandi del musical: Gershwin, Berlin, Porter, Kern e la coppia Rodgers-Hart. Per ragioni misteriose, fors’anche pigrizia, altri autori altrettanto meritevoli sono fuori repertorio. Proprio per questo, fino ai primi anni Novanta conoscevo solo poche canzoni di Wilder, per lo più quelle cantate da Frank Sinatra (avevo il suo «Conducts Wilder», che in copertina vede Sinatra a dirigere l’orchestra) e – in versione strumentale – quelle intense di Jarrett di Blackberry Winter (con Haden e Motian) e Moon And Sand (con Peacock e DeJohnette). Come esecutore conoscevo e suonavo I’ll Be Around nei gruppi di Tiziana Ghiglioni già negli anni Ottanta: era uno dei suoi brani preferiti. Ma fu poi per merito del musicologo Marcello Piras, appassionato studioso della musica americana, che a metà degli anni Novanta incontrai l’universo complesso di Wilder: Piras mi propose di interpretare in prima europea le sue sonate per corno e pianoforte. Da lì in poi fu una scoperta dopo l’altra, culminata con due incontri che mi hanno persuaso definitivamente a pensare al lavoro anche in maniera produttiva, non solo di ricerca: prima con Judy Bell della Richmond Organization, grande amica di Wilder, Bill Evans e Stan Getz, che da sempre gestisce il catalogo delle opere di Alec Wilder e che venne ad ascoltare il mio piano solo alla Steinway Hall di New York con un grande cappello bianco a tese larghe. Poi quello con Stefano Zenni, anche lui infaticabile studioso e divulgatore di musica, nel suo studio di Prato, quando gli confidai l’intenzione di cominciare un’operazione di rilettura e registrazione dell’opera wilderiana. Verso il 2004 ho iniziato a suonare la musica di Wilder anche in concerto e, dopo più di dieci anni, mi sento pronto a registrarla avendo certezza che attraverso questo materiale posso esprimermi compiutamente come se fosse «mio»: non sento più alcuna distanza tra un mio brano e uno dei brani di Wilder che suono. È la fase più importante ed esaltante: quella espressiva.
Oggi credo di conoscere profondamente la sua musica, so di aver lavorato trasversalmente su tutta la sua opera e mi sono infine concentrato su più di sessanta songs tra le oltre cento affrontate, che rappresentano un repertorio vastissimo e paradigmatico della civiltà multiculturale americana del Novecento. Dopo un processo così lungo di identificazione e de-identificazione, attraverso il quale molte canzoni sono ora praticamente riscritte, posso dire che considero Alec Wilder uno dei più grandi compositori americani di tutti i tempi: insieme a Hoagy Carmichael è il mio songwriter preferito.
«In The Morning» è la registrazione del concerto dell’aprile 2014 al Teatro Vittoria di Torino e fa parte di un progetto più ampio nato con la Alec Wilder Fondation, la Patterson University, Torino Jazz Festival ed Ecm. Il programma comprende le art songs di Wilder. Come hai scelto questi brani?
Wilder ha archiviato come art songs i suoi lavori su testi poetici preesistenti, mettendo in musica poeti tardo-romantici e contemporanei come James Stephens, Reginald Lawrence, Edgar Allan Poe, Haverlin, Etherton e Brennan, Laura Bennett e Christina Rossetti, Linn Walker e Carl Sandburg, ma anche Patrick Pearse e un gigante come Tennessee Williams. Trattandosi di poesie già esistenti la forma non è la classica forma canzone, ma una forma più liederistica, libera e aperta. Nessun gruppo di jazz ha mai suonato quei brani, per ora interpretati solo da cantanti e strumentisti classici, sebbene vi siano elementi idiomatici tipicamente «americani» e certamente assai influenzati dal jazz. Istintivamente è emerso, negli arrangiamenti che ho scelto per queste songs, il mio amore per il progressive britannico, forse il periodo più straordinario per la sperimentazione sulla forma-canzone: brani lunghi, cambi di tempo, modulazioni improvvise, spunti visionari sia nei testi che nelle scelte musicali, dialogo tra sviluppi strumentali e parti cantate. Specialmente io e Roberto Dani siamo molto legati ai primi album dei Genesis e dei King Crimson, e antiche passioni sono riemerse durante il lavoro sulle songs poetiche di Wilder. Le art songs sono un’orbita importantissima dell’universo Wilder, e anche un tipo di prassi virtuosa che di tanto in tanto i musicisti e i poeti attuano per collegare i due mondi.

Mi era già successo con Pasolini e Modugno di Cosa sono le nuvole: la trovo un’arte sublime, sia vista dalla parte del compositore, sia del poeta. Basti pensare a Goethe e ai lieder di Schubert e Dallapiccola. Anch’io, dopo i lavori strumentali sui Sonetti a Orfeo di Rilke e sui versi di Rumi e Juan de la Cruz, da poco ho finito di mettere in musica i Four Quartets di T.S. Eliot e, quest’estate, ho finalmente trovato la giusta voce per realizzarli: Theo Bleckmann, la cui intensità incarna perfettamente lo spirito decadente e sublime delle visioni eliotiane. I nostri concerti monografici attorno alla figura di Wilder sono sempre diversi anche nelle scelte dei brani, sfruttano il dialogo tra canzoni popolari (il cui testo, oltre la musica, spesso è dello stesso Wilder) e le art songs. Sono più di sessanta le canzoni che abbiamo rielaborato: e come sempre, una volta stabilito che l’album debba essere singolo e non doppio, è Manfred Eicher a scegliere i brani e la nuova drammaturgia del disco. Lui ha un senso della forma speciale, per me sempre sorprendente: non c’è mai stato un disco in cui le mie previsioni coincidessero con le scelte definitive, e sono felice di sentire totale fiducia nei suoi confronti. In effetti la figura del produttore sta scomparendo nel jazz. Tendono a fare tutto i musicisti, che però hanno il difetto di essere così «dentro», legati a doppio nodo al «micro», con ciò che hanno suonato, che a volte il «fuori», cioè la forma drammaturgica da costruire per una buona narrazione dell’album, ovvero il «macro», finisce per sfuggire o essere distorto da dettagli risibili. Manfred è forse l’ultimo produttore in circolazione, e in assoluto uno dei più grandi della storia del disco. Io faccio sempre fatica a compilare le scalette, a prevedere, ad avere una forma a priori. Persino riascoltare e scegliere, da qualche tempo, mi crea un disagio talvolta invalicabile. La presenza di Manfred per me è salvifica! Nei concerti invece è sempre Salvatore che ha le idee migliori per creare l’ordine.

Dopo «The River Of Anyder» del 2011 e «Songways» del 2013 è il terzo disco che incidi per Ecm in trio con Salvatore Maiore al contrabbasso e Roberto Dani alla batteria, con i quali suoni da molti anni. Il risultato è sontuoso e potente per l’immediato ed esclusivo interplay, che crea profonda complicità con il pubblico risonante.
Sì, in musica mi piacciono i sodalizi. Gli incontri sporadici, talvolta, regalano magie esaltanti; ma le soddisfazioni che regala il lavoro prolungato con gli stessi partner sono diverse, più profonde, e preferisco condividere percorsi lunghi di ricerca e di crescita. Mi piacciono le prove, mi piace creare degli equilibri potenti e speciali, dei codici interni caratteristici e identitari che consentano di lavorare su forme che cambiano di volta in volta, sempre nuove e diverse. In questo, Salvatore e Roberto sono perfetti: hanno sempre protetto la loro dimensione artistica dalla routine e dagli svilimenti del mestiere e perciò sono disponibili a trascorrere con me intere giornate a studiare, ricercare, sperimentare, arrangiare. È la parte più importante del lavoro, quella che consente di far diventare i concerti una manifestazione pura di tutto l’impegno che si è sprigionato nel tempo e che ci sostiene come una presenza invisibile ma potente. Non diventa più una questione di ispirazione o di illuminazione ma di sostanza e fiducia. Il denominatore comune tra noi è l’amore per il suono, la convinzione di essere noi stessi degli strumenti; ognuno di noi ha costruito attorno al suono la sua caratteristica identitaria, e tutti e tre abbiamo una cura particolare per il modo in cui viene prodotto il suono dai nostri rispettivi strumenti a ogni nota che facciamo. È una specie di elemento narrativo a-temporale, che ci lega in modo quasi primitivo.
Tutto questo è emerso fin dal lavoro attorno a Pier Paolo Pasolini e mi ha ispirato per il repertorio seguente, che ambiva a una sorta di linguaggio universale fatto di canti e danze molto semplici e senza elementi idiomatici sofisticati. Ci ascoltavamo semplicemente nel suono senza forzare nulla di specifico, e tutto suonava sorprendentemente nuovo e fresco! Salvatore, oltre che un ottimo strumentista, compositore e musicista assai intelligente, è prezioso soprattutto per gli equilibri musicali interni al trio.

Senza mezzi termini, penso che Roberto sia un batterista unico: nessun altro al mondo possiede quel suono e quel gesto tecnico, nessuno accorda lo strumento in quel modo e il suo apporto al carattere e all’identità del trio è decisivo. Proprio la nostra unicità è l’attestato più gratificante che riceviamo in modo incondizionato in tutto il mondo, quest’anno negli Stati Uniti come in Qatar o in Romania! La nuova avventura attorno a Wilder, dunque come reinterpreti di una tradizione statunitense, è una sfida che ci ha accompagnato in maniera parallela lungo i dieci anni di lavoro sulle mie composizioni. E per questo suona come uno sviluppo naturale, in senso esecutivo, di qualcosa che è sempre stato presente, perfettamente complementare al nostro «River Of Anyder» e alle nostre «Songways».
Monica Carretta









