Il ricco e multiforme percorso discografico di uno dei protagonisti del jazz del nostro tempo: una sintesi di epoche e culture
Nato nel 1971 ad Albany (New York) da genitori indiani, con esperienze di sideman in ambiti diversi della penultima avanguardia (Steve Coleman e Roscoe Mitchell), impegnato da leader in un linguaggio di sintesi di epoche e culture e coinvolto – forse più della media – anche in imprese musicali vicine al mondo accademico, Vijay Iyer presenta le coordinate di una figura tipica del jazz contemporaneo. La sua complessa identità di autore, di cui si riconosce un percorso primario e dall’evoluzione chiarissima, ne fa però una figura chiave, esemplare, ottimale: dal dichiarare suoi ideali maestri Monk, Ellington, Andrew Hill e Randy Weston – esattamente nell’ordine – all’individualità del linguaggio, multiculturale e prettamente contemporaneo, che stratifica su questa miratissima rosa di riferimenti.
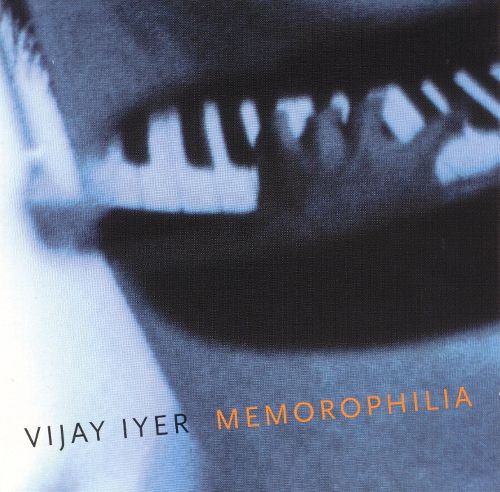 La prima produzione di Iyer è esplorativa. Nel suo primo disco «Memorophilia» del 1994, realizzato con formazioni varie, si avvertono ben più influenze di quanto Iyer stesso non dichiari; anche episodi di folklore metalinguistico mescolati alla libera produzione di suoni che risentono dell’avanguardia creativa. Interessante è soltanto qualche pezzo in trio (soprattutto Spellbound And Sacrosanct…), che annuncia l’importante propensione meditativa del suo pianismo.
La prima produzione di Iyer è esplorativa. Nel suo primo disco «Memorophilia» del 1994, realizzato con formazioni varie, si avvertono ben più influenze di quanto Iyer stesso non dichiari; anche episodi di folklore metalinguistico mescolati alla libera produzione di suoni che risentono dell’avanguardia creativa. Interessante è soltanto qualche pezzo in trio (soprattutto Spellbound And Sacrosanct…), che annuncia l’importante propensione meditativa del suo pianismo.
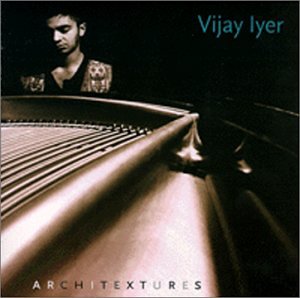
Il successivo «Architextures» (1997) mostra invece quella selezione di influenze già compiuta, con pezzi in ottetto di cui è ancora facile scontornare gli ingredienti e nuovamente pezzi in trio, ritmici e pensosi, a indicare senza dispersioni la direttrice attiva. Uno in particolare, Trident, sarà non a caso rivisitato in più circostanze.

Ma un’immagine del tutto organica della musica di Vijay Iyer ci viene già incontro nel bel «Panoptic Modes» del 2000, prima prova di un quartetto vissuto otto anni e che ha reso particolarmente vitale l’apporto di un altro musicista di origine indiana: il contraltista Rudresh Mahanthappa. La musica che Iyer realizza con questo gruppo stabile – a parte la sezione ritmica sui primi due dischi – è complessa ed equilibrata, intellettuale e musicale.
 Motivo per cui – oggi sappiamo finalmente riconoscerlo! – la musica di tutti e quattro i dischi incisi dal quartetto («Panoptic Modes», «Blood Sutra», «Reimagining» e «Tragicomic») è fatta di pezzi puntualmente molto intensi, oltre che di alcuni capolavori.
Motivo per cui – oggi sappiamo finalmente riconoscerlo! – la musica di tutti e quattro i dischi incisi dal quartetto («Panoptic Modes», «Blood Sutra», «Reimagining» e «Tragicomic») è fatta di pezzi puntualmente molto intensi, oltre che di alcuni capolavori.
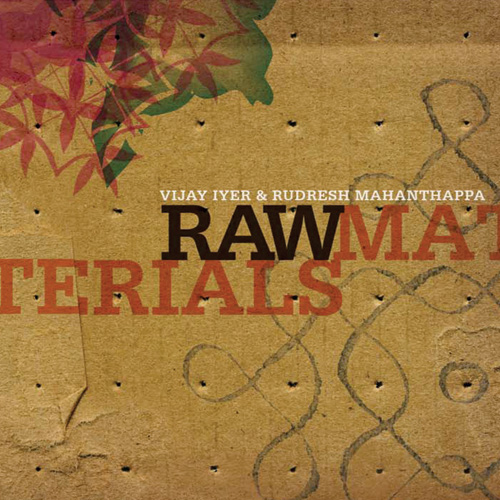 Nel 2008, con alle spalle questa fiorente discografia, in cui si inserisce anche il fondamentale duetto «Raw Materials» nel 2005, e una poetica di gruppo che si dimostrava in continuo movimento, le carriere di Iyer e Mahanthappa si separano. Mahanthappa, già leader di un suo quartetto comprendente Iyer, si concentra sul dialogo con la tradizione indiana.
Nel 2008, con alle spalle questa fiorente discografia, in cui si inserisce anche il fondamentale duetto «Raw Materials» nel 2005, e una poetica di gruppo che si dimostrava in continuo movimento, le carriere di Iyer e Mahanthappa si separano. Mahanthappa, già leader di un suo quartetto comprendente Iyer, si concentra sul dialogo con la tradizione indiana.
Vijay Iyer, che nel frattempo ha già realizzato opere divergenti dal suo tracciato primario (con il gruppo sperimentale Fieldwork e con il poeta Mike Ladd), sceglie evidentemente di approfondire il legame fra quel tracciato e la sua connotazione strumentistica, cominciando nello stesso anno a incidere in trio con la sezione ritmica degli ultimi due dischi del quartetto (Stephan Crump e Marcus Gilmore) e lasciandoci un nuovo capolavoro, quale può dirsi l’intero disco «Historicity».
 Senza le tinte forti impresse da Mahanthappa, la musica di Iyer perde uno strato spesso di apparenza avant-garde. Precisando invece la sua identità nel superamento di quella categoria: confermandosi una musica di ricchezza sapiente e di dettagli che rivendicano importanza. In Vijay Iyer matura oltretutto il piacere dell’omaggio – sentimentale e intellettuale insieme, si direbbe – alla musica amata. Perciò include nel suo repertorio pezzi di autori interni o vicini al suo pedigree (Andrew Hill, Julius Hemphill, Henry Threadgill, Herbie Nichols…), così come qualche canzone pop: di Human Nature incide addirittura due versioni (in solo nel 2010 e in trio nello splendido «Accelerando» del 2012).
Senza le tinte forti impresse da Mahanthappa, la musica di Iyer perde uno strato spesso di apparenza avant-garde. Precisando invece la sua identità nel superamento di quella categoria: confermandosi una musica di ricchezza sapiente e di dettagli che rivendicano importanza. In Vijay Iyer matura oltretutto il piacere dell’omaggio – sentimentale e intellettuale insieme, si direbbe – alla musica amata. Perciò include nel suo repertorio pezzi di autori interni o vicini al suo pedigree (Andrew Hill, Julius Hemphill, Henry Threadgill, Herbie Nichols…), così come qualche canzone pop: di Human Nature incide addirittura due versioni (in solo nel 2010 e in trio nello splendido «Accelerando» del 2012).
 Ed è interessante osservare che la canzone pop viene valorizzata con strategie tanto omogenee allo standard esecutivo del trio quanto indipendenti dalla connotazione seduttiva del genere (all’opposto di Brad Mehldau), mentre è escluso dalla teoria degli omaggi il repertorio classico (diversamente da come fa Jason Moran). I lavori di Vijay Iyer vicini al mondo accademico, come senz’altro «Rites Of Holi» (creato per un cortometraggio, su una traccia ideale della Sagra stravinskiana) e, se si vuole, anche «Mutations» (per piano, elettronica e quartetto d’archi), restano in un ambito separato. Divagazioni, complementi, appendici, anche se per lo più qualità.
Ed è interessante osservare che la canzone pop viene valorizzata con strategie tanto omogenee allo standard esecutivo del trio quanto indipendenti dalla connotazione seduttiva del genere (all’opposto di Brad Mehldau), mentre è escluso dalla teoria degli omaggi il repertorio classico (diversamente da come fa Jason Moran). I lavori di Vijay Iyer vicini al mondo accademico, come senz’altro «Rites Of Holi» (creato per un cortometraggio, su una traccia ideale della Sagra stravinskiana) e, se si vuole, anche «Mutations» (per piano, elettronica e quartetto d’archi), restano in un ambito separato. Divagazioni, complementi, appendici, anche se per lo più qualità.
 La musica del trio, intanto, continua a mostrarsi in evoluzione. L’album «Break Stuff», privo di omaggi, ne è un capitolo ancora nuovo, una «pausa» di ulteriore ricerca. Con il supporto di un lavoro sempre più attento e ricco di Crump e Gilmore, Iyer approfondisce il pianista non abbagliante, il pianista della sfumatura, più che del colore; del sentimento cosciente e dell’introspezione, più che della passione; il pianista di cui suscitano emozione le note, gli accordi, le figure, più che il tocco. La ricchezza ritmica è il suo solo tratto enfatico.
La musica del trio, intanto, continua a mostrarsi in evoluzione. L’album «Break Stuff», privo di omaggi, ne è un capitolo ancora nuovo, una «pausa» di ulteriore ricerca. Con il supporto di un lavoro sempre più attento e ricco di Crump e Gilmore, Iyer approfondisce il pianista non abbagliante, il pianista della sfumatura, più che del colore; del sentimento cosciente e dell’introspezione, più che della passione; il pianista di cui suscitano emozione le note, gli accordi, le figure, più che il tocco. La ricchezza ritmica è il suo solo tratto enfatico.
Ma questo «procedere dal basso» è anche il sintomo di un musicista più completo del pianista in sé. Qualità che Iyer vanta rispetto sia a Brad Mehldau sia a Jason Moran, per parlare di pianisti di simile generazione. Rispetto a Edward Simon, pianista meno incisivo, ma altrettanto vocazionato a un progetto globale di musica, Vijay Iyer possiede invece un’olimpica estraneità alla retorica. La sua India, il suo Monk, il suo Andrew Hill, i suoi affetti pop sono parti di una biologia, vissute in quanto demitizzate. Un atteggiamento che nel jazz contemporaneo, sempre a caccia di pretesti, si vorrebbe più frequente.
Paolo Vitolo
Leggi anche l’intervista a Vijay Iyer
