Chitarrista, pianista, trombettista ma anche, e forse soprattutto, un compositore incredibilmente trascurato: esaminiamo in dettaglio la lunga carriera di Ralph Towner, un maestro dei nostri tempi
Se dall’apparizione degli Oregon e dall’uscita del suo primo disco da leader, entrambe datate al 1972, Ralph Towner si è subito distinto per una spiccata capacità di mettere in musica tutti gli stati d’animo che implicano contemplazione, ciò che fa da premessa a questa importante attitudine è un lungo percorso di formazione, ricettivo di tanti stimoli ma fatto di continue deviazioni ed esperienze transitorie.
Nato in una cittadina dello Stato di Washington nel 1940, da madre insegnante di piano e padre trombettista dilettante (morto appena tre anni dopo), impara da bambino a suonare tutti e due gli strumenti. Il piano lo indirizza alla cultura classica, la tromba a suonare dall’adolescenza in orchestre da ballo. Il jazz, allora di pochissima presa nel Nord-Ovest degli Stati Uniti, comincerà a metterlo a fuoco in seguito, studiando teoria e composizione alla vicina università dell’Oregon, dove stringe amicizia con Glen Moore (futuro contrabbassista degli Oregon) e con un jazzista che ai due giovani studenti fa ascoltare dischi del trio di Bill Evans. Si sa che per Towner era stata una folgorazione. Intanto, nello stesso anno (1962), Towner acquista un po’ per caso una chitarra classica d’occasione e ci si appassiona al punto di dedicarcisi quasi esclusivamente, fino a decidere di frequentare per un intero anno accademico (1963-64) il corso di Karl Scheit (sorta di Andrés Segovia mitteleuropeo) al conservatorio di Vienna.
Di conseguenza per un po’ di tempo si alternano nella sua vita periodi viennesi, in cui suona chitarra e liuto in formazioni classiche, e periodi americani jazzistici, con chitarra o piano. E neppure il ritorno definitivo negli USA (1968), con base a New York, lo induce a una scelta stabile. Suonando soprattutto il piano, fa da accompagnatore a chi capita e a volte anche da «leader per una sera» accettando i concerti rifiutati dagli amici Chick Corea e Hal Galper. La chitarra la suona accompagnando il cantautore Tim Hardin al festival di Woodstock, occasione in cui si ricongiunge a Glen Moore.

Poi, nel corso del 1970, un incrociarsi di situazioni lo porta, ormai già trentenne, a trovare finalmente un contenitore per i tanti stimoli poetici che ha coltivato nel tempo. Rimasto insieme a Moore tra gli accompagnatori di Tim Hardin, conosce in quel contesto il multi-strumentista Colin Walcott, specializzato in strumenti indiani, e i tre vengono casualmente ascoltati dal sassofonista Paul Winter che li invita a entrare nella nuova formazione del Paul Winter Consort, i cui membri ereditati dalla precedente sono il violoncellista David Darling e l’oboista Paul McCandless.
Un habitat ideale
Questo gruppo unico nel suo genere, tanto ispirato dal pacifismo, ecologista ante litteram e che adotta l’approccio esecutivo del jazz per mettere in reazione chimica radici folkloriche, etniche e classiche occidentali, appare naturalmente a Towner un habitat ideale, e la cosa è colta al volo da Winter, che in vista della prima data dal vivo gli richiede composizioni e gli affida arrangiamenti. E ascoltando il disco «Road» che ne è derivato, già molto diverso dai precedenti del Consort per una diffusa impronta cameristica, si avverte anche una certa differenza tra le composizioni di Towner e il resto del repertorio. Con Ghost Beads in testa, sono le più introspettive e anche le più immaginative; spesso di un modale inquieto, in continuo movimento, anche quando le melodie hanno ampie campiture. Lo è persino una song avvolgente e accattivante quale Icarus, che è di un modale statico come quello che allora era già alla portata di tanto rock.
Ma nel gruppo Towner ha altrettanto peso anche come strumentista. Suona quasi esclusivamente la chitarra, alternando la classica alla dodici corde, e per entrambi gli strumenti, nel rispetto delle loro diverse proprietà, ha messo a punto un linguaggio «totale»: orchestrale e multi-culturale. Arpeggi classici e senso del sincopato, suono cristallino e fisicità dirompente. Alla chitarra acustica in genere viene così impressa una profondità «pianistica» che rimanda forse a Bill Evans; una dimensione pressoché sconosciuta ai suoi pochi precedenti interpreti di area jazzistica – essenzialmente Laurindo Almeida e Charlie Byrd – e che neppure interesserà granché il più giovane Bill Connors.

La fortissima impronta di Towner, un po’ in contrasto con lo stile di Winter al sax alto (vagamente sulla scia di Paul Desmond), stimola invece la complicità e le attitudini creative di Moore e Walcott e anche di McCandless, suonatore di ance doppie, generando in alcune esecuzioni, non tutte appunto, una musica che scontorna e sviluppa soltanto alcuni aspetti di quella del Consort, che concede più spazio all’improvvisazione e soprattutto si pone sopra i generi come riflessione su un mondo utopico tanto più mediata, intrisa di echi di un passato o di un altrove che confluiscono in un presente «alternativo». È la musica che Towner, McCandless, Moore e Walcott trapiantano nel loro gruppo Oregon, creato nello stesso 1970 ancor prima di lasciare Winter (con il quale incideranno ancora nel 1971 il disco Icarus, con l’accattivante tema towneriano già eletto a cover).
È anche l’occasione in cui Towner riprende a suonare con frequenza il piano, e il suo stile lirico e disciplinato allinea un’espressione opportunamente più calda alla cultura post-evansiana della generazione dei Corea e dei Jarrett. Non lo curerà più di tanto, lasciando al piano una funzione di servizio.
Musicalmente in controtendenza quanto il Consort, soprattutto rispetto al jazz, e altrettanto sensibili a certe tendenze extramusicali (pacifismo, ecologismo, fenomeno hippie), gli Oregon sono di principio un gruppo senza leader, la cui poetica è dichiarata collettiva: curiosamente, come l’Art Ensemble of Chicago, col quale condividono anche la pratica multi-strumentistica di ciascun membro. E soprattutto nei primi due dischi («Our First Record», del 1970, e «Music Of Another Present Era», del 1972) questa caratteristica provoca, come nel gruppo chicagoano, un po’ di intercambiabilità/indecifrabilità dei ruoli. Towner suona le sue due chitarre, il piano e il mellophone; McCandless l’oboe e il corno inglese; Moore il contrabbasso, il flauto, il piano e il violino; Walcott il tabla, il sitar, la chitarra a dodici corde, il piano e percussioni varie. La differenza è che qui tutto nasce per diretto creazionismo e converge su un fine schiettamente musicale: niente decostruzione, prelievo, collage, cose simili. I pezzi improvvisati si stagliano da quella certa compostezza barocca per sconfinare nell’atmosfera pura, spesso pervasa di indianità.

Negli stessi primi due dischi, anche le composizioni sono piuttosto equamente ripartite tra i quattro. La penna di Towner prevale di poco, a volte in combutta con quella di Walcott, e neppure sempre è facile distinguerla da quella di McCandless o Moore o Walcott stesso, a parte qualche pezzo «più indiano», magari dominato dal sitar. Del resto Towner è già allora un compositore poliedrico, le cui diverse declinazioni possono sia coincidere con quelle collettive, sia averle suscitate. Cosa certa è che le pagine di maggior valore che il gruppo ha accumulato nel suo repertorio, addirittura fino a oggi, restano quelle a sua firma. E neanche possono dirsi concepite appositamente in funzione di quel sapore un po’ bucolico, un po’ britannico, che contraddistingue per qualche tempo lo stile esecutivo oregoniano. Costituiscono anzi gli episodi che al gruppo più hanno dato varietà di registri. Dal lirismo tenero di Aurora, avvolgente e un po’ pop come il vecchio Icarus, a quello più contemplativo di Silence Of A Candle e Song For A Friend e dalle derive estatiche di North Star, Distant Hills, Yellow Bell, Vessel… al melodismo perturbato, fitto di colpi di scena, di Dark Spirit, Tide Pool, Vision Of A Dancer, Waterwheel, Ogden Road…, accontentandosi di una catalogazione molto approssimativa.
Evocare tempi e luoghi
Qualcuno di questi piccoli capolavori Towner lo aveva precedentemente inciso in qualche suo disco da leader, cosa che avverrà più volte anche in seguito, e così anche che un pezzo creato per gli Oregon lo rilegga poi in un proprio disco. Perché la sua produzione di leader, iniziata nel 1972, delinea un percorso per certi versi parallelo a quello con gli Oregon. Da allora a oggi è realizzata unicamente per ECM, essendo spontaneamente vicina ai principi estetici che già da allora caratterizzano l’etichetta di Manfred Eicher; più variegata per l’alternarsi di lavori in solo, in duo e con qualche gruppo (soltanto uno, negli anni Settanta, rimane stabile per qualche tempo), ma alimentata dalla stessa idea di possibile musicale che gli Oregon interpretano a livello collettivo: lo stesso evocare tempi e luoghi stravolgendo la nozione di folklore insieme a quelle di presente e passato, Nord e Sud.

Il primo disco di Towner a suo nome, «Trios/Solos», probabilmente per come lo aveva concepito Eicher, si presenta un po’ come una rassegna di potenzialità, mettendo insieme proiezioni pseudo-sperimentali della musica degli Oregon (i trii con McCandless e Walcott) e immagini intensissime dell’arte di Towner in solo, sia al naturale sia sovraincidendo linee di chitarra e piano: così nella ricchissima versione di Re: Person I Knew, secondo omaggio a Bill Evans dopo il Jade Visions contenuto nel primo disco oregoniano. Ma il discorso si fa già compatto nel successivo «Diary» del 1973, in cui Towner lavora unicamente in solitudine e in più brani sovraincide chitarra su chitarra o chitarra su piano.
Il criterio dell’overdubbing – che vanta proprio Bill Evans tra i suoi pionieri jazzistici – rappresenta infatti per Towner un dispositivo particolarmente propizio al suo ideale di ricchezza armonica dell’esecuzione. Fuori dagli Oregon, il suo obiettivo è che questa ricchezza risulti dalla compresenza di linee melodiche accordali aventi ciascuna la propria individualità. Una sorta di concezione atomizzata dell’elemento sinfonico, se si vuole stratificata sulle orme di Tristano e di Evans, appunto, ma con una più mirata motivazione a creare musica di ricchezza reale, non teorica, e nessuna ridondanza: musica di autentica profondità emozionale.
Questa concezione porta Towner a realizzare anche incontri con altri solisti di strumenti dal suono non continuo, dai quali ottiene risultati diversi sia tra loro che da quelli dei lavori solitari con overdubbing. Nel senso che l’ideale di arricchimento armonico risulta subordinato agli scambi di ruolo solistico.
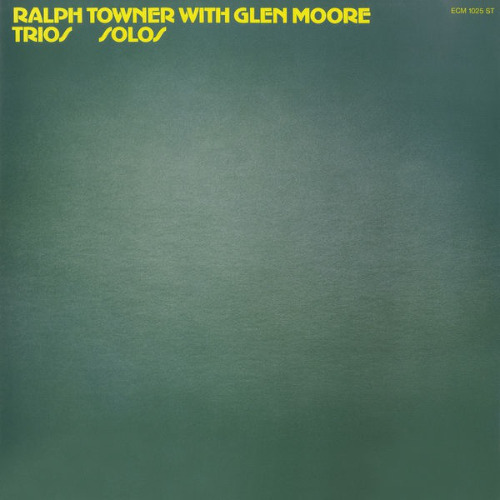
I due incontri realizzati a oltre dieci anni di distanza con Gary Burton, «Matchbook» nel 1974 e «Slide Show» nel 1985, sono in tal senso i più legati alla tradizione, ma anche i più riusciti. Infarciti entrambi di splendide composizioni towneriane, create o no per le singole circostanze, presentano la combine di chitarra e vibrafono in chiave di un lirismo delicato, discreto, e di una straordinaria parcellazione sonora: una cura del dettaglio mai decorativa, che si traduce invece in profondità e respiro. Soprattutto Slide Show, pervaso di una più penetrante melanconia, contiene esecuzioni di immenso fascino. È il disco in cui nascono due altri splendidi pezzi che poi migreranno agli Oregon, Innocente e Charlotte’s Triangle.
Espandere la melodia
Diversa per dinamiche e impatto emotivo la musica creata in duo con John Abercrombie nei dischi «Sargasso Sea» del 1976 e «Five Years Later» del 1981.
Towner e Abercrombie sono i primi e i massimi artefici della chitarra non influenzata né da Jim Hall né dal rock o da derivati del blues. Ma lo sono in due modi opposti e neppure complementari: due modi indipendenti. Towner acustico, Abercrombie elettrico; Towner resistente alle tendenze in atto, Abercrombie abile nell’anticiparle. Il loro connubio potrebbe essere stato indotto più dalla loro profonda amicizia che non dalla condivisione di idee musicali, sempre che non sia stata iniziativa di Eicher. Ascoltando entrambi i dischi, peraltro ben più felici di quanto la critica non li abbia in gran parte giudicati all’epoca, si ha comunque la sensazione di ascoltare in prevalenza un Abercrombie armoniosamente giustapposto al sognante mondo di Towner: giustapposto, non contrapposto. Ad eccezione dei pezzi improvvisati, in cui Towner opera molto su un piano ritmico-gestuale (solo il variegato Late Night Passenger, in «Five Years Later», lo mostra in parte nella sua tipicità solistica), si può osservare che Abercrombie in entrambe le occasioni impiega soprattutto sonorità moderatamente elettriche e firma pezzi soprattutto contemplativi (Fable, Avenue e Over And Gone in Sargasso Sea; almeno Isla in Five Years Later). Quasi ovunque sembra prevalere un intento comune di sfruttare le proprietà dello strumento cordale secondo l’idea, perfettamente towneriana, di «espansione» della melodia nell’armonia. Towner, a sua volta, minoritario come compositore in Sargasso Sea, al successivo «Five Years Later» porta nuovi originali molto belli (assoluto capolavoro The Juggler’s Etude), attirando il collega amico nel cuore del suo particolare, composito e ricchissimo immaginario musicale.

Il solo gruppo relativamente stabile con cui Towner ha lavorato in tutta la sua carriera, a parte gli Oregon, è un quartetto con Jan Garbarek (sax tenore e soprano e flauto), Eberhard Weber (contrabbasso e violoncello, anche con qualche artificio riproduttivo) e Jon Christensen (batteria e percussioni), messo in piedi da Eicher e – come spesso in questi casi – immortalato su due soli dischi, «Solstice» nel 1974 e «Sound And Shadows» nel 1977. Sono però due capolavori, anche di gruppo, come tanti dischi degli Oregon, e che rivelano ancora un’altra faccia, purtroppo senza seguito, del contributo individuale di Towner all’allora nascente «stile» ECM: la straordinaria complicità tra gli stati d’animo della sua musica e le particolari inclinazioni melodiche e sonore di Garbarek, adatte a sottolineare tutte le frequenze drammatiche che il trasognato melodismo di McCandless spesso sembra sublimare. Ne è prova, la potente versione di Distant Hills, che letteralmente ribalta il senso dell’originale, accanto a pezzi come Oceanus, Balance Beam, Drifting Petals e Song Of The Shadows (gli ultimi due con Garbarek al flauto).
Tra i due dischi realizzati con questo meraviglioso gruppo Towner incide in duo con Garbarek il fortunato «Dis» del 1976, al quale dà un contributo della più alta qualità, trovandosi naturalmente a suo agio anche con una musica tanto ispirata dalla tradizione norvegese. Ma i lavori che lo contraddistinguono proseguono, come sempre, distribuiti tra i suoi dischi e quegli con gli Oregon. E in questo periodo, gli ultimi anni Settanta, ne vedono la luce alcuni dei più felici.

«Batik», del gennaio 1978, soffre in parte di qualche scelta dovuta forse più a Eicher che a Towner: due partner «ingombranti» quali Eddie Gomez e soprattutto Jack DeJohnette e un’esecuzione di circa 16’ (quella che dà il titolo all’album) totalmente improvvisata e inevitabilmente un po’ dispersiva. In compenso contiene ben tre nuove gemme del Towner compositore «degli stati d’animo», Waterwheel, Trellis e Green Room. Il primo di questi pezzi migra entro pochi mesi nel disco «Out Of The Woods» degli Oregon, uno dei più belli ed equilibrati del gruppo, insieme al successivo «Roots In The Sky» nel quale ricompare il vecchio Ogden Road, nato in «Diary».
Altri pezzi notevoli si trovano poi nell’anomalo «Old Friends, New Friends» dell’estate 1979, che Towner realizza da leader di un quintetto (pure assemblato da Eicher) comprendente Kenny Wheeler (con cui ha già suonato qualche anno prima in un pezzo del disco «Deer Wan», a nome del trombettista), oltre che il violoncellista David Darling, suo ex-collega nel Paul Winter Consort. Alcune di queste nuove composizioni (New Moon, Special Delivery e Kupala) sembrano infatti adattare l’inconfondibile stile di scrittura towneriano al melodismo pervasivo e pastoso di Wheeler. Non a caso quelle che rivivranno nel repertorio degli Oregon sono altre: Celeste, che è una carezzevole ballad tonale, quasi pop, e lo splendido Beneath An Evening Sky, di un lirismo ineffabile, eseguito in duo con il violoncello di Darling.

Da solo, senza artifici
Se questo disco da non sottovalutare, a dispetto del suo titolo modesto, vede Towner per l’ultima volta leader di gruppi medi (fatta eccezione per singoli pezzi inseriti in dischi per il resto in solo o duo), due eventi di fine anni Settanta segnano l’inizio di nuovi sviluppi della sua carriera. I due concerti in solo di Monaco e Zurigo dell’ottobre 1979 (antologizzati nel disco «Solo Concert») annunciano con quasi vent’anni di anticipo l’eccelsa qualità della sua produzione in solo, rigorosamente senza artifici, che sarà la sua formula di leader pressoché esclusiva dalla seconda metà degli anni Novanta a oggi. Il temporaneo scioglimento degli Oregon nel 1980, dopo aver concluso il contratto con la Vanguard e anche inciso tre dischi per l’Elektra, lo stimola a riconcepire qualcosa dello stile del gruppo in vista di un suo possibile passaggio a ECM.
La cosa avviene dopo un abbondante paio d’anni perché Eicher, pur apprezzando la musica degli Oregon fin dall’origine, ora vuole un gruppo che non replichi in alcun modo il già fatto. Ed è qui che Towner, esplorando nuove ipotesi sul sound, procede a una svolta almeno apparentemente di rottura: affianca ai suoi strumenti tutti acustici il sintetizzatore Prophet 5.
In un primo momento è soltanto nel lavoro per gli Oregon che l’approccio di Towner ai suoni sintetici dà frutti significativi. Nel disco a suo nome «Blue Sun», del 1982, si serve della nuova risorsa essenzialmente per arricchire in termini di «spaziosità» l’effetto dei precedenti overdubbing. Così nei pezzi più tipici (tra i quali svetta un nuovo capolavoro, The Prince And The Sage). È solo nel pezzo C. T. Kangaroo che Towner, suonando il corno francese, ne ricava una sorta di raddoppio. Ne fa un uso spiritoso, sopra le righe, in un pezzo ritmico, soprattutto ironico, che apre la via a nuovi filoni di composizioni: anche leggere, sbarazzine.
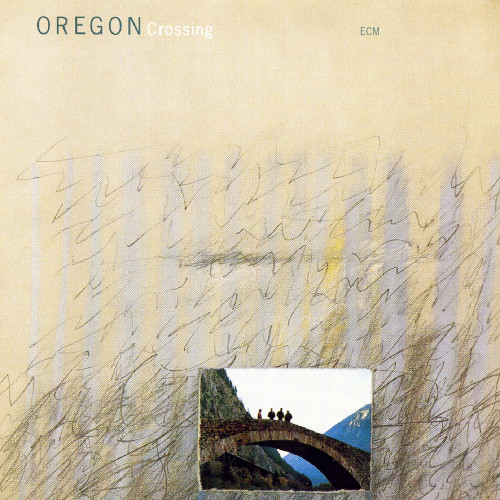
Nei tre dischi incisi per ECM dagli Oregon i suoni ottenuti dal Prophet 5 caratterizzano invece certe composizioni che proprio quell’idea di spazio rende sontuose, a volte altere. Una sensazione sostenuta anche da accorgimenti di registrazione piuttosto tipici di ECM, soprattutto delle percussioni, il che già marca la prima differenza tra questa produzione del gruppo e la precedente. Sono comunque dischi piuttosto diversi tra loro. Il primo, inciso nel gennaio 1983 e chiamato semplicemente «Oregon» (come per segnare un nuovo inizio), potrebbe persino far sospettare un’eccessiva preoccupazione del gruppo di adeguarsi ai parametri estetici di Eicher. I due soli pezzi che possono dirsi «composti» (l’iniziale The Rapids, stranamente l’unico dovuto a Towner, e Beside A Brook di McCandless) galleggiano su un contesto di prevalente sound music a tratti anche molto suggestiva ma parecchio ispirata a certe strategie sonore dell’avanguardia accademica. Al contrario, lo splendido «Crossing» dell’ottobre 1984 è un disco di composizioni e dalle atmosfere differenziate in cui il marchio ECM si riconosce principalmente dal sound. Tra gli stessi pezzi a firma di Towner ne spicca uno simpaticamente swingato e scanzonato, The Glide. Ancora diverso il successivo «Ecotopia» del marzo 1987. Walcott, morto per incidente stradale poco dopo la registrazione di «Crossing», è rimpiazzato alle percussioni dall’indiano Trilok Gurtu, dal gusto paradossalmente pìù occidentale, almeno in questo disco. Ma la differenza la fa ancora di più ciò che Towner ottiene dai suoni sintetici una volta approfondito il campo. Pezzi come Twice Around The Sun e Ecotopia mostrano quanto questo mondo sonoro si appropri a un’ipotesi moderna, o postmoderna, di contemplazione della natura.
L’oracolo di Peacock
A questo punto il volto della poliedrica vita musicale di Towner, quanto meno doppia, si fa ancora più difficile da inquadrare. Mentre il lavoro degli Oregon con ECM si conclude per motivi non molto chiari dopo soli tre dischi, tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta è proprio agli Oregon che Towner si dedica principalmente. Di concerto con i compagni, lavora a un senso del gruppo ancora nuovo, ma è evidente che proceda un po’ per tentativi.

Auspice la confidenza acquisita con più tipi di sintetizzatore, la dominante del disco «45th Parallel» del 1988 è un piacevole e intelligente camerismo pseudo-pop, figlio «leggero» di quello di «Ecotopia», al quale si integrano anche i colori di esecuzioni acustiche in perfetto stile Oregon pre-ECM. Poi la ricetta di questa musicalità accessibile e illuminata, pur sempre originalissima, si riassesta con un sensibile ridimensionamento dei suoni sintetici nel più eterogeneo ma più riuscito «Always, Never And Forever» del 1991. Poi, quando si licenzia Gurtu (peraltro responsabile di qualche pezzo vocale che mal s’inserisce nella musica oregoniana), il gruppo ridotto a trio incide due dischi deliziosi, «Troika» nel 1993 e «Beyond Words» nel 1995, in parte più cameristici del solito ma che, per contenuti e per stile, sembrano voler fare il punto della situazione.
Non meno eterogenea è l’immagine della musica che Towner realizza in quello stesso arco di tempo a suo nome. Inciso tra il 1986 e il 1988, l’intrigante «City Of Eyes», contiene pezzi in gruppo di stampo parecchio ECM (con McCandless, Markus Stockausen, Gary Peacock e Jerry Granelli) inframmezzati da piccoli capolavori in solo o in duo con Peacock (notevoli soprattutto Les Douzilles, chitarristico, e Far Cry, con più strumenti sovraincisi). Dopodiché si passa a «Open Letter», inciso in duo con Peter Erskine tra il 1991 e il 1992: ancora grosso modo metà elettronico e metà acustico, con qualche puntata in quel camerismo più leggero e qualche piccola gemma che si fissa nella storia. In questo momento di possibile incertezza i lavori importanti sono infatti due lavori un po’ «d’occasione»: nel 1992 la colonna sonora del film Un’altra vita di Carlo Mazzacurati; l’anno seguente il magistrale «Oracle», duo con Gary Peacock, qui autore di quasi tutto il repertorio.

Per un sensibile creatore di atmosfere come Towner, lavorare per il cinema sarebbe stato possibile e logico da sempre; quasi un paradosso che questa opportunità gli si sia prospettata così tardi. Ma forse non è un caso che ciò sia avvenuto frequentando l’Italia (per la quale ha sempre coltivato passione e dove ormai vive da circa un quarto di secolo), non essendo mai stata «americana» la sua musica. Quella creata per questo dramma urbano notturno, contenente anche molta azione in ambiente marginale, nasce in ogni caso da un punto di vista originalissimo: le percezioni e gli stati d’animo dei soli personaggi che della vicenda sono vittime; il che significa musica come sempre introspettiva, melanconica, perturbata, a volte anche in contrasto con l’azione stessa, e realizzata con mezzi davvero ridotti: Towner suona il piano e le sue chitarre acustiche, ora sovrapponendone le linee a una base di sintetizzatore, ora in solo, ora accompagnato da una normale sezione ritmica jazzistica (Massimo Moriconi e Fabrizio Sferra).
Il disco con Peacock, di cui Peacock può considerarsi leader benché si tratti di un duetto, viaggia per le tonalità emotive più cupe e spigolose che caratterizzano le composizioni del contrabbassista. Di suo Towner porta soltanto il melanconico Tramonto. Ma il dialogo materiale tra questi due mondi poetici a un tempo diversi e affini, tutto cordale e acustico, perché Towner non adopera che le sue prodighe chitarre, si mantiene intensissimo di passaggio in passaggio, dalla prima all’ultima esecuzione. «Oracle» segna una data di assoluto rilievo per le discografie di entrambi.
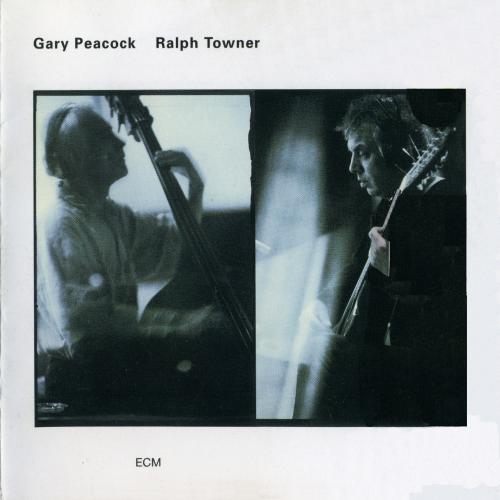
La collaborazione fra Towner e Peacock aveva del resto già una storia. Era cominciata nella prima metà degli anni Ottanta, quando entrambi insegnavano a Seattle e spesso si esibivano in qualche locale della città in trio con Jerry Granelli. Probabilmente suonando musica troppo ruspante perché il comune referente Eicher fosse interessato a immortalarla. Su disco invece i due li ritroviamo nel successivo duetto «A Closer View» di fine 1995, questa volta con un repertorio in prevalenza towneriano. Altra prova splendida, anche se non ai livelli di «Oracle».
Il cambiamento di rotta
I due dischi con Peacock risultano particolarmente suggestivi anche per uno stile chitarristico di Towner divenuto ancora più fisico, a partire da uno strappato vigorosissimo. È una tendenza che si comincia ad avvertire in certi pezzi del vecchio «City Of Eyes», poi in alcuni di «Open Letter» e qualcuno del frammentario «Lost And Found», registrato solo pochi mesi prima di «A Closer View», e non solo su pezzi dalle melodie fosche o accidentate, ma a volte anche di una contemplatività serena, edificante, magari ispirata dallo strato più carezzevole del folklore: pezzi nei quali l’elemento ritmico è spesso piuttosto importante. Il che significa che Towner in questo periodo ha sentito ancora più il bisogno di identificare nella sua espressione chitarristica – benché compiutissima almeno dal «Solo Concert» del 1981 – tutta una parte del suo mondo poetico e con tutti i registri emotivi che nel frattempo vi si sono aggiunti, lasciando in esercizio il piano, i sintetizzatori e gli overdubbing soltanto per i dischi con gli Oregon.

Dalla seconda metà degli anni Novanta la sua produzione da leader cambia definitivamente rotta. Dischi in solo realizzati a intervalli di almeno cinque anni l’uno dall’altro e neppure di durate tanto estese, composizioni originali quasi tutte di nuova creazione, qualche pezzo improvvisato senza traccia ma che non disperde l’emozione, ancora qualche omaggio a Bill Evans e ancora un Goodbye Pork Pie Hat (affezione riesumata dal duetto con Gary Burton del 1974). Finora cinque dischi in oltre vent’anni: quattro in solo, «Ana» (1996), «Anthem» (2000), «Time Line» (2005) e «My Foolish Heart» (2016), e uno in duo con Paolo Fresu, «Chiaroscuro» (2008), che finisce per attirare alla stessa economia le grandi doti del trombettista. Dischi tutti intensamente lirici, dei quali si ha la sensazione di non dover buttare via una nota, specialmente nelle esecuzioni per chitarra classica. Forse poco appetibili per il jazzofilo che ama battere il piede o nutrirsi di solismo funambolico, e che la chitarra la vorrebbe tutta sassofono.
Diversamente, la produzione degli Oregon arriva per gradi a stabilizzarsi su uno standard piuttosto elevato di serena creatività. Nel 1997 il gruppo torna ad essere quartetto con l’aggiunta del batterista e percussionista Mark Walker e incide «Northwest Passage», disco discreto che leviga e addolcisce la vecchia poetica oregoniana anche più dei due precedenti dischi in trio. Poi si susseguono «Music For A Midsummer Night’s Dream» (1998), commento alla pièce shakespeariana realizzato senza Walker, e il premiatissimo doppio cd «Oregon In Moscow» (1999), in cui il quartetto è accompagnato con formula in prevalenza concertante dalla Moscow Tchaikovsky Symphony Orchestra; due lavori che in modi e per motivi diversi polarizzano la prestazione del gruppo sull’elemento classicista. Mentre un «nuovo corso» parte dal «Live At Yoshi’s» del 2001, primo live registrato dal 1980, soprattutto godibile e scorrevole. Ed è questa, proprio questa, la direzione in cui il gruppo riprende a ricercare e raffinarsi lungo il nuovo millennio, realizzando la serie dei bei dischi incisi in studio per la CAM: «Prime» (2005), «1000 Kilometers» (2006), «In Stride» (2010), «Family Tree» (2012) e «Lantern» (2016, con Paolino Dalla Porta al posto di Glen Moore).
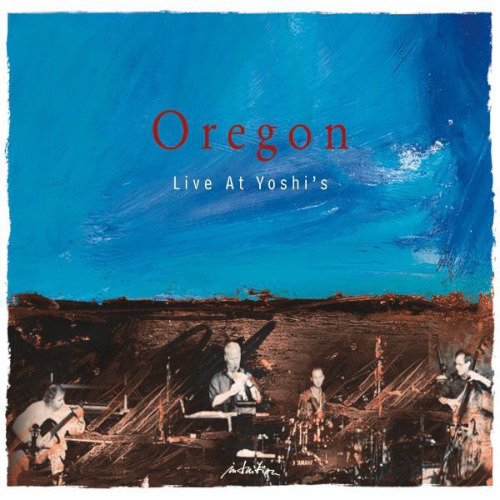
In effetti, al di là del piccolo piacere che ci concediamo nel provocare l’ascoltatore «puro e duro» per il quale la musica gradevole è tabù, questa musica è fresca e appassionante soprattutto per l’equilibrata sapienza post-ideologica che stratifica sul carattere e il sound che ne avevano fissato l’originaria ragion d’essere e arricchito negli anni il senso. È musica di emozioni pacifiche e di composizioni pacificamente evocative, tra le quali si inserisce qualche sound piece dalle frequenze più oblique senza neppure suscitare stridori.
La coesistenza di questa musica e di quella che Towner crea in solo non indica dunque una sopraggiunta sfasatura di qualità musicale fra le due facce della sua vita artistica, che continuano a porsi come complementari. La loro complementarità continua ad essere lo specchio delle attitudini di un musicista di sentimento che ama interpretare tante forme del sentimento. È d’altronde ciò che lo ha portato a quel livello di espressione strumentistica/chitarristica decisamente senza rivali, e a una statura di compositore che sarebbe da equiparare a quelle di Wayne Shorter, Carla Bley, Kenny Wheeler, Paul Motian… A parte certi capolavori strutturalmente legati alle proprietà della chitarra acustica (The Juggler’s Etude, Les Douzilles, Beppo… un po’ anche il sublime Beneath An Evening Sky), nemmeno altri che non presentano questa caratteristica (Ghost Beads, Distant Hills, Ogden Road, Waterwheel, Vessel, Innocente, The Glide, Nightfall, Tramonto…) sembra siano mai entrati in repertori altrui. E non si capisce perché, essendoci oggi musicisti interessati a esprimersi in senso autoriale anche sull’importante patrimonio compositivo della musica non accademica che, per puro comodo, continuiamo a chiamare jazz.
Paolo Vitolo
