Nelle più accreditate storie del jazz, Bud Freeman è citato come uno dei più autorevoli sassofonisti di scuola dixieland che svolse un ruolo di primo piano durante la Swing Era e nella successiva fase di transizione al mainstream-jazz. In realtà, come cercheremo qui di dimostrare, il «più travolgente sassofonista che il Dixieland abbia espresso» – a detta di Joachim-Ernst Berendt – ha attraversato tutte le principali correnti stilistiche del jazz, inclusa quella boppistica, restando sostanzialmente se stesso: una dote riservata ad altri pochi eletti, nell’ambito di quella generazione, come Pee Wee Russell e Vic Dickenson. E finendo per assurgere a caposcuola di una corrente tenoristica «bianca», alternativa a quella allora nettamente dominante di Coleman Hawkins e che schiuse nuovi orizzonti espressivi non soltanto a Lester Young ma anche a tenoristi di estrazione moderna come Charlie Ventura e George Auld. Non a caso, nei referendum del Down Beat di fine anni Trenta, era spesso proprio Freeman a precedere Coleman Hawkins nella classifica dei «migliori» sax tenore.
Tra i tanti illustri esponenti dell’hot jazz che, negli anni Settanta e Ottanta, ho avuto il piacere di far suonare al Louisiana Jazz Club di Genova, Bud Freeman è forse quello cui sono rimasto più legato, sia per le sue doti umane sia, soprattutto, per quelle umane, che sfociarono in una lunga e fraterna amicizia. A quell’epoca ero affetto da condonite acuta e volevo sapere tutto sugli Chicagoans e sui locali in cui suonavano, su Al Capone e sul non meno famoso John Dillinger, su chi fosse più bravo tra Jimmy McPartland e Muggsy Spanier e tra George Wettling, Dave Tough e Gene Krupa. Ma l’argomento principale era la genesi del particolarissimo stile tenoristico di Freeman e l’influenza che aveva esercitato su Lester Young. E il povero Bud a casa mia, in albergo, al ristorante, negli intervalli dei concerti, rispondeva con estrema amabilità a tutti i miei pressanti quesiti, tanto che una sintesi di quelle lunghe chiacchierate fu poi condensata nell’intervista che uscì sul numero 8/75 di Musica Jazz.
Con l’umiltà tipica dei grandi, Bud Freeman si comportava da vero gentleman, cortese e sorridente con tutti: a partire dal pubblico, i cui applausi erano da lui ricambiati con profondi inchini. E quando, a concerto finito, scendeva dal palco veniva subito a chiedermi se avesse suonato bene e se io fossi soddisfatto (cosa più unica che rara…). La signorilità del tratto e del portamento si ritrovava nel suo modo di vestire: portava giacche blu con bottoni dorati Pierre Cardin, scarpe bianco-nere di vernice (difficilissime da trovare e costosissime) e l’immancabile farfallino, sostituito in qualche caso dal foulard di seta. Questo il suo look. Un’analoga eleganza caratterizzava il suo modo di parlare, raffinato e forbito e in un inglese quasi oxfordiano: non a caso Londra era e rimase una delle sue mete predilette. Ricordo che si adoperava per correggere la mia pessima pronuncia, divertendosi moltissimo a rispondermi in italiano e pregandomi di riprenderlo quando sbagliava qualche verbo.

Lawrence Freeman nacque a Chicago il 13 maggio 1906, in una famiglia che aveva la musica nel sangue. La madre era insegnante di pianoforte e il padre amava la musica classica. Sotto la guida materna, il bambino iniziò ben presto a cimentarsi con il pianoforte, anche se era affascinato dalla batteria. Qualche anno dopo, il padre gli regalerà un sassofono in Do, il cosiddetto C-Melody, strumento all’epoca molto in auge e sul quale avrebbe poi esordito. Una volta iscritto alla Austin High School, entrò subito a far parte della Austin Gang, un gruppo che comprendeva Dick e Jimmy McPartland, Jim Lannigan. Frank Teschemacher e Dave North. Sarà il chitarrista Dick McPartland ad impartire le prime lezioni di armonia e di solfeggio al giovane sassofonista, che suonava ad orecchio ed era musicalmente e strumentalmente meno preparato degli altri, che «lo sopportavano per la carica di swing che aveva in corpo» (così riferisce Milt Mezzrow nel suo celebre volume Really the Blues).
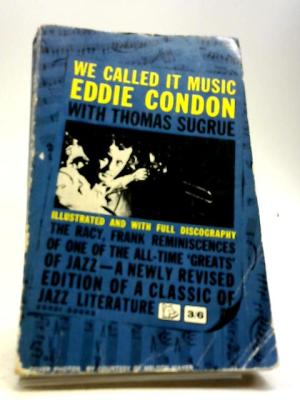 Mentre Eddie Condon, nella sua prima autobiografia We Called It Music, ricorda: «Il sax di Bud era verde e corroso dalla ruggine, tenuto assieme dal fil di ferro. Il suono che ne usciva era conforme all’aspetto». In effetti, per emergere, Freeman dovette faticare non poco – sarà costretto a perfezionare la sua preparazione musicale prendendo lezioni da Duke Real, clarinettista della Chicago Symphony Orchestra – ma, una volta entrato in pianta stabile nei Blue Friars e poi negli Husk O’Hare Wolverines alla fine del 1925, il suo sassofono, che nel frattempo si era trasformato in un tenore, finirà per contrassegnare in maniera indelebile (assieme al clarinetto di Tesch) lo Chicago Style, differenziandolo nettamente dagli stili New Orleans e Dixieland.
Mentre Eddie Condon, nella sua prima autobiografia We Called It Music, ricorda: «Il sax di Bud era verde e corroso dalla ruggine, tenuto assieme dal fil di ferro. Il suono che ne usciva era conforme all’aspetto». In effetti, per emergere, Freeman dovette faticare non poco – sarà costretto a perfezionare la sua preparazione musicale prendendo lezioni da Duke Real, clarinettista della Chicago Symphony Orchestra – ma, una volta entrato in pianta stabile nei Blue Friars e poi negli Husk O’Hare Wolverines alla fine del 1925, il suo sassofono, che nel frattempo si era trasformato in un tenore, finirà per contrassegnare in maniera indelebile (assieme al clarinetto di Tesch) lo Chicago Style, differenziandolo nettamente dagli stili New Orleans e Dixieland.
E un’inequivocabile conferma giunge dall’ascolto di Nobody’s Sweetheart e China Boy (dalla prima, storica seduta del 1927 pubblicata sotto la leadership di Condon e Red McKenzie): l’effetto della front-line è quello di tre voci parallele saldamente unite, con il clarinetto che tende a forzare sul registro acuto per contrastare il ruolo guida della tromba di McPartland. Così come la presenza del tenore al posto del trombone (formula già sperimentata con successo dai Wolverines di Bix) modifica sia la composizione che il sound della sezione melodica, relegando la polifonia libera al chorus finale, in cui i tre fiati «esplodono» (per usare la definizione di Mezzrow) e lasciando molto più spazio alle uscite solistiche. Il caratteristico background della sezioni ritmiche di Chcago, esasperatamente scandito nel quattro quarti e con il bounce spinto all’estremo per accentuare la tensione ritmica, non trova riscontro sia nel classico modulo dixieland (pensiamo all’anemico sound della Original Dixieland Jazz Band e dei quintetti newyorkesi da essa derivati, tutti privi di contrabbasso), sia nel puro stile New Orleans, contraddistinto da una pulsazione ritmica compatta, pesante e quasi indolente.
La scuola di Chicago ha sempre preferito il momento creativo alla tecnica e alla forma
Ma la vera rivoluzione introdotta dagli Chicagoans è rappresentata dalla piena affermazione del jazz come arte prettamente solistica (LeRoi Jones, in Blues People, sarebbe arrivato a scrivere che il passaggio dal collettivismo all’individualismo va ascritto ad un processo di «sbiancamento» della cultura nero-americana). Non tanto all’insegna del culto della personalità come quelle di Armstrong e Bechet ma allo scopo di esprimere qualcosa di diverso o comunque di nuovo, e poco importava se l’assolo non era strumentalmente perfetto (come quelli di Tesch e di Bud, che di quel gruppo erano le stelle).
Uno dei caratteri fondamentali che differenziano nettamente la scuola di Chicago da tutto il jazz bianco contemporaneo e successivo sta proprio nel privilegiare il momento creativo rispetto alla tecnica strumentale e alla forma. Da questo punto di vista, gran parte degli storiografi (Charles Edward Smith e Dick Hadlock in testa) ha esaltato oltre misura il ruolo di Teschemacher, arrivando a parlare di uno «stile Chicago per clarinetto». Eppure, senza nulla togliere alla genialità di Tesch, non vi è dubbio che il tortuoso e vorticoso assolo di Freeman su China Boy, brano destinato a diventare un suo cavallo di battaglia, potrà anche far storcere il naso ai «puristi» per il poco rispetto della forma e della metrica ma appare caratterizzato da un vocabolario melodico e armonico per molti aspetti inedito.
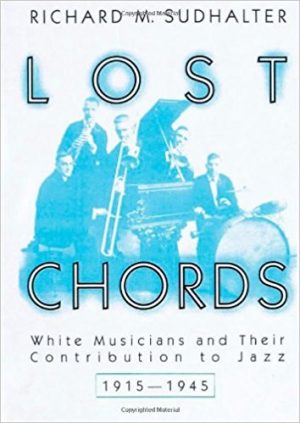 Saranno però le successive registrazioni di Crazeology (dalla prima seduta di Freeman come leader, incisa a Chicago nel dicembre del 1928), Rose Of Washington Square (Red Nichols, 1929), After Awhile (Goodman, 1929), In The Ruff (Venuti, 1933) e soprattutto The Eel, un tour de force tenoristico (inciso sotto il nome di Condon a New York nel ‘33) a dimostrare che questo giovane sassofonista, con incosciente baldanza e forse senza rendersene nemmeno conto, stava elaborando un nuovo linguaggio tenoristico. Nella sua monumentale opera Lost Chords (Oxford University Press, 1999), Dick Sudhalter dedica a Bud Freeman un capitolo di oltre quaranta pagine, analizzando nota per nota le trascrizioni di China Boy, Crazeology e The Eel, proprio per evidenziare l’originalità e sopratutto l’imprevedibilità di certi passaggi. Un linguaggio tenoristico del tutto indipendente e quasi alternativo a quello di Hawkins che, almeno sotto il profilo formale (lasciando da parte l’originalità creativa, un terreno su cui non aveva allora rivali) era contraddistinto da un fraseggio legato e sinuoso, ricco di arpeggi, e da una sonorità piena, scura, enfatica.
Saranno però le successive registrazioni di Crazeology (dalla prima seduta di Freeman come leader, incisa a Chicago nel dicembre del 1928), Rose Of Washington Square (Red Nichols, 1929), After Awhile (Goodman, 1929), In The Ruff (Venuti, 1933) e soprattutto The Eel, un tour de force tenoristico (inciso sotto il nome di Condon a New York nel ‘33) a dimostrare che questo giovane sassofonista, con incosciente baldanza e forse senza rendersene nemmeno conto, stava elaborando un nuovo linguaggio tenoristico. Nella sua monumentale opera Lost Chords (Oxford University Press, 1999), Dick Sudhalter dedica a Bud Freeman un capitolo di oltre quaranta pagine, analizzando nota per nota le trascrizioni di China Boy, Crazeology e The Eel, proprio per evidenziare l’originalità e sopratutto l’imprevedibilità di certi passaggi. Un linguaggio tenoristico del tutto indipendente e quasi alternativo a quello di Hawkins che, almeno sotto il profilo formale (lasciando da parte l’originalità creativa, un terreno su cui non aveva allora rivali) era contraddistinto da un fraseggio legato e sinuoso, ricco di arpeggi, e da una sonorità piena, scura, enfatica.
Quello di Bud Freeman era invece caratterizzato da un attacco imperioso, quasi trombettistico; da un fraseggio scabro e angoloso, con le note che si accavallano l’una sull’altra nei pezzi veloci in una successione parossistica; da una sonorità sottile, nasale, soffiante, anti-rapsodica. La conferma di questo divario stilistico è data dall’ascolto di Girl Like You Were Meant For Boys Like You, il primo dei pochissimi brani in cui Hawk e Bud suonano insieme, registrato nell’ottobre del 1930 sotto il nome di Red McKenzie. Questo nuovo stile avrebbe schiuso non pochi orizzonti espressivi: non solo ai tenoristi bianchi capeggiati da Eddie Miller ma anche a non pochi neri (da Gene Sedric a un certo Lester Young). Tra gli indiscussi discepoli di Freeman figurano Babe Russin (con Nichols), Larry Bynion (Ben Pollack), Art Rollini e Dick Clark (Goodman), Tony Pastor (Artie Shaw), Dean Kincaide, Nick Caiazza, Bernie Billings, Boyce Brown e, naturalmente, il già citato Miller, stella dell’orchestra di Bob Crosby. Miller ebbe il merito di riproporre il linguaggio di Freeman ammorbidendone it fraseggio e rendendone più suadente la sonorità, finendo per conquistare i favori del grosso pubblico. Ma la lezione di Freeman ha finito per coinvolgere anche alcuni tenoristi di estrazione ben più moderna, come Charlie Ventura e George Auld.
Riguardo la genesi di questo stile, Bud Freeman ha fatto più volte i nomi di Teschemacher (non dimentichiamo che, sino al 1924, Tesch utilizza solo il sax) e di Jack Pettis, che andava ad ascoltare al Friar’s Inn quando suonava con i New Orleans Rhythm Kings e che considerava l’indiscusso caposcuola dei sassofonisti bianchi operanti a Chicago nei primi anni Venti. «Era il re di quello che veniva anche definito North-Western Style, contraddistinto da una sonorità fredda e leggera, antitetica al suono scuro e pesante di Hawkins, che non può non aver influenzato Lester Young» (dichiarazioni rilasciate a Max Jones e pubblicate in Talking Jazz, MacMillan 1987). Bud citava anche George Johnson – il primo ad utilizzare il sax tenore al posto del trombone in una dixieland band, quella dei Wolverines – Don Murray e Fud Livingston. Un elenco nel quale non figura Trumbauer, che pare piacesse a Lester Young ma che Bud giudicava povero di swing.
Circa infine l’influenza su Lester Young è ormai assodato che il futuro President ascoltava regolarmente i dischi di Freeman e non faceva mistero dell’ammirazione che nutriva nei suoi confronti, tali e tante sono le più che attendibili fonti di riferimento (soprattutto il pianista Jimmy Rowles, un fedelissimo di Lester) raccolte e riportate da Sudhalter nel suo volume. D’altronde, ascoltando attentamente la versione di Shoe Shine Boy registrata da Lester nel 1936 sotto l’insegna Jones & Smith, appare piuttosto evidente che il tenorista nero utilizza frasi tipiche del repertorio di Bud. Ulteriore conferma giunge dal confronto delle versioni di I Found A New Baby incise da Freeman e da Young alla fine degli anni Trenta. Alle stesse conclusioni giungono George Hoefer (in un saggio dedicato a Freeman, pubblicato nel marzo 1952 su Down Beat) e John Chilton (Song Of The Hawk, Quartet Books, 1990).
Ma torniamo a Hawkins, che Bud ebbe più volte occasione di ascoltare mentre suonava al Graystone Ballroom di Detroit con l’orchestra di Henderson, restando colpito dalla tecnica e dall’audacia delle improvvisazioni. «Era sicuramente il miglior tenorista sulla scena ma non mi prefissi mai di imitarlo, dal momento che avevo già un mio stile che nel corso degli anni successivi avrei ulteriormente perfezionato». (Ira Gitler, Down Beat 5/62; Martin Richards, Jazz Journal 11/84; Bud Freeman e Robert Wolfe, Crazeology, Chicago University Press, 1989). In quest’ultima sede il diretto interessato ebbe modo di precisare: «Mi sono convinto dell’originalità del mio sound solo a forza di sentirmi dire che era diverso da quello di tutti gli altri tenoristi». Ma la definitiva conferma che Bud Freeman era il rivale numero uno di Hawkins si avrà con i primi referendum di Down Beat: ai vertici della classifica dei tenoristi si affermavano infatti il bianco (nel 1938) e il nero (l’anno seguente).
Facciamo un passo indietro. Freeman riesce a superare gli anni bui della recessione lavorando con le orchestre di Roger Wolfe Kahn, Joe Haymes, Ray Noble, Paul Whiheman, Tommy Dorsey e Benny Goodman. Una produzione che non appare particolarmente significativa, anche per il poco spazio che gli veniva concesso sotto il profilo solistico. «Suonare con le big-band non mi dava molta soddisfazione. Avevo ben poche occasioni di emergere e di dimostrare le mie reali capacità» (Jazz Journal, 9/84). Il periodo forse più felice fu quello trascorso con l’orchestra di Tommy Dorsey e, in particolare con i Clambake Seven, una formazione ridotta e di pretta matrice dixieland, che presentava i migliori solisti della big band e con la quale Freeman incise brani dagli interventi davvero degni di nota. Giusto citare At The Codfish Ball, Keeping Out Of Mischief Now, Stop, Look And Listen. E la riprova che il modulo Dixie-Swing risultasse il più congeniale ai gusti di Bud Freeman possiamo averla ascoltando The Buzzard e Tillie’s Downtown Now, incisi alla testa di un eccellente quintetto comprendente Bunny Berigan e in occasione di una jam-session organizzata dall’impresario John Hammond nel dicembre del 1935.

La novità e rappresentata dal fatto che Bud si cimenta anche al clarinetto, richiamando nelle originali escursioni nel registro grave quel Leon Roppolo che schiuse non pochi orizzonti dapprima a Tesch e poi a Pee Wee Russell. E la definitiva conferma giungerà tre anni dopo, in occasione dello storico ciclo di sedute di incisione organizzate da Milt Gabler per la sua etichetta Commodore sotto la leadership di Condon e dello stesso Freeman. Ci riferiamo a opere come Meet Me Tonight In Dreamland, Tappin’ The Commodore Till, Carnegie Jump, ancora caratterizzate dal sound chicagoano, frenetico e incalzante, così come si rivelano non meno convulsi e roventi gli assoli di Freeman. Una nota particolare meritano I Got Rhythm, At Sundown, Exactly Like You registrati in trio. Freeman «tira» con uno swing impressionante, sostenuto da due partner che in quel momento avevano ben pochi rivali: Jess Stacy, primo pianista al mondo per ben quattro anni consecutivi in base alle votazioni di Down Beat, e George Wettling, il miglior batterista dixieland secondo Eddie Condon, uno che di sezioni ritmiche si intendeva.
Nell’estate del 1939, mentre si esibiva al Nick’s con una band diretta dall’attivissimo Condon, Bud Freeman ebbe l’idea di trasformare quel gruppo in un’orchestra stabile sotto forma di cooperativa (e forse la prima cooperativa di jazzisti di cui si abbia notizia) affidando al trombonista Brad Gowans it ruolo di arrangiatore e allo stesso Condon quello di leader nominale. Gli altri membri erano Max Kaminsky, Pee Wee Russell e Dave Bowman, un discepolo di Stacy. Nacque cosi la Summa Cum Laude Orchestra, che farà il suo debutto discografico per la Bluebird incidendo alcuni dei suoi cavalli di battaglia (China Boy, The Eel, I’ve Found A New Baby), in versioni abilmente arrangiate da Gowans ma tali da conservare il sacro fuoco del sound chicagoano. Il passaggio dal Nick’s alla Panther Room dello Sherman Hotel di Chicago e dal Kelly’s di New York a Broadway (ci riferiamo al musical Swinging The Dreams) costringerà l’orchestra ad allargare il repertorio a pezzi ballabili o comunque più commerciali. Una conversione che contribuirà ad incrementare la popolarità del sassofonista presso il grosso pubblico ma che inciderà negativamente sulla successiva produzione discografica.

Cogliendo fior da fiore riusciamo comunque a trovare opere significative come Sensation Rag, Oh Baby, I Need Some Pettin’, nelle quali Bud ha modo di emergere e di dimostrare tutta la sua classe. Senza dimenticare quelle, sostanzialmente analoghe, registrate sotto l’insegna Famous Chicagoans (con Jack Teagarden al posto di Gowans e Dave Tough alla batteria), tra le quali spicca Forty And Seventh State, contraddistinta da un superbo dialogo tra Bud e Big T e da un suggestivo sottofondo orientaleggiante di Tough, in tre, quattro, cinque quarti. Tutto questo gruppo di incisioni documenta il contributo fornito da Freeman all’evoluzione del Dixieland, favorendone la commistione con lo Swing e quindi l’aggancio a quel middle jazz che si rivelerà di lì a poco la corrente stilistica a lui più congeniale.
Richiamato alle armi, presta servizio in una base militare nelle isole Aleutine ma, dopo pochi mesi, avverte i primi sintomi di una depressione che si farà sempre più invalidante e che ne determinerà il congedo anticipato per incompatibilità psicofisica. Rientrato a New York riprende ad esibirsi con gruppi diretti dall’amico Condon nonché alla testa di proprie formazioni. Ma la crisi depressiva continuava a tormentarlo ponendogli molti interrogativi sulla vita da lui condotta e sulla validità della musica che suonava, a fronte dell’onda d’urto con la quale i boppers avevano nel frattempo sconvolto la scena jazzistica newyorkese. Freeman sentì il bisogno di provare ad esprimersi con quel nuovo e rivoluzionario linguaggio. Il più nitido esempio di questa svolta è rappresentato da The Atomic Era, la sua prima composizione atonale, registrata alla fine del 1945 con il solo accompagnamento della batteria di Ray McKinley e contraddistinta da un serrato dialogo sax-batteria del tutto anomalo, stilisticamente parlando, rispetto alla sua produzione precedente e successiva. Il brano fu pubblicato su un 78 giri della Majestic e poi ristampato dalla Allegro su un altrettanto raro 10 pollici.
Non molto tempo dopo decide di frequentare i corsi tenuti da Lennie Tristano (dove tra i giovani allievi incontra Warne Marsh) non tanto perché affascinato dalla musica di Lennie, quanto per l’esigenza di perfezionare la sua preparazione tecnico-strumentale, tutt’altro che sopraffina. «Non ero un allievo modello, e ricordo che una volta – davanti alle difficoltà che incontravo a eseguire correttamente la successione di note sul pentagramma – Lennie sbottò dicendo: “Sei duro come il muro”». Il diretto interessato non sembrò dare molta importanza a quella full immersion nel cool jazz, dichiarando qualche anno dopo a Ira Gitler: «Fu come ripassare le vecchie lezioni sulle scale e sugli intervalli dei miei primi maestri, alle quali in effetti non avevo dato molta importanza. Per il resto non mi hanno minimamente influenzato» (DownBeat, 5/62).
E, sempre nell’intento di superare quel difficile momento, decise di prendersi un lungo periodo di riposo, trasferendosi in Sud America e viaggiando tra il Brasile (dove si esibirà con il pianista Joe Bushkin), il Cile e il Perù. Una decisione che risulterà salutare, visto che Freeman, rientrato a New York, riprenderà a suonare e incidere come nulla fosse. Così, nel giro di pochi anni, lo troviamo con Eddie Condon (degna di nota la tournée in Giappone e Australia con una formazione comprendente Buck Clayton, Pee Wee Russell, Vic Dickenson, Jummy Rushing), con la Newport All-Stars di George Wein, con il gruppo Jazz From The Swingin’ Era (Earl Hines, Roy Eldridge, Buck Clayton, Earle Warren, Budd Johnson), nonché alla testa di suoi gruppi – tra cui la ricostituita Summa Cum Laude Orchestra – e senza dimenticare le frequenti escursioni in terra britannica come ospite della band di Alex Welsh.

Ascoltando le opere più significative di questa produzione (Newport News e You Took Advantage Of Me con Ruby Braff e Ken Kersey; Love Me Or Leave Me e Hector’s Dance con Shorty Baker e Claude Hopkins; Basin Street Blues e School Days con Eldridge e Ray Bryant; The Eel’s Nephew, originalissima rilettura del brano inscindibilmente legato al suo nome, incisa con il sostegno delle chitarre di George Barnes e di Carl Kress) ci accorgiamo che il suo linguaggio appare meno spigoloso, più fluido e armonicamente più ricco, pur senza mai perdere l’incisività ritmica che ne costituiva l’asso nella manica. Ma la più eloquente conferma viene dal secondo confronto diretto con Coleman Hawkins (l’album «The Big Challenge» inciso per la Jazztone nel 1957). Rispetto al primo incontro di trent’anni addietro, la stimolante chase che contraddistingue Alphonse & Gaston mostra che il divario tecnico-espressivo tra i due tenoristi è assai meno evidente grazie proprio alla maturazione di Bud Freeman, favorita dalla lezione di Tristano, unita a quella di Hawkins e di Gene Ammons (che Freeman ascoltava regolarmente nell’orchestra di Billy Eckstine) senza dimenticare Stan Getz, il tenorista che Bud più ammirava tra quelli di estrazione moderna per la sua straordinaria musicalità. «Nell’interpretazione delle ballads non ha rivali», disse a Jazz Journal.
A metà degli anni Sessanta fu invitato da Yank Lawson e Bob Haggart ad entrare, come membro fondatore, nella World’s Greatest Jazz Band (assieme a Billy Butterfield, Carl Fontana, Vic Dickenson, Bob Wilber, Ralph Sutton e Gus Johnson), il gruppo cooperativo con cui collaborerà stabilmente per parecchi anni, suonando in tutto il mondo e registrando un’importante serie di dischi per le etichette Project, Atlantic e World Jazz. Il clamoroso successo riscosso dalla band nel giro di pochi anni, non solo presso il grosso pubblico ma anche la critica (nel biennio 1971-72 la WGJB dominò i referendum di Down Beat, alternandosi ai primi due posti con i gruppi di Miles Davis e di Ornette Coleman), metterà l’anziano ma ancora quanto mai valido Bud nelle condizioni di vivere una seconda giovinezza artistica.
Ecco cosa mi disse Freeman a suo tempo: «La WGJB è stata la più grande band di jazz tradizionale da molti anni a questa parte. Nuova nell’impostazione, nel sound e nel repertorio, caratterizzata da una concezione ritmica moderna, piacevolmente influenzata dal pop». E ancora: «Tra le band più importanti in cui ho suonato, la WGJB. è stata l’unica che ho sentito mia. Nessuno ci diceva come suonare, e quindi ciascuno era libero di esprimere il meglio di sé» (Jazz Journal, 10/84). In effetti, rifiutando in partenza ogni forma di imitazione o di recupero di qualsivoglia modello, la WGJB riuscì a mettere a punto un sound non solo estremamente piacevole ma ben più originale e stimolante di tante formule neo-bop sfruttate fino all’ossessione e ancora oggi in auge.

Il principale merito di un simile exploit va ovviamente attribuito a Bob Haggart, artefice degli inediti arrangiamenti orchestrali e bravissimo nel saper sfruttare in maniera esemplare le caratteristiche dei solisti, tutti di livello decisamente elevato. Nel caso di Freeman, per esempio, il sassofonista viene messo nelle condizioni di riproporre (in That D Minor Thing e nella sempiterna The Eel) i vecchi stilemi chicagoani in una versione sempre rovente e incalzante ma resa sia più scorrevole dall’assenza di inutili salti di tonalità o di registro sia più spettacolare dalla cornice «futuristica» entro la quale il sassofonista dilata quasi all’infinito i suoi serpentini assoli.
Ma il vertice è forse rappresentato dall’album «The Compleat Bud Freeman» per la Monmouth-Evergreen, registrato sotto con il prezioso sostegno di Bob Wilber, Ralph Sutton, Bob Haggart e Gus Johnson: il repertorio è quello abituale (da I Got Rhythm a Just One Of These Things) e la carica di swing è sempre travolgente, ma l’inventiva di Bud appare più fresca e vitale che mai.

Nel 1974 Freeman lasciò la WGJB per stabilirsi a Londra ed ebbe molte occasioni per suonare e incidere in Europa: in Italia con la Milan College Jazz Society, la Genova Dixieland Jazz Band e con diverse formazioni organizzate da Lino Patruno; in Francia con Georges Arvanitas; in Olanda con Ted Easton e Cees Slinger e, ovviamente, in Inghilterra con Keith Ingham e Brian Lemon.
Rientrato a Chicago nei primi anni Ottanta, continuò a esibirsi nei maggiori club della Windy City alla testa di giovani musicisti che aveva preso sotto la sua ala, partecipò a diversi show televisivi della CBS e tenne cicli di conferenze e audizioni per conto di istituti, circoli e associazioni culturali. Nel 1983 incise «The Real Bud Freeman» per la Principally Jazz, per metà composto di suoi brani originali, e nelle note di copertina scrisse: «Sono felice che questo sia il mio ultimo album perché penso che sia anche il migliore», a dimostrazione di una incredibile vitalità oltre che di uno straordinario orgoglio. Ritiratosi dalla scena nel 1989 per l’aggravarsi del tumore di cui soffriva da tempo, scomparve il 15 marzo 1991. L’ultima cartolina che ricevetti da lui fu nel 1985.
Alla soglia degli ottant’anni, Bud mi scriveva: «Pensa: lavoro tre o quattro sere la settimana, e per non meno di 500 dollari a sera». Così mi piace ricordarlo, ancora pieno di entusiasmo, esattamente come straripanti di euforia e di gioia di vivere sono i vorticosi ritornelli di The Eel, il suo indelebile marchio di fabbrica.
Giorgio Lombardi
