Ospitale per natura, la Ogun non si è mai limitata a dare accoglienza ai soli musicisti sudafricani, gli esuli giunti a Londra nei Sessanta. Le tristi e luttuose vicende individuali di molti di loro sono piuttosto note e altrettanto le gloriose imprese musicali di cui furono protagonisti e quella musica stupefacente non andò perduta proprio grazie alla complicità dell’etichetta discografica creata da Harry Miller, uno dei primi a scegliere la via dell’esilio e a sbarcare sul territorio inglese. Viene dunque naturale associare la Ogun a formazioni come i Blue Notes, la Brotherhood Of Breath, agli eroi sventurati come Dudu Pukwana e Mongezi Feza, nonché ai giovani musicisti inglesi che li frequentarono assiduamente nel segno della fraternità e della creatività, dando vita a un laboratorio sonoro inimitabile. Anche in questo caso, i nomi sono i soliti: John Surman, Elton Dean, Mike Osborne, Marc Charig, Evan Parker, Nick Evans, per dirne alcuni. L’ospitalità era dunque connaturata allo spirito della Ogun (lo è ancora oggi), cosicché qualche eccezione nel catalogo compare qui e là, registrando episodi singolari, formazioni estemporanee, musicisti in transito, incontri fuggevoli, insomma apparsi su disco una vol-ta e mai più e non solo sull’etichetta di Miller.È il caso dei radicali europei Irène Schweizer, Rüdiger Carl, Paul Lovens e Radu Malfatti che si ritrovarono con Miller, per dar vita a «Ramifications» (se ne è parlato in MJ, settembre 2018) ancora in attesa di ristampa. Ancora più estemporaneo fu però l’album registrato nel luglio del 1977 e pubblicato due anni dopo, intestato a Joe Gallivan, Charles Austin e Roy Babbington: «Home FromHome», anch’esso mai ristampato e non si può non rammaricarsene; per quanto la fiera Hazel Miller, vedova del contrabbassista eco-fondatrice della Ogun, tenga in vita tuttora l’etichetta tra mille difficoltà una riedizione appare assai improbabile. Il trio non ebbe seguito discograficamente e non solo il disco si può definire un hapax nelle carriere dei trema anche la musica che concepirono costituì un unicum nell’offerta musicale della Ogun. Oggetto misterioso, piuttosto inclassificabile e senza tempo, se non fosse che i tipici suoni elettronici analogici dovuti a Gallivan facciano da spia, rivelando la stagione da cui proviene il disco. A metà anni Settanta difatti, le tastiere elettroniche avevano sedotto non pochi jazzisti e non certo gli ultimi arrivati. Ne era invaghito da sempre Sun Ra, ma a fargli compagnia si erano fatti avanti in parecchi. A iniziare da casa Ogun, dove era sorto l’immaginifico trio SOS con i sintetizzatori di Surman. C’era poi Paul Bley che assieme ad Annette Peacock aveva giocato per un bel po’ d’anni con i nuovi marchingegni e anche in questo caso gli album sono in attesa di un completo recupero (se ne è parlato inMJ, novembre 2019). Ancora negliStati Uniti, Braxton e Richard Teitelbaum si erano azzardati in una ricerca sonora dagli esiti altalenanti quanto sconfinati e George Lewis immaginava sorprendenti mescole trai gorgoglii elettronici e i borborigmi del suo trombone. Soprattutto c’era la fusion con intesta Joe Zawinul ed Herbie Hancock a farne di tutti i colori.

In avanscoperta con loro e qualcun altro (citiamo almeno Wolfgang Dauner) c’era Joe Gallivan, batterista arrivato in Europa nel1976 vantando un curriculum non di poco conto, fatto di tanta gavetta e alcune prestigiose collaborazioni, Larry Young, Gil Evans, con i quali aveva avuto già modo di far pratica con una sorta di batteria elettronica. Il suo è un nome familiare tra i cultori dell’albero genealogico delle musiche canterburyane, essendo ricordato per le sue collaborazioni all’epoca con alcuni ex componenti dei SoftMachine e con Keith Tippett, compreso un altro disco prodotto dalla Ogun,«The Cheque Is In The Mail», opera di un brillante trio capitanato da Elton Dean e con Kenny Wheeler. Gallivan sperimentò parecchio con il sintetizzatore trovando forte disponibilità anche e soprattutto nell’altro ex della morbida macchina, ovvero Hugh Hopper a sua volta interessato alle sonorità elettroniche e alle suggestioni rileyane come aveva mostrato clamorosamente l’album«Six».Dean, Hopper e Gallivan si assestarono in quartetto con Tippett dando alla luce anche due album, entrambi colorati non poco dai suoni elettronici dei sintetizzatori.Inutile dire che anche Babbington è tra i so-liti noti per chi bazzica e ripassa senza sostale vicende del jazz britannico. Ha suonato in tutte le formazioni che contano e di conseguenza con chi davvero ha fatto la storia di quella musica: Nucleus, Soft Machine, Centipede, con Mike Westbrook, in vari combo di Stan Tracey e la lista potrebbe continuare.Lo si era già visto in casa Ogun assieme ai Joy Unlimited di Harry Beckett registrando l’ellepì «Got It Mad»la settimana precedente la seduta con Gallivan e Austin. Lì ne ven-ne fuori tutt’altra musica, perché l’album del trombettista delle Barbados si affidava a ritmi solari e temi gioiosi guardandosi bene dallo sconfinare in territori ignoti.
Non aveva precedenti con l’etichetta dei coniugi Miller e non avrebbe neanche avuti in seguito, invece, il più anziano dei tre, il multi strumentista Charles Austin daMiami, oggi novantenne, che si era fatto le os-sa addirittura con B.B. King prima di mettersi in proprio a coltivare jazz. Austin metteva in campo un bell’armamentario, eterogeneo e inusuale. Suonava il clarinetto, l’oboe, il flauto, il corno inglese e un po’ tutti i sassofoni.Tirava a campare nei locali pensando poco a incidere album e anche se non era più un giovanotto, lo scoprì proprio Gallivan prima di spostarsi in Europa. I due avviarono un lungo e fruttuoso sodalizio, dapprima puntando sul sicuro con una bella formazione, una big band chiamata Intercontinental Express, che annoverava tra le proprie fila Elton Dean, Kenny Wheeler, Ronnie Scott, Nick Evans e proprio Babbington al basso. Temi ariosi, arrangia-menti misurati, assoli pregevoli, il sound strizza l’occhio a orchestre come quella di Mike Westbrook, ma dopo un album l’esperienza venne chiusa. Austin e Gallivan invece continuarono in coppia con un trittico nei quali misero a punto il loro singolare jazz da camera e ritrovando Babbington in studio il 22 luglio del 1977, quando registrarono i quattordici brani di«Home From Home».Brevità, dunque, a segnare un’ennesima differenza con le lunghe improvvisazioni spesso presenti nei dischi (non solo) della Ogun. Sin dal primo brano le intenzioni del trio sono messe in chiaro. In Oriental Fantasy l’oboe ricama una breve melodia che si tinge di mistero rimanendo in perenne sospensione su corde frementi del basso elettrico e rifrazioni di percussioni metallicheNel brano successivo, Piecing It Together, Austin passa al flauto e un assolo di batteria in apertura pare promettere un cambio di scena, invece si ritorna moderatamente a una dimensione piuttosto rarefatta. È soltanto nel terzo brano, Soft Day, che Gallivan aziona per la prima volta il suo moog inizialmente in duetto svolto in assenza di gravità con Babbington. Il suono pare davvero alieno e anche Austin, ancora al flauto, concorre a disegnare un’atmosfera quanto meno astratta.
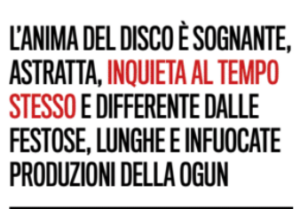
Ancora moog e in chiave eminentemente ritmica nel successivo Percussive Moments, brano dal titolo piuttosto esplicito. Un assolo di Gallivan rinforzato una volta di più dal poderoso basso elettrico di Babbington ne fanno il brano più spaziale della raccolta e il breve intervento sempre al flauto di Austin ne rafforza solo l’accento percussivo. Si torna in una landa magica con Painted Desert, che vede fornire tutt’altro sostegno ritmico alle frasi dolenti pronunciate da Austin al flauto: un severo lavoro d’arco al contrabbasso e un tintinnio di campanelli incessante. È il turno del sassofono contralto nel successivo Whistle Two-Thirty-Eight, che lancia segnali nella direzione di quello che oggi si direbbe spiritual jazz e lo stesso di casi nel brano che chiude il primo lato, ovveroTwo On A Train, che vede l’alternarsi di sassofono e flauto. In entrambi la sezione rit-mica assume un piglio più deciso, sostenuto, sebbene si continui a trattare di falsi movi-menti. Dolente e profondo il brano che apre il secondo lato,Soul One, una ballad a tutti gli effetti che si fa via via sempre più pianto rabbioso e cresce d’intensità grazie al superbo lavoro al basso elettrico di Babbington e il prezioso drumming di Gallivan, che ci ricorda una volta di più di essere anche semplice-mente un ottimo batterista. SegueCatch MeIf You Can, decisamente più battagliero, tutto svolto in velocità all’unisono. Austin qui è al soprano per volare alto i suoi partner fanno sentire i muscoli. È una falsa pista, perché con Winter Solace ci si ritrova in un batter d’occhio in quella dimensione sconosciuta che si è frequentata in precedenza. Si ria-scolta il moog nel concitato Finding Speed, e non è (volutamente) sufficiente il suono terrestre del sassofono di Austin per evitare di ritrovarsi nuovamente in orbita in uno spazio sconosciuto e lì si rimane inOn Top Of theWorld, anche perché l’uso dell’oboe che ne fa qui Austin è forse più alieno del suono del sintetizzatore. L’atmosfera pare permanere in Speedway ma a metà strada i tre decidono di accelerare capitanati dal tenore pastoso e ruggente di Austin. Chiude un’autentica miniatura, Zero Is The Hour. È ancora il flauto lo strumento solista e in meno di due minuti si prova a riassumere l’anima del disco, sognante, astratta, inquieta al tempo stesso e differente dalle produzioni Ogun, da quelle festose, lunghe e infuocate improvvisazioni che asserivano urgenza identitaria e artistica.I tre qui decisero di fare diversamente, di an-darsene in un proprio spazio-tempo e quella scelta ha conservato per intero la freschezza del disco.

Quella radicale alterità, infine, venne ribadita anche dalla copertina decisamente bizzarra. La realizzò Daniel Kleinman, all’epoca ancora un’artista in erba, ma che negli anni oltre a realizzare copertine per pezzi da novanta come Madonna, si fece un nome disegnando i celeberrimi titoli d’apertura dei film di Bond a partire da Golden Eye(1995). Una firma che oggi la povera Hazel Miller non si potrebbe permettere. Kleinman arrivava dalle ultime scene del punk londinese, a quei tempi firmò le copertine dei dischi di Adam and The Ants, e si sbizzarrì non po-co per«Home From Home», in pratica il suo esordio come illustratore. Creò un’immagine che pare concepita dalla copula consumata distrattamente dalle copertine di due operine zappiane:«One Size Fits All»e «Overnite Sensation». Tratti comuni: un divano, tanti poster(lì ritratti di Zappa, qui donnine nude), vene e muscoli allo scoperto, sporco e disordine. Segni particolari: i due personaggi che Kleinman accomodò sul divano trapuntato: una specie di astronauta/alieno e una sorta di robot dalla cui testa/boccia emerge un lungo nastro, in pratica quello delle schede traforate in uso nei computer preistorici, sul quale vengono riportati i nomi dei tre musicisti. Uno squarcio ci mostra la Terra e suggerisce che quello sia l’interno di una navicella spaziale ed effettiva-mente si è distanti un bel po’ dalle copertine Ogun, che quasi sempre riportavano foto dei musicisti o disegni di vaga ispirazione afro. Il seguito della storia, detto in breve è questo. Gallivan si fermò in Europa una decina d’anni ancora e poi se ne tornò negli Usa continuando a suonare e incidere fino a una decina d’anni fa, Austin fece lo stesso dedicandosi sempre più all’insegnamento, Babbington dà una mano tuttora ai Soft Machine dei giorni nostri e il disco continua a orbitare nel limbo degli oggetti smarriti.
A cura di Gennaro Fucile
