Il trio di Manchester, formato dal pianista Chris Illingworth, dal contrabbassista Nick Blacka e dal batterista Rob Turner, resta anomalo da qualunque parte lo si guardi.
Fin dal loro esordio, nel 2012 – ma particolarmente dall’uscita del loro penultimo album, «Man Made Object», del 2016 – i GoGo Penguin sono stati accolti come una vera rivelazione per il jazz strumentale contemporaneo. Il trio di Manchester, formato dal pianista Chris Illingworth, dal contrabbassista Nick Blacka e dal batterista Rob Turner, è anomalo sotto numerosi punti di vista. Giovanissimi, come appare evidente anche dal nome un po’ goliardico (tutti hanno studiato musica all’università e si sono conosciuti suonando nella vivace scena musicale cittadina), per scelta non hanno un leader, ma si comportano come un perfetto triumvirato, prendendo le decisioni insieme e condividendo ogni aspetto del loro progetto e della loro carriera. Utilizzano metodi modernissimi per comporre i loro brani, tra cui software musicali come Ableton o Logic, ma quando si tratta di suonarli rifiutano ostinatamente la tecnologia, affidandosi esclusivamente a strumenti analogici. Eppure, incredibile ma vero, dichiarano che la loro più grande ispirazione è la musica elettronica, e che il jazz li rispecchia «solo nella forma». In effetti le loro influenze sono talmente variegate che i paragoni si sprecano: c’è chi vede in loro qualcosa dei post-moderni Aphex Twin e Massive Attack, chi giura che assomigliano al più classico Brian Eno, chi scomoda pionieri della sperimentazione classica come Šostakovič e Debussy. Evidentemente, però, l’impronta jazz non è solo un’impressione, se un’etichetta storica come la Blue Note li ha voluti tra le loro fila. L’ultimo loro album, «A Humdrum Star», è uscito a febbraio 2018 ed è riuscito nella difficile impresa di spiazzare ulteriormente i loro fan. Le atmosfere eteree e ipnotiche di «Man Made Object» sono solo un ricordo, sostituite dall’intensità e dalle distorsioni psichedeliche di un caleidoscopio di influenze diverse, apparentemente di derivazione molto meno afroamericana. Il risultato finale, però, non delude affatto le aspettative (già molto alte) di pubblico e critica.
Perché il titolo «A Humdrum Star»?
È una citazione dell’astronomo Carl Sagan, che cercava di divulgare nozioni su scienza e cosmo ad adulti e bambini che ne erano digiuni. Tenne un famoso discorso in cui spiegava che il nostro sole non è altro che «una noiosa stella qualunque», una tra le milioni dell’universo, e che la nostra Terra è solo un pallido puntino blu nella vastità della galassia.
In che modo tutto ciò si ricollega alla vostra musica?
Quest’idea ci ha ispirato molto, perché ci dà la sensazione che tutto sia relativo, a seconda della prospettiva di osservazione. Perfino il sole, che dovrebbe essere un punto fermo per tutti, può essere considerato come un’enorme potenza di energia nucleare oppure come una stellina qualsiasi. Un po’ come il nostro album, che può essere considerato insignificante nel quadro generale delle cose, ma che nella nostra visione delle cose è un’opera importante, in cui abbiamo riversato tutto il nostro amore per la musica e cerchiamo di comunicare cose di un certo peso.
Il suono del disco è molto diverso dal precedente: le atmosfere sembrano essere meno jazz e più alternative rock, in qualche modo. È solo un’impressione?
No, affatto. Per essere onesto, forse perché la nostra è una musica basata sul pianoforte e con una certa ritmica e timbrica, l’etichetta jazz ci viene spesso appiccicata addosso, ma non è esattamente quello che sentiamo di essere; il jazz è più che altro la filosofia che ci guida, per il tipo di interazione tra i musicisti e per l’amore per l’improvvisazione.

Spesso, in effetti, avete voluto ribadire che non vi sentite di appartenere a nessuna particolare corrente musicale.
E non lo siamo, infatti. In realtà noi ci sentiamo più vicini all’elettronica e alla dance, eccetto per il fatto che usiamo solo strumenti analogici. Inoltre, tutti noi siamo anche grandi fan del rock e dell’hip hop. Nick suonava in diversi gruppi indie e adora gli Smiths e i Joy Division; Rob ha una formazione classica, ma è un appassionato di folk; io stesso ho iniziato ascoltando i Nine Inch Nails e i Massive Attack. Più suoniamo e componiamo, più ci risulta facile far emergere le nostre diverse influenze e integrarle nella musica che facciamo.
Avete dichiarato che vi siete sentiti più liberi durante la lavorazione di quest’album…
Con il nostro precedente lavoro avevamo molta pressione addosso: era il primo in cui suonava anche Nick, e tutti noi ci eravamo dati degli obiettivi davvero ambiziosi. Volevamo fare un passo avanti e soddisfare le aspettative del nostro pubblico, stupirlo. Questa volta, invece, eravamo molto più rilassati: siamo stati a lungo in tour l’anno scorso e abbiamo avuto modo di legare tra noi e sviluppare le nuove idee suonando ogni sera sul palco. Inoltre abbiamo avuto più tempo per registrarlo: «Man Made Object» era stato inciso in tre giorni, mentre stavolta ci siamo presi due settimane intere. Ci alzavamo con calma la mattina, arrivavamo in studio, provavamo e poi registravamo: una routine davvero piacevole.
A proposito del tour, avete avuto un anno davvero intenso, in cui avete girato il mondo e i momenti di pausa sono stati pochissimi. In che modo tutto ciò ha influenzato il disco?
In molti modi. Girare il mondo per suonare è molto diverso che farlo da turisti, tanto per cominciare. Le esperienze che abbiamo vissuto on the road hanno sicuramente influenzato il nostro modo di pensare e di vedere le cose. Ad esempio c’è un brano in particolare, Transient State, che è stata ispirato da ciò che abbiamo visto a Tokyo.
È stato faticoso lavorare con una concatenazione di impegni così fitta?
Abbastanza. Il fatto di avere centinaia di concerti in programma ci ha obbligato ad alzare l’asticella di parecchio: salire sul palco ogni sera implica esercizio, concentrazione, dedizione, perché la stanchezza spesso rischia di prevalere. Sento che in quest’anno siamo molto migliorati, come strumentisti.
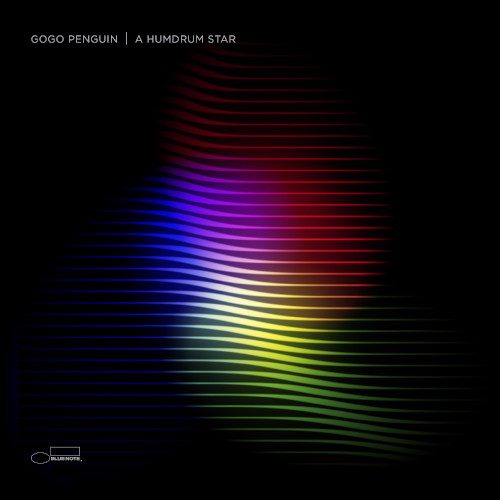
Sul palco siete in tre, ma ci tenete a sottolineare che c’è un quarto membro onorario dei GoGo Penguin: il produttore e tecnico del suono Joe Reiser. Qual è il suo contributo?
Fa parte del processo creativo e anche di quello tecnico: per la band è davvero importante avere a disposizione un altro paio di orecchie che conosce bene quanto noi la musica dei GoGo Penguin ma che non ne è direttamente artefice. Quando lavoriamo è come se noi tre ci chiudessimo nella nostra bolla, e Joe è la finestra sul mondo esterno. Ci dà una mano fondamentale a sviluppare i brani e a plasmare il suono del disco.
A proposito di suono: oltre agli strumenti tradizionali avete usato anche dei suoni provenienti da vari oggetti, come catene metalliche o addirittura un metro a nastro usato come archetto per il basso. Come vi è venuto in mente?
Lo so, sembra strano! Ma avevamo un’idea precisa del sound che volevamo e, essendo noi una band che non utilizza elettronica, abbiamo sperimentato molto per ottenerlo in maniera analogica. Quando usi un sintetizzatore puoi programmarlo per rendere le note più corte o più metalliche, ad esempio, ma su un pianoforte vero devi inventarti una tecnica diversa per ottenere lo stesso risultato, come stoppare le corde.
Avete fatto di necessità virtù, insomma?
Più o meno. Il criterio è sempre stato: «Abbiamo bisogno di questo suono, come lo creiamo?». C’era uno scopo, e non la semplice voglia di fare cose inconsuete fini a se stesse. In Prayer volevamo inserire qualcosa che assomigliasse a un tuono, e ci è venuta l’idea di applicare qualcosa di diverso alle corde del basso. A furia di provare abbiamo capito che il metro a nastro era quello che ci serviva.
Un’ultima curiosità: nella precedente intervista per Musica Jazz affermavate che i titoli dei vari brani erano senza senso perché volevate che l’ascoltatore si concentrasse sul suono, più che sul possibile significato. Vale anche per «A Humdrum Star»?
Credo che alcuni dei titoli di quest’album abbiano un significato più chiaro: penso ad esempio a Bardo, che nel buddismo tibetano è uno stato di transizione tra la morte e la reincarnazione. Rob, che ha scritto la bozza della traccia, è molto affascinato da questo tipo di filosofia. Resta il fatto che non vogliamo che la gente prenda alla lettera la nostra visione: la nostra intenzione è di trasmettere un’emozione, e quell’emozione dev’essere personale. L’esempio perfetto è Raven, che è ispirata da un mio sogno ricorrente in cui gioco a scacchi contro un corvo. Come interpretazione ha senso solo per me, perché è un mio sogno, ma il sentimento che ne scaturisce può essere preso e rielaborato da chiunque. Non vogliamo nascondere le storie alla base della nostra musica, ma allo stesso tempo non vogliamo neanche imporle agli altri.
Marta «Blumi» Tripodi
