Dal 1972 al 2012, John Surman ha pubblicato sette album in perfetta solitudine, affiancando al proprio bagaglio di dottissimo fiatista un armamentario espressivo elettronico, fatto di sovraincisioni, loops e sequencers. Il capitolo più recente di tale saga, che a buon diritto si può considerare l’espressione di un corpus narrativo unico, è «Saltash Bells» (2012), che ha completato un ciclo ideale dopo quarant’anni esatti. Il primo album della serie, «Westering Home», fu inciso per la Island. Successivamente, nel 1979, il primo disco a nome di Surman per l’Ecm, di cui rappresenta tuttora una delle figure iconiche (come pure, en passant, una delle più feconde cash cows), fu proprio un solo: «Upon Reflection». Hanno poi fatto seguito, sempre per l’etichetta di Manfred Eicher, «Withholding Pattern» (1985), «Private City» (1987), «Road To Saint Ives» (1990), «A Biography Of The Rev. Absalom Dawe» (1994), fino a giungere all’album del 2012.
 «Westering Home» è un disco che, riascoltato oggi, rivela ancor più la sua importanza. Non solo – e non tanto – perché è il primo passo di un percorso che all’epoca rappresentava una novità ma piuttosto per l’enunciazione, sia pure ancora parzialmente acerba o disorganica, di tutti gli elementi estetico-artistici già indicati, quasi l’arsenale di un giovane (e già sapiente) trovarobe. In esso inizia dunque a delinearsi quel mélange di jazz, temi tradizionali, folk reale e immaginario che poi verrà messo a punto nei titoli successivi, diventando cifra stilistica. Esso è, fuor di dubbio, il progetto dove risulta più pertinente la parola «jazz», risacca delle ondate d’avanguardia che avevano increspato «How Many Clouds Can You See» (Deram, 1969). Colpisce, rispetto alle opere successive, la presenza del pianoforte (in Mock Orange, brano evocativo di una suggestiva atmosfera, che non avrebbe stonato, già allora, nel catalogo Ecm) e delle percussioni, oltre alla moltitudine di fiati, tastiere e sovraincisioni (Jynjyg, Outside The Scorpion e Walrus). Il titolo e la foto di copertina rimandano chiaramente a luoghi e percorsi della memoria, iniziando ad adombrare la tematica del ritorno.
«Westering Home» è un disco che, riascoltato oggi, rivela ancor più la sua importanza. Non solo – e non tanto – perché è il primo passo di un percorso che all’epoca rappresentava una novità ma piuttosto per l’enunciazione, sia pure ancora parzialmente acerba o disorganica, di tutti gli elementi estetico-artistici già indicati, quasi l’arsenale di un giovane (e già sapiente) trovarobe. In esso inizia dunque a delinearsi quel mélange di jazz, temi tradizionali, folk reale e immaginario che poi verrà messo a punto nei titoli successivi, diventando cifra stilistica. Esso è, fuor di dubbio, il progetto dove risulta più pertinente la parola «jazz», risacca delle ondate d’avanguardia che avevano increspato «How Many Clouds Can You See» (Deram, 1969). Colpisce, rispetto alle opere successive, la presenza del pianoforte (in Mock Orange, brano evocativo di una suggestiva atmosfera, che non avrebbe stonato, già allora, nel catalogo Ecm) e delle percussioni, oltre alla moltitudine di fiati, tastiere e sovraincisioni (Jynjyg, Outside The Scorpion e Walrus). Il titolo e la foto di copertina rimandano chiaramente a luoghi e percorsi della memoria, iniziando ad adombrare la tematica del ritorno.
 Con «Upon Reflection» è più compiuta la definizione di uno stile fatto di perizia strumentale, spunti personali, visioni ora legate ai luoghi, ora puramente astratte ma sempre evocative. La capacità di far dialogare le linee dei fiati sovraincisi, chiaro retaggio della pratica in big band (ma anche di Sos, trio di ance i cui membri erano peraltro tutti polistrumentisti), caratterizzerà d’ora in poi tutti gli album di Surman. Nelle note di copertina viene rammentata un’altra delle esperienze formative di Surman: la collaborazione, a partire dal 1974, con la danzatrice e coreografa statunitense Carolyn Carlson, per balletti inscenati all’Opéra di Parigi e altrove; i brani Edges Of Illusion (1) e The Lampligther sono ispirati e composti appositamente nel solco di quel sodalizio. Non vi è alcun modo di dubitare dell’originalità della pozione distillata dal druido Surman, se si considera che in Prelude And Rustic Dance sono riproposti alcuni loops e ostinati già uditi nei primi anni Settanta nel trio formato da Surman con Jack Bruce e Jon Hiseman. Infine, in Constellation, ritorna la passione di Surman per gli arpeggi.
Con «Upon Reflection» è più compiuta la definizione di uno stile fatto di perizia strumentale, spunti personali, visioni ora legate ai luoghi, ora puramente astratte ma sempre evocative. La capacità di far dialogare le linee dei fiati sovraincisi, chiaro retaggio della pratica in big band (ma anche di Sos, trio di ance i cui membri erano peraltro tutti polistrumentisti), caratterizzerà d’ora in poi tutti gli album di Surman. Nelle note di copertina viene rammentata un’altra delle esperienze formative di Surman: la collaborazione, a partire dal 1974, con la danzatrice e coreografa statunitense Carolyn Carlson, per balletti inscenati all’Opéra di Parigi e altrove; i brani Edges Of Illusion (1) e The Lampligther sono ispirati e composti appositamente nel solco di quel sodalizio. Non vi è alcun modo di dubitare dell’originalità della pozione distillata dal druido Surman, se si considera che in Prelude And Rustic Dance sono riproposti alcuni loops e ostinati già uditi nei primi anni Settanta nel trio formato da Surman con Jack Bruce e Jon Hiseman. Infine, in Constellation, ritorna la passione di Surman per gli arpeggi.
 «Withholding Pattern» nella foto di copertina sembra alludere ancora una volta a reminiscenze legate a luoghi fisici. Tali luoghi tuttavia non si disvelano apertamente nei titoli dei brani, come altrove avvenuto, trasfigurandosi piuttosto in immaginifiche astrazioni musicali. O forse sono legati a un percorso abilmente celato, come lascerebbe intendere il titolo dell’album. In Doxology si presenta, per la prima volta in modo così chiaro, un pensoso rimando alla musica sacra, che tornerà in opere successive, non necessariamente solitarie. Notevoli sono le parti al sax baritono e al clarinetto basso (All Cat’s Whiskers And Bee’s Knees, The Snooper), che fanno riflettere sull’assoluto controllo da parte di Surman delle possibilità espressive della propria formula, colte appieno nella continua interazione tra gli strumenti, i loro multipli sovraincisi o echeggiati e i fondali campionati, costante spunto per ulteriori ripartenze improvvisate. Holding Pattern II sembra voler trasportare l’ascoltatore in una sorta di spirale, in cui il percorso surmaniano rimane solo accennato e si fa misterioso, benché rimanga fonte di una sollecitazione emotiva diretta.
«Withholding Pattern» nella foto di copertina sembra alludere ancora una volta a reminiscenze legate a luoghi fisici. Tali luoghi tuttavia non si disvelano apertamente nei titoli dei brani, come altrove avvenuto, trasfigurandosi piuttosto in immaginifiche astrazioni musicali. O forse sono legati a un percorso abilmente celato, come lascerebbe intendere il titolo dell’album. In Doxology si presenta, per la prima volta in modo così chiaro, un pensoso rimando alla musica sacra, che tornerà in opere successive, non necessariamente solitarie. Notevoli sono le parti al sax baritono e al clarinetto basso (All Cat’s Whiskers And Bee’s Knees, The Snooper), che fanno riflettere sull’assoluto controllo da parte di Surman delle possibilità espressive della propria formula, colte appieno nella continua interazione tra gli strumenti, i loro multipli sovraincisi o echeggiati e i fondali campionati, costante spunto per ulteriori ripartenze improvvisate. Holding Pattern II sembra voler trasportare l’ascoltatore in una sorta di spirale, in cui il percorso surmaniano rimane solo accennato e si fa misterioso, benché rimanga fonte di una sollecitazione emotiva diretta.
 In «Private City» – album sognante, di rara delicatezza, che esprime forse nel modo più pieno, fin dal titolo, la privateness surmaniana – ritorna anche la musica per balletto: la splendida Portrait Of A Romantic e Not Love Perhaps erano state composte per la rappresentazione dalla quale l’album trae il titolo. Le eteree filigrane disegnate da Surman drappeggiano l’aria, delineando melodie incantate (On Hubbard’s Hill), intense e dolenti (The Wanderer), mentre la sua maestria nell’esplorazione del timbro, arricchito dai flauti dolci, ammalia, escludendo radicalmente ogni possibile apparentamento con le più pigre forme di ambient music, imperanti nelle mode coeve.
In «Private City» – album sognante, di rara delicatezza, che esprime forse nel modo più pieno, fin dal titolo, la privateness surmaniana – ritorna anche la musica per balletto: la splendida Portrait Of A Romantic e Not Love Perhaps erano state composte per la rappresentazione dalla quale l’album trae il titolo. Le eteree filigrane disegnate da Surman drappeggiano l’aria, delineando melodie incantate (On Hubbard’s Hill), intense e dolenti (The Wanderer), mentre la sua maestria nell’esplorazione del timbro, arricchito dai flauti dolci, ammalia, escludendo radicalmente ogni possibile apparentamento con le più pigre forme di ambient music, imperanti nelle mode coeve.
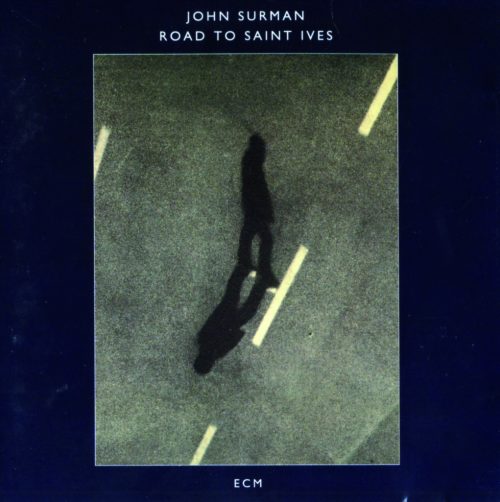 «Road To Saint Ives» torna a palesare l’interesse per la musica sacra (esplicito in Tintagel) ed è caratterizzato (se non nel senso dell’esplicita descrizione, che Surman espressamente nega nelle note di copertina) da un’evocazione nominalistica di luoghi della Cornovaglia e del loro spirito, riemergente come da vorticosi brandelli di memoria. Introspettivo e quieto, si segnala per l’alternanza tra brevi cammei bucolici (Polperro, Lostwithiel, Kelly Bray) e per le maggiori complicazioni consentite dall’elettronica (Trethevy Quoit, Perranporth, Bedruthan Steps). Contiene, probabilmente, alcune delle migliori parti di sax soprano mai suonate da Surman.
«Road To Saint Ives» torna a palesare l’interesse per la musica sacra (esplicito in Tintagel) ed è caratterizzato (se non nel senso dell’esplicita descrizione, che Surman espressamente nega nelle note di copertina) da un’evocazione nominalistica di luoghi della Cornovaglia e del loro spirito, riemergente come da vorticosi brandelli di memoria. Introspettivo e quieto, si segnala per l’alternanza tra brevi cammei bucolici (Polperro, Lostwithiel, Kelly Bray) e per le maggiori complicazioni consentite dall’elettronica (Trethevy Quoit, Perranporth, Bedruthan Steps). Contiene, probabilmente, alcune delle migliori parti di sax soprano mai suonate da Surman.
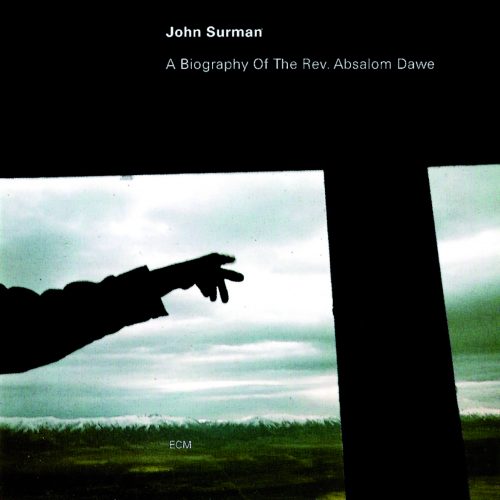 Lo splendido «A Biography Of The Rev. Absalom Dawe», dedicato a un remoto avo di Surman, è composto (tornando ad attingere allo stesso armamentario espressivo, ora arricchito dal timbro del clarinetto contralto) dalla consueta serie di pannelli, accostati con rinnovata originalità. L’opera è tra le più evocative, sebbene il narratore non possa esserne altri che Surman, che ne possiede il filo conduttore interiore e può così alternare il sacro (A Monastic Calling, ’Twas But Piety) al profano (Druid’s Circle), creare accostamenti a più voci (la delicatissima Three Aspects, per sax soprano), invitare l’ascoltatore a percorrere strade sconosciute (The Long Narrow Road, Wayfarer), forse senza approdo (The Far Corners).
Lo splendido «A Biography Of The Rev. Absalom Dawe», dedicato a un remoto avo di Surman, è composto (tornando ad attingere allo stesso armamentario espressivo, ora arricchito dal timbro del clarinetto contralto) dalla consueta serie di pannelli, accostati con rinnovata originalità. L’opera è tra le più evocative, sebbene il narratore non possa esserne altri che Surman, che ne possiede il filo conduttore interiore e può così alternare il sacro (A Monastic Calling, ’Twas But Piety) al profano (Druid’s Circle), creare accostamenti a più voci (la delicatissima Three Aspects, per sax soprano), invitare l’ascoltatore a percorrere strade sconosciute (The Long Narrow Road, Wayfarer), forse senza approdo (The Far Corners).
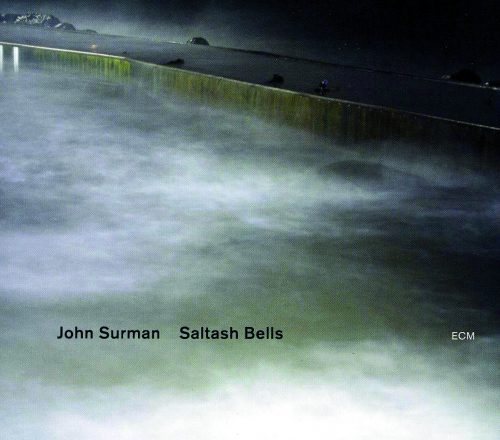 Infine «Saltash Bells» risulta forse l’opera in cui è più apertamente evidente il flusso dei ricordi. Essi restituiscono le consuete visioni incantate, inframmezzate da brani più incalzanti. Alla panoplia di Surman si aggiungono il tenore, il clarinetto contrabbasso e l’armonica. L’autorevolezza del solista è ai suoi massimi livelli esprimendosi con grande serenità, senza l’aggiunta di una nota di troppo. Alle più consuete stratificazioni sui fondali programmati (Whistman’s Wood, On Staddon Heights, Winter Elegy) si aggiungono brani a cappella (Glass Flower, per clarinetto basso, Ælfwin, per sax baritono), mentre Triadichorum intreccia in sovraincisione tre baritoni. Nel brano eponimo si ascoltano appunto le campane di Saltash, in Cornovaglia, mentre la cavalcata finale di Sailing Westwards sovrappone, tra gli strumenti, anche il suono dell’armonica.
Infine «Saltash Bells» risulta forse l’opera in cui è più apertamente evidente il flusso dei ricordi. Essi restituiscono le consuete visioni incantate, inframmezzate da brani più incalzanti. Alla panoplia di Surman si aggiungono il tenore, il clarinetto contrabbasso e l’armonica. L’autorevolezza del solista è ai suoi massimi livelli esprimendosi con grande serenità, senza l’aggiunta di una nota di troppo. Alle più consuete stratificazioni sui fondali programmati (Whistman’s Wood, On Staddon Heights, Winter Elegy) si aggiungono brani a cappella (Glass Flower, per clarinetto basso, Ælfwin, per sax baritono), mentre Triadichorum intreccia in sovraincisione tre baritoni. Nel brano eponimo si ascoltano appunto le campane di Saltash, in Cornovaglia, mentre la cavalcata finale di Sailing Westwards sovrappone, tra gli strumenti, anche il suono dell’armonica.
È persino superfluo sottolineare l’enorme talento di cui Surman è dotato: le opere in solitaria rappresentano soltanto piccola parte della sua carriera (caratterizzata da una discografia tanto nutrita nei numeri – invero impressionanti – quanto multiforme). Tuttavia è una parte d’importanza tutt’altro che secondaria, per varie ragioni: innanzi tutto, attraverso gli album in solo ha trovato piena espressione il profondo radicamento surmaniano nell’«attitudine culturale» specificamente propria degli anni Sessanta, in cui si è inizialmente formato, innervata dalla bulimica urgenza di «sapere quanto più possibile su tutte le opzioni musicali disponibili» (2). L’argomento va letto nella sua proiezione oggettiva: non è né secondario, né frutto di un’ubbìa di Surman ma è legato a doppio filo alla questione nodale dello sviluppo autonomo di un jazz «europeo». Rispetto a tale questione, sia gli anni di maggior frequenza per le solitarie divagazioni surmaniane (gli Ottanta), sia la definitiva scelta della partnership discografica di Ecm non rappresentano opzioni casuali (3).

Come icasticamente osservato da Mike Westbrook, primo bandleader e sodale di Surman: «Everybody loved the jazz that came out of America, of course, but when we came to play it ourselves, it somehow came out differently. We developed our own personalities» (4). Ma, in aggiunta, la manciata di album in disamina offre, in una chiave di lettura squisitamente soggettiva, scorci fortemente personali della poetica di Surman, delle sue attitudini e dei suoi percorsi formativi, tali da consentirne un inquadramento di privilegiata sintesi, in una sorta di volontaria messa a nudo di fronte al proprio pubblico: Surman si rivela lasciando che sia la musica a parlare di sé. Ecco dunque emergere, nel progressivo disvelarsi di un’emozionante e caleidoscopica tavolozza, il giovane corista studioso del National Song Book, le conseguenti influenze in termini di folkish tinge, il clarinettista in erba cui vengono inculcati il senso dell’intonazione e la ricerca del buon suono, il solista torrenziale e intenso ma anche il disciplinato componente di big band, il creatore di fondali musicali per balletti mediante il ricorso all’elettronica (nel quale parte della critica ha voluto vedere una parentela filosofica con Terry Riley, peraltro espressamente negata da Surman in un’intervista a The Wire [5]). Perciò, se la sua specificità autoriale è in questo intreccio tra (cercata) identità e luoghi, così frequentemente evocati proprio nelle opere solitarie (come spesso fatto palese dalla titolazione dei dischi e dei brani), Surman finisce per celebrare un certo genius loci prettamente europeo o, se si preferisce, una personale «memoria emotiva» (6), interazione di luogo e di personalità, secondo il detto popolare per cui «You can take the man out of the place, but you can’t take the place out of the man».
Surman ha elaborato negli anni uno stile del tutto personale, ove si fondono indiscusse capacità tecniche, una inconfondibile voce strumentale, seppure declinata attraverso una moltitudine di strumenti, la capacità di uso e di pieno dominio (tale da fugare il rischio di appiattimento creativo) dell’elettronica, un personale vissuto. Ciò nel quadro della nascita, dello sviluppo e del definitivo consolidamento di un linguaggio musicale nuovo, seppure non privo di radici, pertinente a una definita area continentale. Perciò la sua musica è anche una sintesi delle sorti del jazz europeo (e ciò spiega la convinta adesione al manifesto estetico dell’Ecm). Per di più, nelle opere solitarie ha pienamente rivelato al pubblico se stesso, il proprio gusto per strutture musicali reiterate, per gli arpeggi, per sonorità elettroniche, echi, sintetizzatori, ampliando così la propria tavolozza espressiva forse più di quanto abbia potuto fare in un dialogo con partner reali. L’eccezionalità di questo evento è ben comprensibile a fronte della smisurata area coperta dai suoi interessi, tale da far ritenere questa epifania ai limiti dell’impossibile. Il risultato, che resta comunque frutto di un ragionato atteggiamento complessivo, non è soltanto soggettivo, poiché comporta anche l’affermazione di una specifica heimat, che trascende i modelli di partenza. Così Harry Carney e John Coltrane saranno sempre sullo sfondo, sebbene Surman abbia saputo trascenderli dando prova della propria originalità ed essenza europea, in una peculiare sintesi di suono e scrittura.
Sandro Cerini
Note
(1) Che all’inizio cita apertamente un altro brano icona dell’etichetta bavarese, quello eponimo del disco «Azimuth» (1977) del trio Wheeler-Taylor-Winstone.
(2) L’osservazione è di Steve Lake, «Dalla Swinging London all’Ecm», in Musica Jazz n. 5/2001, pag, XXXVIII.
(3) Al riguardo si legga Alessandro Achilli, «Ritorno alla Swingin’ London», in Musica Jazz n. 11/1999, pag. 20 e seguenti.
(4) Ibidem, ove peraltro la citazione appare tradotta.
(5) thewire.co.uk/in-writing/interviews/john-surman.1. Sono state consultate anche le due interviste che si trovano in johnsurman.com/?page_id=72.
(6) La locuzione è usata da Filippo Bianchi, «Un bardo celtico prestato al jazz», in Musica Jazz n. 5/2001, pag. XXXVI.
