Patrizio Fariselli: un disco nuovo tutto suo e una ristampa degli Area, passato e presente si intrecciano in modo inestricabile quanto paradigmatico
Lo spunto per questa chiacchierata è l’uscita simultanea, a fine 2018, di due cd che ti riguardano: il tuo nuovo album, «100 Ghosts», e la ristampa di «1978 gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano!» degli Area. Partirei dal primo, che rispetto a tue cose passate appare più eterogeneo, con tanta carne al fuoco, tante diverse sonorità, per cui volevo chiederti come l’hai concepito e impaginato, se ci sono pezzi magari composti in un ampio arco di tempo…
C’è dentro quasi un anno e mezzo di lavoro. Io decido di fare un disco quando ho accumulato sufficiente materiale. A quel punto comincia a profilarsi la possibilità di documentarlo. È una prassi che abbiamo sempre praticato anche con gli Area, nel senso che si lavora, si producono cose nuove, poi qualcosa si scarta e qualcosa si conserva. Cosa mi è rimasto impigliato in questo caso nella rete? Il risultato di alcune mie passioni, essenzialmente convergenti nella ricerca sulla musica arcaica paragonabile alle ricerche di Dylan Dog, svolte quasi sul nulla. Già mi ero misurato in passato con la musica greca antica, di cui sono rimasti solo alcuni frammenti su papiro, con delle lacune bestiali, quindi praticamente niente. Anche se sappiamo leggere le note, altezza e durata, e conosciamo magari anche il tono in cui venivano eseguite, non sappiamo la cosa più importante per un musicista, cioè come suonava, il suo carattere. Un tentativo filologico è stato compiuto diverse volte. Il più importante è quello di Atrium Musicae di Madrid. Lì trovi tutti i frammenti, molte lacune colmate, con una buona possibilità di corrispondenza al vero. Ma la musica greca antica è niente rispetto ad altre musiche, di tradizione orale. Ecco perché citavo Dylan Dog: bisogna sviluppare la sensibilità di captare i residui fossili di musiche arcaiche presenti nelle musiche moderne. È questo che mi diverte e mi attrae. Nel caso specifico, ho recuperato un pezzo ritrovato su una tavoletta di argilla tra le rovine di Ugarit, scritto in caratteri cuneiformi, roba di 3500 anni fa. Ma anche lì attraverso qualche ipotesi più o meno ardita si riesce a ricostruire qualcosa.
Come sei arrivato a questi reperti?
Non è così complicato, anche per la penuria di materiale esistente, per cui se entri in una data ottica ci arrivi. Oggi su internet si trovano cose altrimenti impensabili da reperire. Una grande fonte d’ispirazione per me è stata poi Musica dal profondo di Victor Grauer, il primo a introdurre la musica come strumento di ricerca del movimento di popoli e culture. Finora si usava la linguistica, ultimamente la genetica, poi si è iniziato a incrociare i dati, riuscendo a ottenere una mappa dei movimenti della specie umana. Grauer introduce la musica tra questi elementi di ricerca, con un azzardo estremamente motivato e meraviglioso, dal mio punto di vista di musicista. Quindi se lui riconosce nello jodel tirolese un residuo fossile degli jodel pigmei, c’è un filo che li lega, benché non ci sia nulla di più diverso di un lucertolone biondo con i pantaloni di pelle e un pigmeo della foresta pluviale. Questo filo è appunto la musica. Ecco allora che nella Danza del labirinto che è il secondo brano del mio cd trovi una canzone greca scritta non più di un secolo fa che puoi sentir cantare nelle osterie, anche con una melodia propria, ma su uno schema e una scansione ritmica che risalgono alle antiche danze pre-labirinto architettonico, a carattere orgiastico, riferite al labirinto in quanto convoluzione, una danza spiraleggiante in 5/4 lento usata come prologo al compimento dell’atto sessuale. Queste sono le cose che mi divertono e che ritrovi nella metà dei pezzi, cinque su dieci. Chiaramente non tento nessun approccio filologico, ma prendo le mie responsabilità. La mia è la voce di un artista contemporaneo che spende la sua parola per fare della musica che abbia dentro della vita. Ecco perché fin dal titolo del disco cito questi fantasmi che vengono da un tempo immemorabile e ai quali diamo un corpo ricostruendo delle emozioni assolutamente contemporanee, perché questo è il gioco, il concept dell’album.

Ecco, appunto: perché questo strano titolo, «100 Ghosts»?
I cento spettri? Nel disco c’è un brano con questo titolo, ispirato a una ricorrenza giapponese, che si chiama appunto «la marcia dei cento spettri». Secondo la leggenda, un giorno all’anno, d’estate, attorno a mezzanotte, questi strani esseri scendono per le strade a ubriacarsi e a fare scherzi pesantissimi alla gente. Per contrastarli si deve recitare un mantra. Questa è la storia, che mi ha molto divertito, per cui ho scelto appunto questo titolo per un brano che è una sorta di inno, molto irruento, quasi onomatopeico, che del resto ben si attaglia al concetto globale del disco, questo dar carne agli spettri che vengono dal passato, per cui l’ho allargato all’intero lavoro, il cui altro elemento distintivo è che per la prima volta faccio delle cover. Io che ho sempre suonato solo musica mia, qui ho inserito due brani di autori che adoro, John Coltrane e Joe Zawinul. Il lavoro su tali materiali è estremo. Di Giant Steps, per esempio, sono andato a cercare lo schema geometrico alla base della sua costruzione, esasperandolo al massimo, individuandolo nel numero 3: movimenti di triadi, salti di terza. C’è un gioco armonico con cui apro il pezzo, una scalata di triadi esatonale che si sovrappone al movimento dei bassi di Coltrane e determina la chiave di lettura di tutto il pezzo e l’improvvisazione che si sviluppa di conseguenza. Tutto il resto è estremamente dilatato dalle toniche, dando l’impressione di quello che c’è, ma senza spiegarlo. Quindi massima ambiguità ma al tempo stesso massimo rigore.
C’è poi un altro pezzo, Aria, la cui intro è una palese riproposizione di Creuza de mä di De André, persino nello strumento protagonista, la gaida tracia. Un omaggio, una citazione, o che altro?
Nulla di tutto ciò. Negli anni Settanta, quando c’interessavamo di quella che si sarebbe poi chiamata world music, io e Demetrio Stratos, rivolgendo lo sguardo a Oriente invece che a Occidente, lui a riscoprire le sue origini e io a trovarne per altre vie, amavamo un disco in particolare, «I flauti greci», della collana francese Arion, che produceva lp di grandissima qualità, nello specifico un’antologia con dentro due brani popolari della Tracia, uno, Paidushka, per flauto e tamburo, l’altro, Aria pastorale, appunto per gaida, che è esattamente quel brano lì, che Mauro Pagani ha preso pari pari piazzandolo in testa a Creuzä de ma, cosa che io neppure sapevo.
Non avevi mi sentito Creuza de mä?
No. I due brani che ho citato, negli anni Settanta li abbiamo ascoltati allo sfinimento, perché li amavamo alla follia, riconoscendovi un potere evocativo enorme, per cui a un certo momento ho deciso che dovevo metterci le mani sopra, e quindi il brano specifico l’ho imparato a memoria e l’ho risuonato il più possibile vicino all’originale con una gaida campionata. Da lì è partita la mia versione, riprendendo il tutto con le tastiere, i bassi, il duduk armeno, poi il pianoforte, l’improvvisazione, tutto un gioco che ho sviluppato alla mia maniera, come pure Paidushka, una danza sciamanica, anche qui col flauto campionato, con qualche veleno che fa capire che è finto, anche se di regola la mia filosofia è rifare l’originale il più verosimile possibile. Altrimenti non lo suono, oppure chiamo uno strumentista in carne e ossa. Però questo gioco mi dà la possibilità, tirando fuori il mio portatile, di rifare qualcosa di credibile, con gande puntiglio, imparando a usare quei dati suoni. Quindi se suono un pezzo alla gaida, devo diventare un suonatore di gaida.
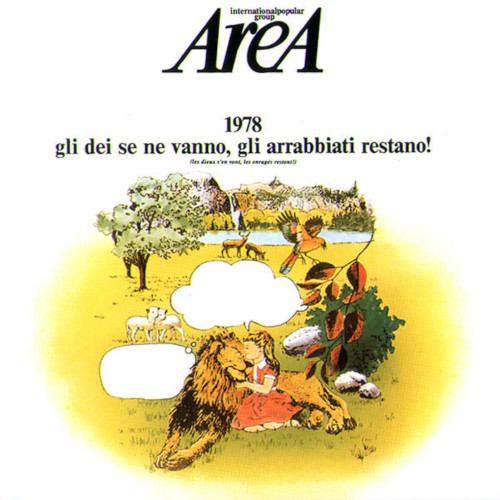
Magari la difficoltà può essere che qui devi diventare uno strumentista a fiato, cosa che magari sei anche, o sei stato.
In effetti ho sempre suonato il clarinetto basso. In tutti i dischi degli Area c’è sempre qualche mia nota al clarinetto basso.
Il che ci induce di passare all’altro cd, la ristampa di «1978», appunto degli Area. Il motivo è solo il quarantennale, o ce ne sono altri?
No: i quarant’anni, se vuoi uniti al mio rapporto con la Warner, e quindi l’idea di far coincidere il mio nuovo lavoro con questa ristampa, per un’uscita doppia.
Stiamo parlando fra l’altro dell’ultimo album degli Area con Demetrio Stratos, prima della sua uscita dal gruppo seguita nel giro di poco dalla sua improvvisa scomparsa. Oltre tutto la formula era particolarmente asciutta: lui alla voce e tre soli strumenti, tu alle tastiere, Ares Tavolazzi al basso (e in alcuni casi al trombone) e Giulio Capiozzo alla batteria. Fotografami rapidamente il disco nel suo contesto storico.
Era un periodo di grande transizione perché uscivamo dalla parte monolitica, molto agguerrita, del nostro lavoro con la Cramps, in quintetto, ma di fatto con un elemento in più, Gianni Sassi, non solo il nostro discografico ma uno che, pur non occupandosi mai della musica – visto che, a differenza per esempio di un Manfred Eicher, non ha mai messo il becco su una nota – determinava però profondamente le strategie del gruppo oltre a essere, con lo pseudonimo di Frankenstein, coautore dei testi. Quindi Gianni Sassi ha introdotto nel lavoro di un collettivo di ragazzi abbastanza scalmanati il metodo, il rigore. Ci ha costretti a sederci periodicamente intorno a un tavolo a ragionare sulle varie problematiche, un approccio per me entusiasmante, mentre altri lo trovavano meno entusiasmante, tipo Eddie Busnello, jazzista puro, molto più nature, che non a caso è rimasto poco con noi. Di fatto, peraltro, un po’ tutti scalpitavamo, perché ci sentivamo un po’ rinchiusi nel nostro piccolo ghetto di sinistra estrema da cui volevamo saltar fuori, per esempio mettendo il naso oltre l’Italia, il che spesso ci era negato proprio per motivi politici, per esempio dal mercato anglo-americano per titoli tipo Luglio agosto settembre nero, provocatorio, certo, ma senza per questo inneggiare a certe realtà: volevamo discutere della tragedia di un popolo, senza reticenze, senza fare confusione.
Chi aveva edito in origine questo album, oggi ristampato appunto dalla Warner?
La CGD di un’esordiente Caterina Caselli, che già dimostrava di avere naso, perché in quello che era un po’ il suo giocattolo, la collana Ascolto, già aveva fatto incidere Pierangelo Bertoli…
Peraltro suo concittadino, sassolese come lei.
Certo, però stava dimostrando di avere coraggio. Magari, essendo alle prime armi, non sapeva ancora bene come gestire una patata bollente come gli Area, fra l’altro con l’uscita di Demetrio subito dopo quel disco e poi la sua morte, l’anno dopo.

Certo, giugno 1979. Una morte assurda, rapidissima.
Sì, è stata una cosa terrificante, svoltasi di fatto nel giro di un mese. Quando sono venuto a sapere che era in ospedale ed era grave non ci potevo credere, perché Demetrio era una roccia, un uomo pieno di energia. Era ancora in Italia, poi quando si è reso conto che non ci capivano niente ha provato la carta estrema degli Stati Uniti, ma non è cambiato nulla.
Negli ultimi tempi il vostro rapporto come si era evoluto?
È stato un convergere di situazioni, nel senso che io, Demetrio e Paolo Tofani abbiamo partecipato tutti alla Diverso della Cramps, collana di musica contemporanea, Demetrio con «Metrodora», Paolo con «Indicazioni», io con «Antropofagia», riedito non molto tempo fa, con mia grande soddisfazione, da Sony.
Disco in solo, vero?
Disco in solo, di sperimentazione pura, anno 1977. Ciò per dire che questa spinta individuale di pura ricerca era molto viva in seno al gruppo. Demetrio in particolare partecipò anche a un disco di John Cage, entrando quindi in contatto con lui. In un modo stranissimo, fra l’altro, al di là di averlo conosciuto a Milano per l’incisione: durante un’intervista alla radio, l’intervistatore chiese a Cage se poteva mettere musica sua in sottofondo mentre parlavano. Cage storse un po’ il naso perché non amava queste cose, ma accettò. Non riconobbe la musica ma si entusiasmò e volle proseguire l’ascolto. Il disco era appunto quello con Demetrio, un Cramps del 1975. Tramite questo episodio, Cage e Demetrio sono entrati in contatto. Demetrio è andato a New York e lì si è trovato di fronte il gotha della musica mondiale, perché in quel momento la storia della musica passava da Cage. Ciò determinò l’intensificarsi della sua attività solistica e il conseguente allontanamento dal collettivo, subito dopo l’incisione proprio di «1978». Capì che la sua strada era quella e abbandonò il gruppo. Poi, qualche mese dopo, si ammalò.
E voi come avevate gestito questa sua defezione?
Ma, vedi, contemporaneamente a questa tensione di Demetrio verso la ricerca sulla voce pura, c’era da parte mia, di Ares e di Giulio il desiderio – per così dire – di colmare delle lacune, dando corpo alle nostre origini jazzistiche, la nostra anima più profonda. Ares e Giulio avevano già inciso un disco in trio con Martial Solal [«7+4=X», PDU, 1975] e tutti volevamo sviluppare questo profilo. Non a caso inglobammo Massimo Urbani, Marco Pellacani, più tardi Larry Nocella. Insomma: ci mancava un tratto di strada, che volevamo completare. Il jazz è sempre stato il motore della nostra indole creativa, attraverso cui macinare musiche di altri ambiti, perché provenendo dal jazz tutto è più facile.
Cosa che non apparteneva a Demetrio.
Gli apparteneva meno, perché comunque aveva anche una multi-provenienza piuttosto strana: nato ad Alessandria d’Egitto da genitori greci, scuole inglesi, per cui era quasi di madrelingua inglese (dovevi sentire come cantava il repertorio di Ray Charles!), poi l’Italia…
Quindi per voi la ricerca di una nuova voce non è stata così stringente?
Assolutamente no: volevamo vivere per intero la nostra fase strumentale. Del resto la voce nei nostri lavori è sempre stato uno spazio che Demetrio si è conquistato coi denti, perché la vocazione strumentale del gruppo era totale. I primi tempi la convivenza era un problema, tanto che Demetrio suonava molto l’organo, dividendo con me e Paolo gli oneri armonici. Ma lui ha vissuto la sua vocalità sempre da strumentista e quindi, a parte rare eccezioni, la voce in quanto tale è sempre stato un po’ un inserto. Soprattutto dal vivo, macinava musica a trecentosessanta gradi, era un centrocampista totale, con l’organo, la voce… I suoi interventi non erano quasi mai quelli di un cantante canonico.
Tra le vostre frequentazioni jazzistiche rientra anche Steve Lacy, musicista straordinario non sempre valutato quanto meriterebbe. Vuoi fissare i contorni di questa collaborazione?
Tutto è nato in una fase particolarissima, durante la registrazione di «Maledetti», il nostro quinto disco, anno 1976, in un momento in cui diciamo che c’era un po’ di maretta fra i membri storici. Basso e batteria, Ares e Giulio, si erano allontanati temporaneamente, per rientrare dopo qualche mese. Comunque la progettazione del disco è stata fatta da me, Demetrio e Paolo. Quindi siamo arrivati in studio incidendo un paio di brani con la formazione storica, perché li avevamo già elaborati in quel modo, altri pezzi con una nuova ritmica con Walter Calloni alla batteria e il giovanissimo Hugh Bullen al basso elettrico, e in più tutta una sezione con gli ospiti più disparati, tipo i fratelli Arze, baschi, con cui abbiamo inciso per esempio l’intro di Gerontocrazia, Steve Lacy, che fra l’altro in quell’introduzione suona pure lui, Paul Lytton con tutti i suoi ammennicoli, Eugenio Colombo… In quel momento ci viene chiesto un concerto all’Università Statale: il gruppo non c’è, ma al concerto non vogliamo rinunciare, per cui partiamo da un’indicazione data a suo tempo da John Cage all’Art Ensemble of Chicago, un concerto in cui suonare ognuno per conto suo senza ascoltare minimamente gli altri, input in buon parte disatteso dall’Art Ensemble, venendo con loro a prevalere l’estetica di gruppo, il che aveva indotto Cage a commentare «è difficile essere liberi». Partiamo di lì ma rivoltiamo un po’ la cosa, scrivendo degli stati d’animo su dei foglietti che distribuiamo a caso ai vari musicisti, con cambio ogni due minuti. Tutto ciò agendo completamente liberi, senza badare a cosa suonassero gli altri. Questa era la scommessa. Per fare ciò abbiamo allestito un gruppo assolutamente anomalo: Lacy, Lytton, Tofani, Demetrio e io al piano, anche preparato, senza contrabbasso. E lì, attirato fraudolentemente dalla presenza di Lacy, c‘era anche il vostro direttore Arrigo Polillo, rimasto intrappolato dalla gran massa di gente e costretto a sentire tutto il concerto. Peraltro apprezzandolo anche. Tempo dopo è venuta fuori la registrazione, edita dalla Cramps col titolo «Event ’76». L’ho risentita proprio di recente.
Torniamo all’oggi. Hai appena pubblicato «100 Ghosts», Area è rinata anni fa come entità per forza di cose diversa dal passato… Insomma: cos’hai in agenda?
Sostanzialmente due quartetti. Uno si chiama Area Open Project, per distinguerlo sia dall’International Popular Group originale che da Area Reunion, a cui ti riferivi tu, con Paolo, Ares e Walter Paoli, a volte UT Gandhi, alla batteria. Questo progetto mio conserva la matrice del nome Area pur circuitando solo attorno a me. In realtà anche Paolo chiama così i suoi concerti in solo, duo o trio. Del resto lui è quasi sempre in India, Ares si dedica ormai solo ai suoi progetti di jazz acustico, per cui di fatto Area Reunion non esiste più. Questo Area Open Project porta in giro buona parte del repertorio storico (a maggio saremo in Giappone) con una formazione che oltre a me comprende Walter Paoli alla batteria, Marco Micheli al basso, acustico ed elettrico, e Claudia Tellini alla voce, uno strepitoso mezzosoprano che canta i brani di Demetrio in tonalità originale. Poi il concetto di Open ti dice come siamo aperti a eventuali apporti di musicisti disposti a misurarsi col repertorio storico e cose nuove. Claudia Tellini compare anche nell’altro quartetto, che al momento deve ancora debuttare, con Caterina Crucitti al basso elettrico e Giovanni Giorgi alla batteria. Con questo gruppo porterò in giro «100 Ghosts» e i suoi futuri sviluppi.
Alberto Bazzurro
