Per tentare solo di accostarsi ad una biografia musicale straordinaria (nel senso letterale di fuori dal comune) come quella di Barbara Hannigan, vincitrice del Polar Prize 2025 insieme a Herbie Hancock e ai Queen, può essere utile partire da un po’ lontano. Un po’, per dire: mille anni. Perché la Hannigan scorrazza scioltamente dalla musica medioevale a John Zorn, quando dirigendo orchestre, quando prestando la sua stupefacente qualità di soprano, quando facendo ambedue le cose contemporaneamente e anche quando compone e riarrangia musiche lontanissime. Nulla di ciò che abbia suono le è estraneo, mantenendo la medesima qualità e lo stesso spirito passionario in ogni percorso intraveda disponibile. Fondamentalmente un fenomeno rarissimo; non a caso il Polar, probabilmente il riconoscimento più prestigioso al mondo (equivalente al Nobel), consegnato a Stoccolma dalle mani del Re, è nato sotto l’idea ferma di Stig Anderson per cui «la musica non ha confini: tocca, influenza e cambia il mondo». E ora, per sommi capi, la breve storia promessa, che parte nel 1100 d.C. circa e che finirà con la lunga conversazione che Barbara Hannigan ha regalato a MJ.
«La musica risveglia nell’uomo il ricordo e la nostalgia dell’armonia di cui godette prima della caduta». Hildegard Von Bingen, vulcanica monaca benedettina e naturalmente propensa alla pluralità dei saperi come fatto distintivo dell’umanità, risponde così per le rime a papa Anastasio, che la rampognava per la sua condotta, più incline all’apertura verso l’esterno del monachesimo che non al destino di clausura delle religiose medievali. «Colui che è grande e senza macchia abita un’umile dimora e possiamo vedere un miracolo e formare lettere sconosciute e pronunciarle in una melodia sconosciuta», aggiunge. Santa Ildegarda abbraccia in pieno l’idea di enciclopedismo (in greco, educazione circolare) e non lascia branca della conoscenza fuori dalla sua curiosità. La musica e il linguaggio sono una piccola parte del suo lascito dottrinario, eppure la sua Symphonia harmoniae caelestium revelationum (Sinfonia dell’armonia delle rivelazioni celesti) ha una ampiezza desueta per il tempo, a partire dalle sessanta antifone per l’anno liturgico. Ora, scrisse Peter Dronke (medievista tedesco di prima fila) nel 1985, «Symphonia è un concetto chiave per lei: indica non solo l’armonia dei suoni creati dalle voci e dagli strumenti, ma anche l’armonia celeste e l’armonia intima dell’uomo. L’anima, per Ildegarda, è sinfonica e questa caratteristica si esprime tanto nel raccordare anima e corpo, quanto nel fare musica». È quella che i tedeschi chiamano stimmung, la consonanza, per cui la musica è insieme terrestre e celeste.
E lo spirito di consonanza è il filo rosso che unisce con forze equipotenti la debordante creatività di Hannigan, che in una agenda fittissima di direzioni, concerti, masterclass da un capo all’altro del mondo, riesce a registrare anche una perla come «Electric Fields» (ottavo cd per Alpha Classics) con Katia e Marielle Labéque al piano e la complicità elettronica di David Chalmin, dove – appunto – si incontrano, in apertura e chiusura dell’album, due riarrangiamenti di Hildegard Von Bingen, alla quale si deve anche l’invenzione della curiosa «lingua ignota» (Hannigan ne canta una versione nell’album, con musiche di Chalmin). Si tratta di un vero e proprio linguaggio sconosciuto, volto a raggiungere scopi utopistici, eterei e spirituali, strettamente correlati alla musica. E se linguisti e medievisti ancora si scervellano per cavar fuori il senso di quei segni magici (per grafia, morfologia e sintassi) di Ildegarda, nella rilettura di Hannigan sembra tutto più vicino, ragionevole, contemporaneo.
La musicista, nata ad Halifax in Nova Scotia cinquantaquattro anni fa, sotto il segno della tenacia e della socievolezza del toro (a dar retta a Dante), è ciò che di più lontano si può immaginare dal divismo. La si può vedere rispondere nel modo più coerente e pertinente alle domande, mentre cammina in un giardino fiorito, si prepara per la sua corsa quotidiana nella natura, pensa a cosa abbia funzionato o non funzionato nella direzione della London Symphony pochi minuti prima, annota spunti mentre parla, tira fuori un baton da direttrice da non si sa dove, muove continuamente le mani come a dirigere anche i pensieri, cambia occhiali, sorride spigliatamente dalla bolla di bellezza musicale che si è creata con tenacia. Fin da quando, ragazzina, trasferitasi a diciassette anni a Toronto, ha studiato come una matta canto, pianoforte, composizione, direzione, con l’unica convinzione che etichette e generi siano il male assoluto per chi voglia accostarsi al fenomeno musicale. E, in barba a chi la ascrive al club della musica colta contemporanea, risponde che vorrebbe pranzare con Haydn, canta Hildegard Von Bingen, si diverte tra Ligeti e Poulenc, Pergolesi e Gesualdo da Venosa, rilegge Gershwin (l’album per Alpha del 2017 «Crazy Girl Crazy», con la relativa suite, è imperdibile) ed è musa di Zorn, che per lei – come tanti altri compositori – ha scritto nuovissime pagine di musica per il nuovo millennio.

Miss Hannigan è un grande piacere averla nel nostro giornale. È difficile non partire dalla splendida notizia del Polar Prize 2025, che le è stato meritoriamente assegnato insieme a Herbie Hancock e ai Queen («yeah!» e sfodera le corna rock, ndr). Come ci si sente e che ha in comune con loro?
È bello esserci, grazie! Che significa vincere il Polar? Hmm, vediamo. Quando mi hanno comunicato che avrei avuto il premio sono rimasta talmente scioccata da non avere alcuna reazione. Era notte ed ero in tour cantando Zorn e Messiaen, me ne sono andata a letto, l’unica cosa che volevo fare era dormire. Poi la mattina dopo, quando ho aperto gli occhi, il primo pensiero è stato: «e ora che faccio?». Mi ricordo ancora quando nel 2004 lo ha vinto György Ligeti, che è un musicista fondamentale per me. Sono rimasta scombussolata, commossa e ho ripensato al mio percorso che non è stato sempre semplice, anzi piuttosto poco ortodosso, ma certamente interessante, la maggior parte delle volte addirittura divertente, fatto di lavoro duro. Poi non ho scoperto subito chi avesse vinto con me e sono rimasta a chiedermelo per un bel po’ di tempo finché non mi hanno detto che erano loro due. Wow! Io ammiro in un modo pazzesco Herbie Hancock, è l’inventore assoluto di tantissime cose, un musicista che ha aperto strade poi diventate molto popolari e scovato sentieri più di nicchia, ma tutte – proprio tutte – sono rimaste nel tempo. Lo ascolto e mi chiedo: ma cosa fa qui? E in quest’altro punto? La sua influenza sugli altri musicisti è stata straordinaria. E poi i Queen. Cioè, una roba da matti a pensarci. Conoscevo molto bene il loro album «A Night at the Opera», un disco fuori schema, e lo feci ascoltare a un direttore molto moderno e aperto come Ryan Berti Leo, che è stato mio mentore. Dev’essere stato una decina d’anni fa, glielo feci sentire perché volevo che capisse la struttura e la complessità di quello che stavano facendo. Me lo ricordo ancora seduto a casa mia, ad Amsterdam, e poi fare: «Capisco bene cosa intendi, c’è una fenomenale complessità e stratificazione della musica, è sorprendente la libertà che riescono a guadagnarsi». Quello che lega noi tre, probabilmente, è insomma l’idea di essere autentici con noi stessi, che a mio parere è la cosa principale per chi fa questo mestiere.
Il vantaggio di avere un talento come il suo è anche poter avere tanti compositori interessati a scrivere nuova musica, il che è un bene per avere repertori nuovi in futuro. Che requisiti deve avere una partitura per piacerle?
A essere sincera, molte volte non so neanche bene dove andrà a finire una certa composizione, se entrerà in una première internazionale o cos’altro. Non conosco bene da prima le intenzioni o cosa stanno scrivendo e, soprattutto, non è che possa dir loro: «Scrivimi un pezzo così e così». Accade e basta, diversamente da altri pezzi che scelgo di cantare o dirigere come le sinfonie di Haydn (vado pazza per lui), ma anche Bartók o Sibelius. Il punto è che qualunque cosa io scelga deve avere una profonda, passionale connessione al ritmo, una struttura che sia come una architettura. Deve essere un edificio che mi invogli a passarci del tempo e del quale voglio esplorare ogni angolo, sia la prima volta che lo abito che quando ci torno, perché mi invoglia a capirne di più. E quindi, per tornare alla domanda, se chiedo a qualcuno di scrivere musica per me o se scelgo un repertorio esistente è perché so di affidarmi a qualcosa di autentico; non mi interessa affatto quale sia lo stile, non è quello il punto, mi piace ogni tipo di musica. Credo che sia qualcosa che diceva anche Mingus, giusto?
È così. In effetti, curiosando tra i suoi appuntamenti da qui a un paio di mesi, suonerà con cinque orchestre diverse e con repertori che vanno da Pergolesi a Poulenc a Prokof’ev. Cambiando spesso situazioni, in che modo spiega ai suoi colleghi la visione, il suono che vuole ottenere?
Quando lavoro con i musicisti, utilizzo molto le metafore. Termini drammaturgici, riferimenti emotivi: la natura, l’amore, la passione, le relazioni umane, gli animali, le questioni spirituali. Non mi piace parlare in termini tecnici ai miei colleghi, quelli li sanno già. Invece se mi riferisco a un qualche fantasma misterioso che torna da una parte nascosta della loro memoria, della loro storia, allora sapranno capire come suonare ed è quello che voglio da loro: che trovino il modo per tirare fuori in modo creativo il suono che gli sto chiedendo. Spesso gli canto le cose, specie se si tratta dei violini o degli ottoni. Canto loro l’accento o l’articolazione che ho in mente; insomma, cerco semplicemente di sollecitare questa forma di costante interrogazione creativa, senza dirgli cosa fare.
Non sempre, ma nella storia molti direttori d’orchestra provengono da studi pianistici, il fatto di avere uno strumento melodico come la voce la aiuta ad avere una sensibilità diversa nei confronti dei singoli strumentisti e non solo quella d’insieme?
In effetti, credo che essere una cantante aiuti molto nel lavoro, anche solo per il fatto di poter mostrare le mie idee attraverso l’uso del respiro; inoltre non c’è partitura sul pianeta che non abbia momenti in cui utilizzi indicazioni scritte per i musicisti, pensa al «cantabile»; è come si avesse la necessità di cantare attraverso i singoli strumenti. Ciononostante, ho studiato pianoforte da quando avevo cinque anni, oboe da quando ne avevo nove. In conservatorio ho studiato composizione, tutte queste cose fanno parte della mia formazione, anche se il canto è la mia parte più profonda d’anima.
Dovrebbe avere novant’anni per tutte le cose che ha fatto!
È il motivo per cui ho vinto il Polar Prize, tu non lo sai ma ho centocinquant’anni…
Le direzioni d’orchestra, nel tempo, hanno avuto declinazioni completamente diverse. C’è chi ha definito l’orchestra come la società perfetta e democratica in cui il direttore è un primus inter pares, chi l’ha interpretata in modo quasi tirannico e autoritario. Toscanini, Von Karajan, Celibidache, Harnoncourt, Abbado, tutti hanno avuto modalità diverse di avvicinarsi ai grandi ensemble. Quale è la sua idea di buona orchestra?
Nella mia esperienza, ogni orchestra è diversa e tutte hanno un equilibrio e gerarchie sottilmente differenti, le une dalle altre. Ci sono dinamiche e meccanismi che inevitabilmente si creano e si strutturano, al di là del fatto che ne siano consapevoli i musicisti. Se dirigo a Londra, Losanna o a Santa Cecilia incontro sempre un ecosistema diverso e questo per me è interessantissimo. In primis, a livello psicologico, perché devo ogni volta rispondere alla domanda: qual è il ruolo del direttore? Allora, a mio giudizio la temperatura dell’orchestra in qualche modo comanda e quindi il ruolo del direttore deve essere in una condizione, come dire, di flessibilità. Occorre domandarsi di cosa hanno bisogno e quando ne hanno bisogno, cosa non vogliono e cosa non gli serve. Non dargli cose in più se non ne sentono la necessità, se non sono affamati non nutrirli, se hanno bisogno d’acqua allora dargliela. Molti hanno bisogno di un gran pasto e di tante attenzioni: bisogna dargli attenzione. Questo è ciò che domanda la musica. Alcune volte, pure, hanno bisogno di più tempo per comprendere la mia visione e hanno bisogno che «scompaia» in qualche modo; ci sono casi in cui possono essere ispirati dalla gestualità o dalle più disparate stramberie. Detto questo, in generale, se mi conosci, so essere molto collaborativa, ma so anche quando occorre dominare. So farlo. La direzione d’orchestra è una specie di formazione continua, apprendere nel tempo con apertura, come auspicabilmente chiunque dovrebbe fare. Siccome le variabili sono molteplici e tutto cambia di continuo, ciò che è importante è farsi trovare in uno stato di costante «libertà». E poi serve stabilire una forte connessione. Una cosa che dico spesso è: abbassare la forza di gravità, spostare il peso della gravità, abbassare la dinamica, non alzarsi… come se fosse un magma, come se ci trovassimo nel suono che immagini si possa produrre nel centro della terra. Poi, quando troviamo la nostra gravità, allora diventa tutto come una danza e noi siamo i ballerini; si possono fare tutte le mosse, si può volare in alto. Ma non puoi volare in alto, se non sei partito bene dal basso.
Tra l’altro, nella direzione, spesso le capita di scardinare le regole classiche nell’uso del baton, che è una innovazione ottocentesca. Alle volte sembra più riferirsi agli usi medioevali e rinascimentali in cui il direttore (se c’era) non usava strumenti per ammorbidire il suono o dare indicazioni di tempo.
È vero, le mie mani sono particolarmente espressive. Questo è perché non mi piace avere il baton in mano, perché appena lo afferri, impedisci al resto della mano di fare altri movimenti più utili. Se faccio questo movimento (tira fuori un baton come un coniglio dal cappello magico e mostra i gesti classici, ndr) è perché sto indicandoti dove entrare o dove uscire. Per me il punto di entrata e di uscita può essere la punta del dito o anche il palmo, ma voglio che guardino quello, non la bacchetta.
Nel frattempo, tra una direzione e l’altra, ha trovato modo di curare l’uscita di questo nuovo «Electric Fields» con Alpha Classic, che ha registrato qualche tempo fa. Si ha l’impressione che ci siano tre grandi musiciste (lei, Katia e Marielle Labéque) per tre grandi compositrici della storia: Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi e Giulia Caccini. Sono tutte donne molto forti, coraggiose, testarde, si direbbe …
Ecco! Non ci avevo mai pensato in questi termini: sono testarde! Aspetta che lo annoto nel mio taccuino (tira fuori un taccuino come un coniglio dal cappello magico e scrive, ndr), perché hanno tutte questa caratteristica. Hildegard l’ho conosciuta che avevo diciannove anni, credo di aver registrato qualcosa con le sue musiche per un film. Ha alcune caratteristiche che per me sono molto interessanti: il modo di pensare, di sentire, di inventare il suo proprio linguaggio. Come fanno John Zorn o Claude Vivier: inventano i loro linguaggi. È qualcosa che accade anche con i lessici familiari, io per esempio ho un gemello e quando eravamo piccoli con mio fratello avevamo le nostre parole esclusive. Nel caso dell’album, eravamo alla ricerca di musica interessante, non intenzionalmente diretta a trovare donne, poi la scelta è caduta su Giulia Caccini e Barbara Strozzi, che è un vero portento, una bomba di energia. Come lo sono Katia e Marielle, che hanno una inedita capacità di restare energetiche anche dopo tanto tempo. Insieme abbiamo costruito una specie di «triangolo del potere» che, come sai, può essere davvero intenso.
A Barbara Strozzi (1619-1677) è dedicata Improvisation nell’album, rielaborata dal suo «Che si può fare?». Che cos’è per lei l’improvvisazione, che certo non è un’esclusiva del jazz, ma viene direttamente dalle musiche antiche?
Esatto, ci tengo che tu lo abbia ricordato. L’improvvisazione non è una specie di indulgenza, che ti libera per suonare ogni tipo di cosa. Riuscire a farla in modo autentico richiede un grande sforzo di comprensione su ciò che si è, sugli aspetti del proprio ego. Quando qualcuno sta improvvisando, sta parlando da solo, sta prendendosi spazio o sta creando un dialogo fatto di domande e risposte? Perché solo in questo ultimo caso instauri una conversazione. Anche la musica, come il linguaggio, ha la sua quota di retorica e alcune volte ti capita di incontrare una persona che domina la conversazione o che resta passiva. Quello che a me interessa è lo scambio e se eseguo Haydn porto l’orchestra a conversare come ai tempi in cui visse. Se vuoi suonarlo, ci devi parlare, serve che tutti parlino quella lingua, anche perché lui, come dire, ti risponda; sono una specie di sottotesti invisibili che scorrono nella musica. Quindi, per me, l’improvvisazione è una pratica con cui ho dimestichezza sin da bambina: lo facevo per ballerini, altri musicisti, gruppi micro-tonali. Non facevamo jazz, ma c’erano musicisti che avevano la mentalità jazz, però suonando una musica diversamente moderna. Poi ho abbandonato quella pratica per lungo tempo e ad oggi non improvviso praticamente più. È accaduto però, nel 2015, di registrare un album di musica completamente improvvisata con Massimo Pupillo (bassista, compositore, fondatore degli Zu, ndr) che uscirà il prossimo anno e da allora ho ricominciato a improvvisare, lo faccio anche con John Zorn.
Com’è lavorare con Zorn?
Straordinario. Ho lavorato con John per otto anni e lui ha scritto sei pezzi per me. Ho girato con Zorn per festival jazz, ma ho anche inserito le sue composizioni nei miei repertori destinati a spazi per la classica. Ne ho fatto anche una specie di mix e l’ho presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto, insieme a Ches Smith e Jorge Roeder ed è stato bello. Ha la caratteristica di essere spiazzante, di non poter essere incasellato in alcun modo e questo perché ha una sua potentissima luce interiore, personale; quella energia è stata molto potente per me, devo dire che ha aiutato molto il mio percorso artistico.
Questo consente di ricollegarci al suo rapporto con l’elettronica in musica e le prospettive legate allo sviluppo dell’AI. Tra l’altro lei ha lavorato con Stockhausen e il suo ultimo «Electric Fields» fa ampio ricorso all’elettronica, grazie anche a David Chalmin, che è un egregio tecnico del suono.
Devo dirti che sull’AI non ho sviluppato un’idea precisa, perché probabilmente non l’ho ancora capita, e tutta la musica che faccio è destinata a essere eseguita dal vivo, anche le volte che facciamo ricorso all’elettronica. Però resto convinta che la postazione di guida resti tutta in capo all’umanità. Sono sicura che potrà essere utile in alcune applicazioni, ma – ancora una volta – saranno gli uomini a dirigerne i processi; quindi, il tutto dipende dalla natura delle persone che la stanno sviluppando e quali siano i loro obiettivi. Inutile dire che la storia ci ha insegnato che nei progressi tecnologici ci sono finalità nobili, generose e costruttive, così come anche fini costruiti sull’avidità e al servizio dei soldi e del potere. Tra l’altro, parlavamo prima proprio di Herbie Hancock, che è stato uno dei primi ad utilizzare una certa elettronica in musica ed è stato anche molto criticato al tempo, ma se riesci ad essere padrone degli strumenti disponibili il risultato può essere interessante, nuovo.
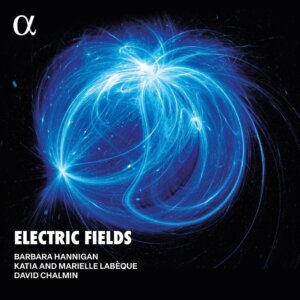
Si tratta sempre di lavorare sui confini delle possibilità. Chissà se c’entra anche l’ambiente in cui si vive e si nasce. Lei è nata in una punta di Oceano Atlantico ad Halifax, in Canada, e vive a Finistère in Bretagna, praticamente sulla sponda opposta di mare. La sua creatività è influenzata dal vivere in punti «estremi» del mondo?
Lo è certamente e anche molto. Non ho necessariamente bisogno di essere circondata dalla natura, ma ho bisogno di avere dello spazio intorno. Torno a Finistère ogni volta che posso e, anche se solo per tre giorni, so che ci tornerò col batticuore. Lì sono circondata dal verde e ho davanti una vista molto ampia sia davanti sia alle spalle di casa. Vedo tutte le strade che scendono verso l’acqua, sarà un percorso di un chilometro e mezzo circa. E vedo la marea che va e viene, mi piace guardare come quegli elementi della natura si sviluppino, cambino. Vedi, anche adesso, alla fine della nostra chiacchierata, andrò a fare la mia corsa: faccio lo stesso percorso ogni giorno, ma non è mai lo stesso, è completamente diverso. Devi saper cogliere le differenze con lo sguardo e cambiare sarebbe inutile: sono i dettagli per me a essere interessanti. Certamente i confini, poi, sono una specie di porto da cui parte la libertà di immaginare e sviluppare la curiosità.
Quanto ad elementi della natura, Electric Fields si riferisce ai campi elettromagnetici in cui il campo di forze che si crea fa sì che ogni particella carica sia attratta da un’altra. Questa continua fissità e mutazione della gravitazione è la stessa che percepisce nell’evoluzione della storia della musica, per cui dal Rinascimento ad oggi agiscono le medesime forze trasformate?
Questo che chiedi è interessante, mi piace questo modo di fare connessioni, non ci avevo pensato ma è giusto. Cioè i campi elettronici creano un’attrazione. Lo stesso avviene nell’elettricità statica, che pure è un campo. Una cosa ne attrae un’altra, che ne attrae un’altra ancora e così via e quindi ti ritrovi a creare una specie di «kosmos» costruito sull’attrazione. E così può capitare, a un certo punto della tua carriera, di trovarti in un punto dove non avevi intenzione di andare, ma per qualche motivo ci sei. Almeno questo accade a me. Per lo più lavoro su questa sorta di attrazione verso qualcosa e degli elementi tra di loro.
Un paio d’anni fa è stata chiamata a ricoprire il prestigioso ruolo di Reinbert de Leeuw Professor of Music della Royal Academy of Music di Londra. Quindi mi domandavo quanto sia stato importante nella sua formazione Leeuw e che cosa significhi per lei insegnare.
Reinbert era musica allo stato puro, al mille per cento. Aveva un modo ininterrotto di calarsi sempre più a fondo dentro il suono. Era al servizio della musica e dei compositori. Aveva il suo modo di lavorare e non era mai critico verso i metodi di altri suoi colleghi, ma ribadiva sempre «ho solo questo modo di fare musica e non posso cambiarlo». Ecco, un altro testardo nella mia vita! Però quel suo approccio è stato di grandissima ispirazione per me, tutte le volte che abbiamo avuto modo di fare musica insieme. Vedi, il suo senso dello spazio e del tempo era davvero particolare: non era metronomico e questo per lui era molto importante. Alle volte, mi veniva da chiedergli: «Ma dov’è il tempo qui?», perché non aveva un modo di segnarlo convenzionale e mi rispondeva: «Barbara, mi raccomando, nessun tempo!»
Come note continuamente coronate?
Sì e no. Semplicemente non c’era una scansione da metronomo. Stavo lavorando allo Stabat Mater di Pergolesi e a un certo punto della partitura, per dirti la sua importanza, ho proprio annotato «no tempo». Quel momento musicale doveva essere liberato, come se in qualche modo stesse a noi musicisti creare qualcosa di nuovo, qualcosa di simile all’improvvisazione: nessun tempo, nessun recinto. Certo può essere difficile per direttore e musicisti, ma si riesce a farlo. E se avviene, se si riesce a creare quel respiro comune allora davvero hai soddisfatto la necessità del mistero dentro la musica; ovviamente il tempo c’è, ma è come se non volessi farlo sentire.
E l’insegnamento?
Riesco ad andare alla Royal Academy due o tre volte all’anno e faccio masterclass con compositori e ogni genere di strumentista, ovviamente molti cantanti e proprio pochi giorni fa ho fatto un concerto con l’Orchestra e dirigerla è stata un’esperienza bellissima. Il nostro è uno scambio continuo, perché io imparo da loro e loro da me. Mi piace osservare i loro volti quando iniziamo a lavorare insieme, quando realizzano il fatto che non voglio bravi scolari, di quello non mi interessa nulla, voglio che siano creature creative. Avviene come uno scossone, quando capiscono che li sto sollecitando ad essere vivi, sedersi, sorridere o reagire emotivamente all’opera su cui stiamo lavorando. Questo è il modo migliore per tirare fuori tutto ciò che possono come musicisti ed è qualcosa di molto stimolante, perché non sono le solite scatolette predefinite che trovi a scuola per avere buoni voti. I voti non importano, anche se so, per esperienza, quando ho studiato e lottato per avere il massimo, ma alla fine non interessa a nessuno dei risultati scolastici, interessa il risultato. Certe volte li vedo anche preoccupati perché la Hannigan sta dicendo queste cose…
Spostandoci sull’altro polo della fruizione musicale, cioè il pubblico, come costruisce i suoi repertori, che alle volte possono essere molto «sfidanti»? La musica astratta e contemporanea può suonare anche respingente.
Sì, certo, e naturalmente penso al pubblico. Però, con il passare del tempo, diciamo da quando avevo diciannove anni a oggi, ho costruito gradualmente un rapporto con chi mi ascolta e ho capito quanto importante fosse sviluppare una specie di relazione di fiducia con le persone. Metto nei miei repertori solo musica per la quale provo una passione intensa e ho pieno affidamento sul fatto che questo sentimento rimbalzerà sul pubblico e avrà una controreazione. Ci sono, mi seguono, vengono in viaggio con me, insieme agli altri musicisti. Poi, sai, è una questione di cosa risulti sfidante o respingente per ognuno di noi; siamo onesti, una Sinfonia di Bruckner può esserlo moltissimo, perché spesso si tratta di moduli ripetitivi. Credo che sia importante creare qualcosa che si amplifichi nel tempo e nello spazio, che le persone si dicano: «mai sentito nulla del genere prima! Dove stiamo andando? Dove ci sta portando?»; questa è la parte emozionante per me, portarli dentro qualcosa di sconosciuto.
Devo dire che vederla raccontare opere anche complesse con i video sui suoi canali social è straordinariamente magnetico. Crede sia importante utilizzarli per avvicinare meglio il pubblico a ciò che lo attende?
Io credo di sì, voglio dire che il modo in cui la musica racconta una storia è diverso da ogni altra forma di narrazione. Tutto quello che serve fare è osservarla in silenzio, come fosse una immagine visuale, poi tornare da quell’immagine alla musica, che dà concretezza alla percezione di quell’immagine. È un fenomeno straordinario, è il motivo per cui penso che la musica sia un’arte sacra, molto spirituale; anche per questo le culture antiche avevano una profonda connessione con essa e ne sviluppavano i contenuti proprio come stiamo facendo ora …
Tra i più toccanti, ho trovato il racconto del personaggio di Elle dall’opera La Voix humaine di Francis Poulenc, dandole una nuova densità, sospesa tra realtà e sogno. Nel 2021 ha fatto una sua produzione dell’opera, utilizzando tre schermi diversi che aiutano a seguire la sua interpretazione. Quanto è importante integrare le esecuzioni con una parte, diciamo così, di spettacolo, di performance?
È un’opera che amo molto e che tra qualche giorno riproporrò a Parigi. In questa produzione ogni singolo dettaglio è importante, ogni aspetto ha il suo significato. Ho scavato l’opera di Poulenc a fondo, trovando nuovi indizi luminosi, dal 2019 e poi c’è stato il debutto due anni dopo. Ogni volta che la eseguo è diversa e ogni volta mi dico che dobbiamo passare ad un livello successivo e ad un altro ancora. Non voglio mai che l’orchestra arrivi a dire: conosciamo bene l’opera e sappiamo cosa fare. Il mio compito è farli continuare a scavare, fargli vedere che c’è ancora molto lavoro da compiere, in modo che ci sia uno sviluppo continuo delle idee e della musica.
D’accordo che ha un’estensione e un timbro incredibile, ma ha una qualche tonalità preferita quando canta? Una che sente più affine alla sua anima?
Ah, che buffo… Vediamo. Ci sono alcune note che mi piacciono tantissimo: il la bemolle, ad esempio, forse è al mio top e mi piace moltissimo cantare in quella tonalità. Però anche il mi bemolle maggiore, che è tra i miei colori preferiti Anche il fa diesis minore è davvero una gran bella chiave. Poi, se ci penso, ognuna ha le sue caratteristiche e curiosità… hai presente alcune linee melodiche col do diesis? Per me sono pazzesche, perché restituiscono un senso di instabilità. Allo stesso modo, mi piace quando le armonie vanno su diminuiti o aumentati, così come mi piace ancora la musica micro-tonale, il bending, i flipping tones (note che raccordano una tonalità all’altra o fungono da passaggio da un brano all’altro, ndr).
Per concludere con una nota un po’ lieve, di curiosità… Suonando ogni repertorio della storia, c’è un periodo in cui le piacerebbe vivere per un po’?
Ce ne sono diversi! Partirei dagli anni di Gesualdo da Venosa (1566-1613) per capire bene come lavorassero allora, e poi vorrei andare a trovare Haydn e andarmene un po’ in giro con lui; mi piacerebbe vederlo a Palazzo Esterházy, dove era Kapellmeister e aveva una sua piccola orchestra. Ma con lui vorrei anche viaggiare a Londra e a Parigi. E poi mi piacerebbe visitare, però non per molto tempo, giusto una visita veloce, qualche civiltà antica come quella persiana. Lì andrei per capire meglio l’esperienza religiosa, ciò che vedevano e sentivano rispetto a questo tema e vederne lo sviluppo successivo verso lo zoroastrismo… Però, mi raccomando, non per anni e anni, al massimo qualche mese!

Quasi che quel viaggio le si potesse davvero far fare, nulla precludendo alle possibilità, abituata com’è a viaggiare nella storia, Barbara Hannigan ci saluta per la sua corsa quotidiana e tornare da Spot, Louiza ed Elizabeth Taylor, i suoi tre gatti. Cose di un altro mondo, magico.
