Un raffinato progetto dei Mercury Rev ripropone in lingua d’oggi una dimenticata pagina degli anni Sessanta
Bobbie Gentry: chi era costei? Credo che a rispondere alla domanda possano essere solo vecchi ragazzi beat della mia generazione, fiocinati un giorno del 1967 da una ballata cupa e soave capace di conquistare le classifiche, Ode To Billy Joe. A cantarla con voce da angioletta hip era una ragazza del profondo sud emigrata in California, che non aveva mai dimenticato le sue radici e lì aveva ambientato la triste storia di un ragazzo che si era buttato giù da un ponte, tra lo stupore ma soprattutto l’indifferenza di chi gli stava intorno: la canzone raccontava giusto quello, un suicidio diventato presto chiacchiera nello scorrere della vita di tutti i giorni in provincia.
Bobbie diventò una piccola star, anche perchè aveva ambizioni nel mondo della musica country e in quel territorio maschile e maschilista era difficile trovare cantautori di genere femminile. Era bella, oltre che brava, e la cosa la aiutò a muoversi con disinvoltura nel mondo del live e della tv; ma nonostante gli sforzi e le idee profuse in sette album non riuscì più a tornare ai livelli del primo hit, sfiorandoli solo quando registrò un disco con un maestro di Americana come Glen Campbell. Delusa, nel 1971 smise di pubblicare lp e dopo una fortunata parentesi a Las Vegas abbandonò le scene, gettando la sua carriera «off the Tallahatchie Bridge», sparendo come «una versione country di J.D. Salinger». Era il 1978. Chi la conosce dice che oggi vive nei sobborghi di Memphis, non troppo distante dai luoghi natali, e in realtà non fa nulla per nascondersi; semplicemente è uscita dal giro della musica, rifiuta le interviste e si gode i frutti della sua prima vita: Ode To Billie Joe è un brano che non può mancare in una compilazione Sixties che si rispetti.

Sulle piste di Fred Neil, altro illustre desaparecido negli stessi anni, irriducibile fino alla morte, Bobby avrebbe battuto probabilmente ogni record di oblio se non fosse stato per un paio di eventi che di recente hanno illuminato a giorno il suo nascondiglio. In autunno la Universal ha pubblicato (ma sarebbe meglio dire riversato, vista la mole) «The Girl From Chickasaw County», mega-cofanetto di otto cd con tutta la sua produzione Capitol e una colata di provini, inediti, alternate, nastri BBC; e giusto in queste settimane un gruppo di culto come i Mercury Rev ha deciso di tradurre a modo suo il secondo lp, il dimenticatissimo «The Delta Sweete», chiamando a collaborare un disparato coro di voci femminili perchè con Bobbie non si può fare a meno, Bobbie era soprattutto chiara voce e una specialissima forma di soul, oltre che lussuosi archi, soffici guanciali di suono, sorprendenti accostamenti in chiaroscuro.
Guai ai revisionisti, l’ho scritto tante volte. Non ne posso più di storici affreschi ripittati secondo il gusto di oggi, di giudizi consolidati mandati a gambe all’aria per voglia di andar contro o per vedere giusto l’effetto che fa. Così non sosterrò nemmeno sotto tortura che Bobbie Gentry fosse una gigantessa misconosciuta, vittima dei poteri forti discografici e della stampa cinica e bara. A risentire quelle pagine dopo il grande hit, in realtà, sembra chiaro perchè non trovò più il successo: perchè il cuore non le ispirò più un’altra Ode, sebbene ogni tanto provasse a rifarne il verso, e perchè non capì che il fascino di quella canzone stava anche nella sua sobrietà, un provino voce chitarra con appropriata punteggiatura, non proprio minimalista ma ben calibrata. Preferì arrangiamenti luccicanti, anche invasivi, seppur non privi di finezza, con digressioni verso un soul pop che il gusto dell’epoca giudicò troppo timido. Nella sua stagione di notorietà venne anche in Italia, al festival di San Remo 1968, dove cantò in coppia con Al Bano un Pallavicini-Massara assolutamente smemorabile, La siepe. Pur selezionata per la finale, la canzone affondò come un ferro da stiro; e, spiace dirlo sed magis amica veritas, la versione di Al Bano suonava meglio.

Ora, chiarite così le cose, è giusto riconoscere alla signora anche una sua originalità, concentrata soprattutto nei primi anni e in particolare quando fu il tempo del secondo lp. L’esordio era stato, inevitabilmente, Ode To Billy Joe più dieci canzoni di contorno; ma quando Bobbie ebbe più tempo e mezzi per esprimersi, 1968, inventò una singolarissima opera, «The Delta Sweete», che a tutti gli effetti era un concept album, anche se allora quel termine usava poco (si era cominciato a parlarne a proposito del «Sgt. Pepper» dei Beatles, che come è noto non è un concept album). Il disco rievocava in dodici quadri l’infanzia della ragazza nel profondo sud, prima del distacco verso la sunny California e una vita che possiamo immaginare meno chiusa, severa, provinciale. Il tono oscillava tra il nostalgico e il fiabesco, con ricordi di famiglia e di domeniche in chiesa, e l’eco di tanta musica sudista che tra la voce di Bobbie e le corde della sua chitarra perdeva peso e diventava una strana carezza, un po’ dolce un po’ ruvida. Chi all’epoca si imbatté nel disco notò probabilmente proprio quello, e ne restò più stranito che ammirato. Big Boss Man non era più il desolato lamento di Jimmy Reed che aveva incantato perfino Elvis ma una giocosa fantasia con gli archi che flirtavano con chitarre swinganti; e Parchman Farm John Mayall ce l’aveva fatta conoscere sul secondo lp Bluesbreakers con ben altre unghie e angoscia, così come i Nashville Teens e soprattutto gli Animals ci avevano consegnato una Tobacco Road sgherra e inquietante, non l’eterea creaturina modellata da Bobbie e dai suoi stilisti musicali, Jimmy Haskell e Shorty Rogers.
«The Delta Sweete» era un’opera troppo sofisticata, mettiamola così, e non fu minimamente apprezzata: gli appassionati rock soffrirono i toni soft, il pubblico del country la giudicò una stranezza. In realtà c’erano delle idee in quel disco, semini che hanno impiegato decenni a dare frutti; e mentre la ragazza della Chickasaw County si volatilizzava, qualcuno si è preso la briga di studiare le sue carte e ha trovato che quelle memorie del Delta fossero un ottimo spunto anche cinquant’anni dopo. Quel qualcuno si chiama Jonathan Donahue ed è un attempato ragazzo -anta che ha messo testa, voce e chitarra in due band di sicura fama, i Flaming Lips e i Mercury Rev. I primi li ha lasciati da tempo, i secondi continua a sostenerli dopo aver contribuito a gettarne le basi nel lontano 1991. La definizione che si dà abitualmente di loro è «psichedelia gentile»: brevi voli della mente in colorati angoli di fantasia, allucinazioni barocche o, come una volta han detto i Mercury stessi, «dreamy wonder and aural kaleidoscopia». Con un simile gusto, le orchestrazioni country di Bobbie Gentry non sono tanto lontane; e se prendiamo gli album migliori di Donauhe e compagni, «The Deserter’s Songs» (lo dicono tutti) e «All Is Dream» (lo aggiungo io), viene il sospetto che quella pista fosse ben conosciuta fin dalle origini. Negli ultimi anni i Mercury Rev si erano un po’ defilati, un album ogni tanto e neanche molto ispirati. Sembrava l’eutanasia di un gruppo, ma ecco la fantasmatica apparizione di Bobbie G: e l’idea di riprovare il suo trekking tra le terre del profondo sud, usando ancora quella mappa del 1968 senza le comodità dei GPS di nuova generazione sonora. Il risultato è sorprendente. «Bobbie Gentry’s The Delta Sweete», così si chiama il disco nuovo, non è una banale rilettura e nemmeno una nostalgica appendice ma una piccola trasfigurazione, giocando proprio sul chiaroscuro che era tipico dell’originale e con più fantasia, più respiro sonoro, più libertà cromatica. Donahue e la sua brigata di cucina musicale sono celebri per essere degli esagerati pasticceri, che alla crostata di frutta della nonna han sempre preferito sciropposi brodi di giuggiole, torte Sacher con strati di Brian Wilson, di Van Dyke Parks, di Neil Young. Qui hanno zucchero per i loro denti, con tutti i rischi del caso ma con una opulenza sonora che incanta, quel mix di musica solenne e umorale, magniloquente ed elusiva, che ha sempre distinto i loro momenti migliori.
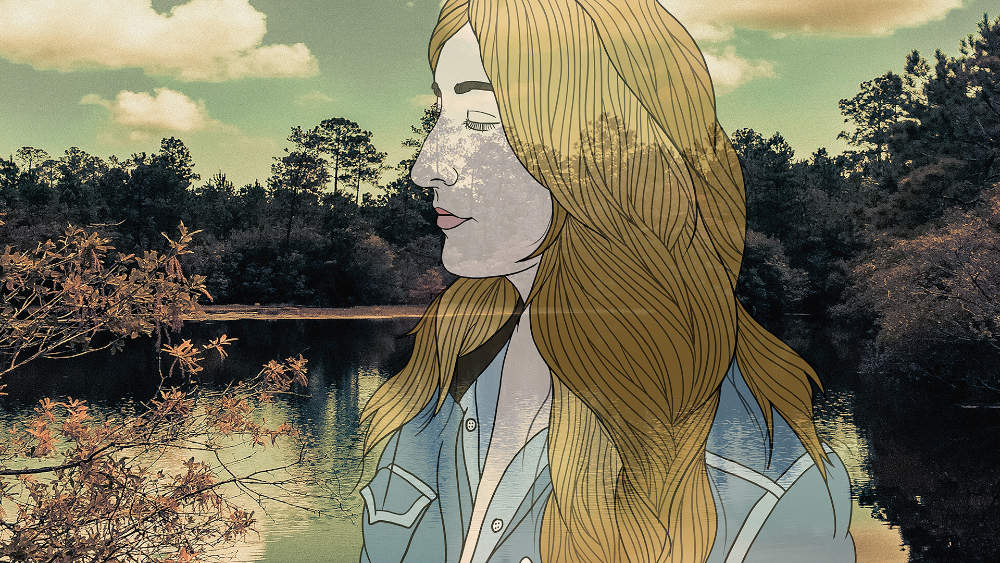
C’era lungo la via un piccolo problema, risolto brillantemente. Nel Delta di Bobbie Gentry non sono date voci maschili, e dunque Jonathan Donahue ha ceduto (volentieri) il posto e, già che c’era, ha chiamato non una sola vocalist ma dodici diverse, una per canzone: un coro di venerate icone (Lucinda Williams, Vashti Bunyan), eroine di culto (Hope Sandoval, Beth Orton, Norah Jones), giovani stelline (Margo Pryce, Phoebe Bridgers), con un ventaglio di suggestioni che vanno dall’ «acid western» al «country con cuore punk» al «gotico nordico alla Nico» (le definizioni sono di David Fricke, il guru che ha redatto le note). Un bel modo di reinterpretare il disco e, se vogliamo, una sommessa protesta; dicono le statistiche che siamo tornati anche più indietro rispetto agli anni Sessanta, che la presenza femminile nel mondo dei dischi country è scesa ormai sotto il dieci per cento.
«The Delta Sweete» finiva sulle note eteree di Courtyard, il progetto dei Mercury Rev no. C’è un dodicesimo pezzo e l’aggiunta, forse temeraria forse solo inevitabile, è Ode To Billie Joe, trasfigurata anch’essa con un po’ di archi in più, e un sitar risonante, per legarla meglio al resto del repertorio. Non è una forzatura, ci sta; tanto più che a cantarla è Lucinda Williams, una grande interprete, una degna sorellina di Bobbie Gentry, nata anche lei nel profondo sud di Lake Charles, Louisiana. Aveva quattordici anni, Lucinda, quando la Ode conquistò le classifiche, e questa ricerca del tempo perduto tra paludi, brughiere, borghi remoti e memorie potrebbe essere anche la sua.
Riccardo Bertoncelli
