Buongiorno Pierpaolo e bentornato a Musica Jazz. Cerco di riassumere: professore universitario di Letteratura Inglese e altro, che ti chiedo di definire nella risposta; contrabbassista e bassista, improvvisatore ma anche rocker old school; saggista con particolare riguardo sulla cultura pop inglese e David Bowie in particolare. La domanda non è cosa senti più vicino alla tua indole, ma: quanto riesci a fondere nella musica queste attività apparentemente diverse l’una dall’altra?
Grazie a voi Alceste per il prezioso e graditissimo invito. In realtà, ho sempre pensato alla musica in termini di narrazione e di scrittura (non di trascrizione, ma di scrittura sonora) e soprattutto di plurilinguismo di linguaggi. Si tratta di una visione che viene dalla letteratura. Del resto – come scrivevo anni fa in Mark the Music. The Language of Music in English Literature from Shakespeare to Salman Rushdie, una mia monografia dedicata a questo tema – musica e letteratura hanno molto in comune. La loro somiglianza rimanda, infatti, al rapporto di contiguità che, se ci pensi, sin da tempi remoti esisteva tra lingua e musica, sino a giungere a contesti in cui poesia e musica finiscono spesso per coincidere. La scrittura letteraria attiva processi comunicativi che in sostanza non differiscono da quelli del linguaggio musicale, dato che in entrambi i casi il detto è fondamentalmente pretesto del dire. Bachtin sottolinea poi come la parola letteraria non potrà mai appartenere a chi la utilizza; la parola letteraria è sempre parola altrui, infatti, “il poeta riceve le parole ed impara a dare loro un’intonazione nel corso di tutta la sua vita, in un processo di comunicazione poliedrica con il suo ambiente sociale.” La parola letteraria altro non è che voce della tradizione che continua a parlare, a dire nella pagina del Talento Individuale (per dirla con T.S. Eliot). In questo senso, anche il suono musicale – è sempre suono dell’altro, già ascoltato dallo strumento dell’altro, nell’altrui contesto, durante un concerto, attraverso un disco o semplicemente inseguendo un ricordo. Anche qui non si tratta soltanto di quella volontà di citare, che spesso interessa sia compositori che improvvisatori, ma di un processo imprevedibile (l’improvvisazione è, per sua natura, imprevedibile); perché è la coscienza che sceglie il suono, la nota, l’accento dell’altro, in quanto espressione chiara, precisa dello stato d’animo di chi suona o ascolta. E’ proprio questa pulsione tra passato e futuro, e questa idea di simultaneità di linguaggi, voci, stili, visioni (spesso dissonanti e che viene dalla letteratura) a definire il mio approccio alla musica.
Hai frequentazioni con diversi improvvisatori sia britannici che italiani, ma anche statunitensi. Quando hai iniziato a parlare questo nuovo linguaggio, rispetto a quello del pop-rock britannico?
In realtà, se è vero che ho iniziato ad ascoltare e a parlare il linguaggio del rock Britannico molto presto – ossia vero la metà degli anni Ottanta (e a praticarlo a partire dal 1990 con band indie quali i Clocks) – già a cavallo dei due decenni mi ero già avvicinato al jazz ascoltando Chet, Metheny e poi i grandi classici, soprattutto Miles Davis e Bill Evans. L’ unica band rock che allora continuavo ad ascoltare erano gli Smiths . Sul basso (allora usavo un sei corde) sviluppai una tecnica molto chitarristica, arrangiando brani di Metheny e Morricone per solo basso e iniziai a suonare in duo con un sassofonista tenore. In questi anni scoprii l’ ECM (e più tardi la Tzadik) e iniziai ad ascoltare (e amare) musicisti che sono poi diventati dei miei punti di riferimento ossia John Surman, Eberhard Weber, John Zorn e soprattutto Bill Frisell il cui pluristilismo e la cui trasversalità sono diventati aspetti imprescindibili del mio modo di pensare la musica. Sono approdato invece all’ improvvisazione verso la fine degli anni Novanta. Del resto qui in Puglia quelli erano gli anni di Festival quali l’Europa Jazz e delle primissime edizioni del Talos Festival, musicisti e in particolare contrabbassisti quali Paul Rogers, Bruno Chevillon (con il suo straordinario solo su Pasolini) e Joëlle Leándre (della quale frequentai una masterclass organizzata qualche anno dopo dal compianto Gianni Lenoci, con cui avrei poi suonato a lungo in duo e in trio, con ospiti quali gli americani Steve Potts e Vinny Golia) ebbero un enorme impatto su di me. Iniziai a suonare improv con il chitarrista Adolfo La Volpe, lavorando spesso con danzatori, e nel 1999 formammo una band, il Diomira Invisble Ensemble, molto attiva in ambito nazionale, al punto di diventare l’ensemble di riferimento di Eugenio Colombo per due suoi lavori «Tempiduri» del 2002, «United Front» del 2003 entrambi editi da Splasc(h) e per la colonna sonora del film Alla Fine della Notte di Salvatore Piscicelli (2003).
A Noci poi in occasione di un festival organizzato nel 2016 da due miei carissimi amici Vittorino Curci e Gianni Console – entrambi sassofonisti straordinari, con cui di recente abbiamo inciso due splendidi dischi, editi da Setola nel 2023, con ospiti rispettivamente Gunter Baby Sommer e Michel Godard (mentre a brevissimo vedrà la luce un altro lavoro registrato lo scorso Dicembre con ospite il grande Giancarlo Schiaffini) – conobbi il sassofonista Adrian Northover che mi invitò a suonare all’Iklectick di Londra in trio con il pianista anglo-russo Valdimir Miller; nacquero così i Dinner Party con cui ho inciso due dischi per l’etichetta inglese FMR Records. Adrian mi invitò poi nel 2017 a suonare con la London Improvisers Orchestra e da quel momento ho avuto la fortuna di suonare con tanti bravissimi musicisti inglesi. Due di loro, Steve Beresford e Dave Tucker, avevano tra l’altro, nei primissimi anni Ottanta, militato in celebri band postpunk, ossia ripetitivamente le Slits (di Viv Albertine) e i Fall, guidati dal grande Mark Smith. Continuo ancora oggi ad ascoltare moltissimo rock e avant-rock di band quali Radiohaed, Smile, Mogwai, Goodspeed, Sonic Youth, Wilco e Yo la Tengo. A mio avviso i due linguaggi – il jazz e il rock – sono inseparabili; forme di incontro/scontro e compenetrazione dei due linguaggi sono alla base di lavori magistrali proprio di band quali Radiohaed, Wilco e Yo La Tengo e soprattutto negli ultimi due casi l’apertura verso il noise e l’ improv ha portato ad esiti straordinari.
Cosa ti affascina dell’improvvisazione?
Direi il suo essere ovunque, ossia il suo essere un aspetto imprescindibile del nostro essere al mondo. Derek Bailey nel suo celebre studio del 1980 – Improvisation. Is Nature and Practice in Music – sottolineava come l’improvvisazione gode del curioso privilegio di essere l’attività musicale più largamente praticata e, nel contempo, la meno conosciuta e compresa. In effetti un suo tratto essenziale è il carattere sfuggente, la sua eccedenza rispetto alle singole definizioni. L’improvvisazione, poi, come notava anni fa Paolo Fabbri è la principale modalità delle enunciazioni verbali quotidiane e di buona parte di quelle artistiche, tra cui appunto il jazz. Il processo semiotico stesso di conferimento di senso a un testo letterario è poi, se ci pensi, esso stesso un processo improvvisativo, sempre imprevisto e imprevedibile. La musica improvvisata (come l’enunciazione quotidiana) vive tra l’altro della sua unicità e irripetibilità. Per molte delle persone che la praticano, una delle più grandi attrattive dell’improvvisazione è, come sottolinea Bailey, la sua esistenza momentanea; nessun documento di ciò che è stato rimane davvero; la registrazione di un’improvvisazione potrà essere sì fruita un numero infinito di volte, ma la sua riproducibilità tecnica, non potrà riprodurre il contesto di vita in cui quella si è svolta. C’è poi la dimensione del mettersi in gioco e del decentramento costante. Come sai in inglese il verbo to play fa riferimento alla musica, al teatro, ma anche al gioco; E nell’improv l’ascolto si fa gioco e viceversa permettendoci finalmente di accogliere – in senso divertito e divertente, attraverso l’incontro con l’altro, con il corpo e con il suono dell’altro – l’irrinunciabile e vitale alterità di cui siamo fatti. Nel 2023 ho tra l’altro preso parte a uno splendido progetto RAI intitolato Ur-Klang. Echi di improvvisazione in Alto- Adige, ideato dal musicista trentino Max Carbone, in cui ho avuto la possibilità di indagare in senso teorico e pratico l’improvvisazione, in conversazione con tre straordinari musicisti, ossia il violinista Marcello Fera, la pianista Rossella Spinosa e la percussionista portoghese Sofia Borges. Nelle giornate trentine è emerso chiaramente come quella dell’improvvisazione è sempre necessariamente una dia-logica in cui il musicista è invitato non solo a confrontarsi con l’altro ma ad indagare le molteplici voci e storie che abitano nella sua interiorità.

Nel 2022 esce il tuo disco con Enrico Merlin dal titolo «It’s About That Time» con Enrico Merlin che, mi sembra, ha delle caratteristiche differenti rispetto alla tua precedente discografia. Ce ne vorresti parlare?
Io e Enrico ci siamo conosciuti ad un Festival a Pompei nel 2019, io e mia moglie – l’artista e designer – Fanny Cavone presentammo un lavoro di action painting e bass improv su Le Città Invisibili di Italo Calvino e Enrico suonava prima di noi con il suo trio; dopo averlo ascoltato gli chiedemmo di prender parte alla nostra performance. Con Enrico riuscimmo immediatamente a creare uno spazio sonoro aperto, imprevedibile, una geografia urbana immaginaria, fatta di linguaggi diversi e di un modo di intendere l’improvvisazione come di-vertimento, come spostamento continuo. Ciò che definisce la nostra musica dal vivo è questa componente dialogica, questa splendida con-fusione e sovrapposizione di voci. Enrico è un musicista straordinario, un’enciclopedia sonora. A distanza di qualche mese pensando a un progetto in duo, ci siamo chiesti come e se fosse possibile fare un progetto di musica originale che però ripartisse da «In A Silent Way», album che viene spesso osannato, ma che di fatto è capito a pieno da pochi. Qui c’è il Miles musicista dell’attraversamento, e della sintesi di linguaggi musicali diversissimi. Abbiamo declinato l’intuizione di Miles in un senso del tutto nostro; oltre alla riscrittura di alcuni momenti salienti dell’album del 1969 il disco contiene nostre composizioni originali e tributi a vari ‘discepoli’ di Miles: da Charlie Haden a Eberhard Weber, da Pat Metheny a Bill Frisell. Ci interessava molto indagare a fondo il rapporto tra chitarra e (contrab)basso tra tradizione e innovazione, utilizzando suoni acustici ed elettronica e muovendoci liberamente tra i generi più diversi. Il disco intitolato «It’s about that time» pubblicato nel 2022 da Kut Music riproduce, tra l’altro, nella copertina e nel booklet due ritratti di Miles realizzati da Fanny. Abbiamo presentato il disco all’ Easy Nuts Lab di Milano e al Centro Musica di Trento nonché all’Università di Bari e al Museo della Radio di Galatone in Salento.
In che direzione sta andando la tua ricerca musicale?
Da un lato continuo a lavorare sull’interazione tra basso ed elettronica, a vari livelli; innanzitutto con il solo per contrabbasso, nastri ed electronics dedicato a David Bowie dal titolo «Ziggy Plays Bass» (nato nel 2016) e poi più di recente con «Oscillate Wildly», un tributo “immaginario”, liquido, per certi versi filmico all’universo sonoro degli Smiths per Fender VI – un basso a sei corde con accordatura E-A-D-G-B-E – ed elettronica. Avevo già utilizzato il VI (strumento a cui sono molto legato) in trio con Gianni Lenoci e Francesco Cusa per un disco intitolato «Dystopia» del 2017 (mentre con Cusa e Gianni Mimmo al sax, ossia con The Lenox Brothers, ho inciso nel 2020 un album omaggio a Lenoci scomparso, com’è noto, prematuramente nel 2019).
D’altro canto mi interessa molto la dimensione del contrabbasso suonato in acustico, in spazi aperti, e l’interazione, per certi versi in senso cageano, del suono del contrabbasso con i suoni circostanti, spesso a partire dall’esecuzione di brani per solo contrabbasso composti da Dave Holland, Chris Laurence e Barre Phillips.
C’è poi la formula del duo contrabbasso/voce a cui sono particolarmente legato e che pratico da diversi anni, nello specifico con Lisa Manosperti, con cui – oltre a lavorare su un repertorio di brani dei Radiohead in trio con il violinista degli Afterhours Rodrigo D’Erasmo – abbiamo da poco inciso un lavoro intitolato On the Wilde Side, dedicato alla mia passione di una vita, ossia Oscar Wilde e agli artisti che gli hanno reso omaggio nell’ambito della popular music (da Gavin Friday agli Smiths, da Patti Smith ai Pet Shop Boys), tema tra l’altro a cui ho dedicato l’ultimo capitolo di un mio libro intitolato WILDE NOW, pubblicato nel 2023 dalla storica casa editrice inglese Palgrave Macmillan. Più recentemente ho iniziato a lavorare con Gianna Montecalvo con due progetti musico-letterari presentati in occasione di due diversi convegni organizzati presso l’Università di Bari; il primo lavoro si intitola YES, ed è basato sulll’Ulisse di James Joyce, mentre il più recente Noises and Sweet Airs è dedicato alla Tempesta di Shakespeare, opera su cui ho lavorato anche con la collega anglista, nonché vocalist, Maddalena Pennacchia.
Ci sono elementi di connessione tra la tua ricerca in ambito universitario-letterario e quella musicale?
Sì, in entrambi i contesti ciò che più mi affascina è l’idea di praticare una fuga costante dall’identico, ossia la possibilità di abitare quella che definirei una sorta di soglia tra differenze. Wilde, Bowie e molti degli artisti che amo abitano gli interstizi tra cultura alta e bassa, tra maschile e femminile, tra accessibilità e sperimentazione. Quest’ultimo tratto è quello che più mi affascina nella musica, ovvero la possibilità di essere al tempo stesso pop e avant, di giocare con forme accessibili, con ritmi e melodie coinvolgenti, aprendoli verso il possibile e l’imprevisto. Penso ancora al primo Frisell. Sono tra l’altro da pochissimo titolare dell’insegnamento di Letteratura, Media e Popular Music per il corso di laurea DAMS del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (di cui ho la fortuna di far parte) e qui ho potuto toccare con mano l’entusiasmo di studenti (molti dei quali sono musicisti) attratti anche e soprattutto dalla mia conoscenza diretta, performativa della popular music. C’è poi l’idea della centralità delle storie, delle narrazioni, sia in musica che in letteratura, da cui eravamo partiti.

Quando improvvisi parti con un’idea preconcetta?
Parto sempre da una suggestione contestuale, da un’enunciazione che, per riprendere Bachtin, ha in sé i tratti della risposta. In ensemble quali la London Improvisers Orchestra – con cui ho inciso l’album «Twenty Years On» – soprattutto nel contesto delle conduction, ci sono invece norme ben precise da seguire, ossia segnali, gesti che rimandano ad articolazioni sonore specifiche.
In termini di espressione personale e di esperienza di performance, come si colloca il suonare da solo rispetto alle improvvisazioni di gruppo?
In solo parto dal corpo dello strumento o da una risposta imprevista dell’elettronica che utilizzo dal vivo; qui, più ancora che nelle performance in gruppo, diventa centrale il rapporto con il pubblico e lo spazio, che diventa non semplicemente cassa di risonanza ma vero e proprio interlocutore. In duo, o in ensemble più ampi, tendo generalmente a rispondere agli accenti, alle intonazioni, alla grana vocale e più in genere sonora dei musicisti con cui improvviso.
In una situazione live, le decisioni tra i creativi spesso avvengono senza parole. In base alla tua esperienza e ai suoi progetti attuali, come si presenta questo processo e come funziona?
Nelle mie improv oltre a ricorrere a rotture e decostruzioni di ogni tipo – ossia ad una dimensione per certi versi verticale del fare musica – faccio spesso ricorso a pedali, vamp, ostinati, che hanno la finalità di accogliere ma anche interrogare l’identità sonora altrui; si tratta di elementi che provengono dal mio interesse per il postpunk e che ho utilizzato ampiamente nei progetti con Steve Beresford (ossia nei Frequency Disasters in trio con Valentina Magaletti, con cui ho inciso due album per Confront), Dave Tucker e più di recente con il violista Benedict Taylor con cui – per il Time Zones Festival 2024 – abbiamo sonorizzato la versione filmica di Salomé di Wilde diretta da Charles Bryant nel 1923
In un certo senso, le improvvisazioni ci ricordano la natura transitoria della vita. Quando un’improvvisazione finisce, è davvero finita? O continua a vivere in qualche forma?
Credo che continui sempre e necessariamente a risuonare nell’afterwards, ossia in quei silenzi che mettono in rapporto i momenti più o meno lunghi in cui fai musica; e qui l’improv definisce per certi versi il tuo agire nel mondo. L’improvvisazione musicale ti insegna poi a metterti sempre e comunque in gioco aldilà di ossessioni identitarie di ogni tipo.
Pierpaolo, perché hai scelto il basso e il contrabbasso come tuo strumento di riferimento?
Il mio interesse per il basso nasce nella metà degli anni Ottanta ossia nell’ ambito della new-wave e nello specifico nel 1987 (un anno che considero centrale nella storia della popular music) in occasione della pubblicazione di album chiave di band quali Smiths, Cure e U2. Fui particolarmente colpito prima dalla funzione del basso in un album come «The Joshua Tree» (ossia del lavoro molto semplice e incisivo di Clayton sui loop di Brian Eno) e poi dal lavoro magistrale di Andy Rourke all’ interno degli Smiths. Avevo 12 anni ero alle primissime armi e le figure di Rourke pensate in contrappunto con quelle della chitarra di Marr mi sembravano inaccessibili e tuttavia estremamente “Charming” come avrebbe detto lo stesso Morrissey. C’era poi David Bowie che l’anno prima aveva pubblicato «Absolute Beginners», a casa dei miei c’era il 12 pollici che ascoltavo spessissimo in versione strumentale soffermandosi proprio sul basso. Iniziai invece a suonare il contrabbasso nel 1993 frequentando la classe di contrabbasso del Conservatorio N. Piccinni di Bari sotto la guida del Maestro Giovanni Rinaldi. In realtà iniziai a suonare il contrabbasso dal vivo solo più tardi nel 1997 soprattutto in contesti legati alla world music, ossia con band quali Pane e Rose e soprattutto Radicanto con cui incisi diversi dischi e intrapresi diversi tour. Sempre nel 1997 iniziai a suonare con il chitarrista Adolfo La Volpe con cui suono tutt’ora e con il quale ci siamo occupati di world – con il trio Fore’ che include il musicista e musicologo Massimiliano Morabito – di post-rock, e di film-music (con un recente progetto sul cinema noir in quartetto con Gianlivio Liberti e Roberto Ottaviano). Tornando al contrabbasso, posso dire di essere sostanzialmente autodidatta, sebbene abbia studiato con Maestri dell’improv quali Joëlle Leándre e Mark Dresser – a cui sono legato da un profondo rapporto d’amicizia e che ho ospitato anni fa a Bari per una splendida masterclass presso la Stanza dell’Eco (spazio culturale diretto da me e mia moglie Fanny) e Barre Phillips, il Maestro dei Maestri, scomparso lo scorso 28 dicembre.

Sei un esperto di David Bowie e hai scritto più di un libro su di lui, come accennavo in precedenza. A tuo avviso, quanto Bowie ha attinto dal jazz e quanto il jazz si è ispirato a Bowie?
Bowie ha sempre amato il jazz; fu il suo fratellastro Terry Bowie a farglielo scoprire a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta; David suonava il sassofono (sue, per esempio, le parti di sax in Diamond Dogs del 1974) e amava musicisti quali Eric Dolphy. Uno degli aspetti più affascinanti del jazz è a mio avviso la sua capacità di abitare gli interstizi, di vivere la soglia tra differenze come spazio privilegiato e sempre sfuggente di ascolto ed enunciazione. Il jazz è un linguaggio profondamente radicato in pratiche e processi complessi quali quelli di traduzione e migrazione. In sostanza il jazz è una forma di scrittura che non può essere contenuta, un linguaggio che risulta essere sempre in viaggio, traducendosi in spazio accogliente che a sua volta chiede accoglienza. Sin dalle sue origini il jazz – con la sua complessa sintesi di elementi africani ed euro-americani – sembra porsi come musica basata sull’ interplay e, in questo senso, esso ha a che fare, con la ridefinizione dell’identità in termini dialogici. Il jazz può divenire in questo senso un modello per un’interazione sociale libera e non prescritta e per la costruzione di una soggettività pienamente polifonica. Ed è per questo che il jazz risulta in grado di andare oltre se stesso dialogando, ossia muovendosi in direzione di altre forme d’ arte quali la pittura, il cinema e la letteratura. E’ proprio questo senso di attraversamento e di messa in rapporto di mondi e linguaggi diversi che definisce al meglio la filosofia dello stesso di David Bowie. Ci sono poi album di Bowie con un sound che rimanda fortemente al jazz, mi riferisco non solo al suo lavoro per la colonna sonora di Absolute Beginners ma anche a The Buddha of Suburbia (1993) , che vede come protagonista il pianista Mike Garson, già autore del celebre assolo free del brano ‘Aladin Sane’ del 1973, e ovviamente a Blackstar. Diversi sono i jazzisti che hanno lavorato con Bowie, da Pat Metheny a David Torn, da Lester Bowie a Joey Baron, Gli stessi musicisti che suonano in Blackstar tra cui Donny McCaslin e soprattutto Ben Monder esemplificano un mondo di intendere il jazz che rimanda al Bowie migliore, penso ai soundscape del periodo berlinese e una certa logica della sottrazione.
C’è un momento, in particolare, della tua vita artistica che ritieni essere stato fondamentale?
La scoperta di Bill Frisell e dell’ECM e la possibilità, di cui parlavo di recente con Melvin Gibbs, di suonare tutto con un solo strumento, ossia con il basso. Il basso come Orchestra un’idea molto cara al contrabbassista tedesco Eberhard Weber, che intitolerà così un suo disco del 1988. In termini di carriera, ti direi l’inizio del rapporto di collaborazione con gli improvvisatori inglesi di cui ti dicevo (da Northover, a Tucker a Beresford a Calude Deppa) ma ovviamente non posso che ringraziare gli straordinari musicisti italiani con cui ho realizzato importanti progetti negli ultimi 25 anni da Gianni Lenoci a Eugenio Colombo, da Gianni Mimmo a Enrico Merlin, da Adolfo La Volpe a Roberto Ottaviano, da Lisa Manosperti a Tiziana Felle, da Giorgia Santoro a Gianna Montecalvo.
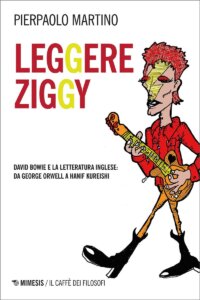
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi e i tuoi prossimi impegni?
In primavera sarà pubblicato dall’etichetta inglese Confront Recordings un album in trio con il mitico Steve Beresford e il grandissimo batterista inglese Mark Sanders dal titolo «Be S-Mart», registrato dal vivo al Bari in Jazz Festival 2024. Stiamo lavorando all’organizzazione di un piccolo tour di presentazione in UK e qui da noi.
A maggio sarà invece pubblicato da Shake – casa editrice che ha pubblicato in Italia lavori seminali come Il popolo del Blues di Amiri Baraka – un libro a cui ho lavorato per più di un decennio e intitolato: Scritti dal Basso Dieci bassisti, dieci storie per una storia Tra jazz e letteratura. Il libro si sofferma su dieci bassisti che considero tra i più influenti della storia del jazz, e da Jaco Pastorius a Charlie Haden, da Eberhard Weber a Barry Guy. Ho cercato, in breve, di tessere una storia possibile, ma necessariamente aperta e inclusiva, del contrabbasso e del basso elettrico in ambito jazz e avant, in cui il basso viene indagato attraverso diverse prospettive e pensato in termini necessariamente intermediali. Fondamentale nella scelta dei musicisti è stato il rapporto di ciascuno di essi con la letteratura, sia in quanto lettori, che scrittori; ossia l’aver composto delle opere in omaggio a – o in collaborazione con – alcuni scrittori (è il caso di Steve Swallow, Bruno Chevillon, Dave Holland, Charlie Haden, Guy, Dresser,) o l’aver composto brani o album che sanno di letteratura (come nel caso di Pastorius, Weber e Gary Peacock). Ogni capitolo mette in questo senso in rapporto specifiche composizioni di ciascun bassista con opere di scrittori quali Oscar Wilde, Thomas Hardy, James Joyce, Virginia Woolf, Samuel Beckett, Pier Poalo Pasolini, Kamau Brathwaite, Robert Creeley, Paul Auster e Yvone Vera. Attraversando i vari capitoli del libro – basati nella maggior parte dei casi su interviste esclusive realizzate nel corso degli ultimi 12 anni – ho cercato di dimostrare come ogni bassista rimanda ad altri bassisti (e musicisti in senso lato), secondo un’idea di ascolto come vibrazione rispondente e attraversamento che si nutre di un vero e proprio sapere intercorporeo, idea, quest’ultima, a cui sono molto legato.
Alceste Ayroldi
