Vent’anni dopo, eccoli di nuovo. Insieme e sempre in prima linea. Sono i tre moschettieri del jazz europeo, Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. Con il nuovo album «Mare Nostrum IV» (su etichetta ACT), il percorso del gruppo approda – è proprio il caso di dirlo – al quarto capitolo. E quello che nell’ormai lontano 2005 era cominciato come un semplice esperimento (un tris di esibizioni in Svezia in cui era stato riunito questo gruppo di star della scena del vecchio continente composto dal trombettista sardo, dal virtuoso di fisarmonica francese e dal pianista scandinavo) si è trasformato a poco a poco in un progetto continuativo e di grande successo, sia sul piano concertistico sia sotto il profilo discografico. La nuova fatica della band è una raccolta di dodici fascinosi brani, la cui paternità viene divisa in modo equo tra i co-leader. Il tutto è stato presentato dal terzetto in anteprima italiana nel corso di tre applaudite serate di fine marzo al Blue Note di Milano. Quindi la formazione ha fatto tappa in aprile a Lugano, mentre a giugno è attesa a Fiesole (il 25) e a Verona (il 28) e il 27 luglio suonerà alla Casa del jazz di Roma. È Richard Galliano a raccontarci com’ è andata e il «dietro le quinte» del lavoro. E per l’occasione ne approfitta anche per parlarci di sé e dei suoi nuovi progetti. E pure di fare un bilancio in vista di una ricorrenza importante: il suo compleanno numero 75.
Richard, il disco è stato registrato nell’autunno dell’anno scorso nello Studio La Menuiserie a Noisy-le-Sec, non distante da Parigi. Dopo tre album che hanno funzionato bene sia a livello di critica sia a livello di pubblico, avete deciso di rivedervi e di mettere a punto il quarto progetto. Com’è andata? E nel vostro approccio è cambiato qualcosa?
Permettimi di riavvolgere il nastro del tempo e di raccontare questa storia dall’inizio. Paolo Fresu e io ci siamo conosciuti una trentina di anni fa: la prima volta abbiamo suonato insieme a Napoli e quindi a Parigi, se non ricordo male . Da quel momento in poi il nostro rapporto è diventato una vera amicizia e quindi è sempre una bella sensazione ritrovarsi. L’incontro con Jan Lundgren, invece, risale a venticinque anni fa, eravamo in Giappone. Perciò abbiamo avuto l’idea di mettere in pista questo progetto a tre, registrando il primo disco in Italia nel 2007, il secondo in Francia nel 2014 (ma è stato pubblicato solo nel 2016) e il terzo in Svezia nel 2018 e uscito l’anno seguente. «Mare Nostrum IV», invece, abbiamo deciso di farlo in occasione del Giubileo e ho organizzato tutto io, scegliendo uno studio vicino a Parigi – che è casa mia, abito nel nono arrondissement – e coinvolgendo il mio fonico di fiducia Rémi Bourcereau. Non è cambiato molto rispetto alle altre sedute: ognuno di noi porta tre o quattro brani, più uno o due legati al patrimonio folclorico dei rispettivi Paesi di origine. Per esempio, nel primo capitolo io avevo scelto Que reste-t-il de nos amours, mentre nel nuovo disco ho optato per La vie en rose.
Quello con Paolo Fresu non è il tuo unico incontro con un trombettista. Da adolescente ti sei avvicinato al mondo del jazz trascrivendo gli assoli del grande Clifford Brown. E, sempre a proposito, nell’agosto del 2008, al festival Jazz in Marciac, hai tenuto un concerto – che poi è anche diventato disco con il titolo «From Billie Holiday to Edith Piaf» – insieme al quintetto di Wynton Marsalis. Insomma, tra la tua fisarmonica e la tromba esiste da sempre un’attrazione fatale.
È vero. Questa accoppiata mi piace molto: l’ho sperimentata per la prima volta con Chet Baker in un disco uscito nel 1981 per la Dreyfus, «Chet Baker & the Boto Brasilian Quartet» – che conteneva il brano Salsamba – e poi con Enrico Rava, oltre che con Wynton Marsalis. E infine con Paolo.
Tra te, Paolo e Jan, nonostante l’insolita combinazione strumentale e timbrica (fisarmonica, tromba e pianoforte), si avverte una chimica speciale. Ma quello che colpisce maggiormente è l’attitudine all’ascolto reciproco, oltre all’uso particolare degli spazi e delle pause…
Sì, l’ascolto reciproco e l’interplay tra noi tre è la cosa fondamentale. Pensa che per questo quarto disco non abbiamo fatto alcuna prova, siamo andati direttamente in studio a suonare senza avere nulla di preordinato, salvo che sapevamo quali brani avremmo eseguito. Si comincia, uno di noi esegue un accordo e lancia un’idea, che poi viene ripresa ed elaborata dagli altri due. Possiamo dire che il nostro è un vero e proprio un discorso musicale.
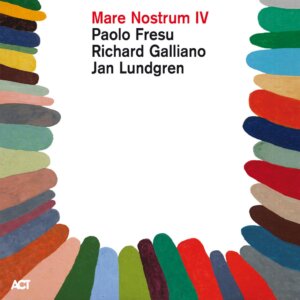
Mi pare di poter dire che ciò che vi accomuna è l’amore per la musica a trecentosessanta gradi, jazz ma non solo: nei vostri dischi e nei vostri concerti ci sono arrangiamenti di brani tradizionali, echi del folclore, riprese di temi classici (per esempio di Monteverdi, Ravel, Erik Satie), divagazioni brasiliane ed escursioni nella chanson française. E, anche se Jan Lundgren è svedese, quello che vi lega in modo particolare è la passione per la bella melodia mediterranea.
Sono d’accordo. L’amore per la melodia è la chiave della nostra partnership. Per esempio, Paolo scrive pezzi bellissimi e di grande suggestione, che sono anche molto originali a livello armonico. E il medesimo approccio vale pure per Jan. Io stesso, infine, sono un fan dei brani francesi, italiani e anche americani: insomma, mi definirei un «uomo di canzoni». Dopo improvvisiamo, naturalmente, cioè facciamo jazz. E tuttavia il punto di partenza è la chanson per me. Succedeva anche quando suonavo con Chet Baker e con Enrico Rava. Del resto loro, come pure Fresu, sono musicisti che «cantano».
Tra concerti da solo, in duo, trio, quartetto, quintetto e orchestra, hai sperimentato di tutto e di più. Ma qual è la dimensione in cui ti senti più libero e riesci a esprimerti meglio senza alcun freno e condizionamento?
Ti rispondo subito e senza alcun indugio. Dovendo scegliere, preferisco esibirmi in solo, perché così riesco a suonare tutta la musica che mi passa per la testa in quel particolare momento, senza bisogno di fare in precedenza una scaletta o un programma. Per me è la dimensione di massima libertà.
Al di là del trio con Paolo e Jan, hai anche tanti progetti. Ci puoi anticipare quali sono?
Per quanto riguarda i miei progetti ce n’è uno che mi sta particolarmente a cuore. È in arrivo la riedizione di un album che risale al 1993, «Viaggio», e che fu pubblicato allora per la Dreyfus. Sarà rieditato con un nuovo missaggio e verranno alla luce anche parecchie bonus tracks. All’epoca c’erano Pierre Michelot al contrabbasso, Charles Bellonzi alla batteria e Bireli Lagrene alla chitarra che – oltre a me – è l’unico del gruppo ancora vivo (anche il produttore Francis Dreyfus ci ha lasciati, purtroppo). Quindi il mio vuole essere un omaggio a questo gruppo fantastico e a un disco che, tra i tanti che ho realizzato – credo 75, proprio come i miei anni – è quello al quale sono più affezionato, dato che lo considero il più importante a livello musicale e anche esistenziale nella mia carriera. È un po’ come se fosse la storia della mia vita, che è sempre legata agli spostamenti e al viaggio. La nuova edizione di questo lavoro arriverà nei negozi il 3 ottobre per i tipi della Dreyfus/BMG e a seguire farò una tournée con altri musicisti per rendere omaggio a quella seduta così importante: al mio fianco ci saranno Adrien Moignard alla chitarra, Philippe Aerts al contrabbasso e Yoann Serra alla batteria, la nouvelle vague del jazz francese. Per me è stata veramente una grande emozione ascoltare le bonus tracks del disco, pezzi che avevo del tutto dimenticato e che trovo assolutamente fantastici.

Il 12 dicembre soffierai su 75 candeline. E, se non ricordo male, sei in pista nelle sale di registrazione dal 1979, cioè da 46 anni. Proviamo a riavvolgere il filo della memoria: che ricordo hai del tuo primo disco, «Joue Ravel & Debussy»?
Ricordando quel disco, la cosa strana – o se vuoi la… tragedia – è che io dentro mi sento lo stesso ragazzo di un tempo! Eppure fisicamente non è così, il mio corpo è invecchiato, anche se sono piuttosto in forma, quindi è una sensazione assai bizzarra. E, a proposito del mio compleanno, ti anticipo che festeggerò suonando con questa formazione al New Morning di Parigi: un posto del cuore, per me, una sala da concerti che amo davvero molto.
Quando tu, giovane di origine italiana, dal Sud della Francia ti sei trasferito a Parigi in cerca di fortuna, hai collezionato una serie di collaborazioni strepitose, lavorando con autentiche leggende della musica francese: da Serge Reggiani a Juliette Gréco, da Claude Nougaro a Barbara fino a Georges Moustaki. Che cosa hai imparato da loro?
Diciamo prima di tutto che io stravedo per Parigi e per i suoi musicisti-poeti. E ovviamente anche per la musica popolare, il musette, che viene dall’Italia e che poi è approdata nella capitale francese e si è trasformata grazie a me, diventando new musette. Insomma, mi sento il cuore di questa storia. Per quanto riguarda la mia educazione di musicista, dopo essermi formato con mio padre – che insegnava fisarmonica – e al conservatorio di Nizza – dove ho studiato anche trombone – ho suonato con tutti questi grandi artisti , compreso Yves Montand, dato che una volta il mio amico Marcel Azzola aveva un problema e mi ha chiesto di sostituirlo in concerto. Ecco, ripensando a quel periodo formidabile devo dire che sono felicedi essere aperto a ogni tipo di musica, da quella popolare al jazz, dalla chanson fino alla classica. Pensa che di recente ho riscoperto un gigante della scena contemporanea come Pierre Boulez. Ovviamente conoscevo da tempo le sue composizioni; eppure, se devo essere sincero, avevo un rapporto difficile con la sua poetica. Oggi, invece, la sua musica «mi parla», è un grande esempio di rigore e di libertà.
Un incontro fondamentale per te è stato quello con Astor Piazzolla, il tuo mito, il maestro del bandoneón, l’artista che in qualche modo ha ispirato la tua svolta. Che tipo di uomo era il fondatore del nuevo tango? E c’è qualche aneddoto particolare su di lui che ci puoi svelare?
Piazzolla è stato un personaggio determinante nella mia vita. Ed è lui che mi ha consigliato di creare il new musette, cioè la musica che ha trovato forma nel disco di cui ti parlavo prima, «Viaggio», utilizzando la chitarra elettrica e una sezione ritmica jazz. Ho conservato le lettere che lui mi scriveva per aiutarmi a mettere a fuoco questo passaggio. Astor non mi ha mai chiesto di suonare la sua musica, sono io che più tardi ho voluto rendergli omaggio con un disco dedicato alle sue composizioni. La nostra è stata un’amicizia molto intensa, lo considero una sorta di padre. Certo, sembrava un uomo molto austero e severo ma, al tempo stesso, era una persona gentile e disponibile. Le origini italiane contavano molto per lui. Anche io ho le stesse radici e lui diceva che noi italiani siamo invincibili. Purtroppo negli ultimi tempi della sua vita era triste perché sosteneva che la gente non aveva davvero capito la sua musica. E aveva un progetto: scrivere un’opera sul grande tanguero Carlos Gardel. Però era molto stanco e malauguratamente non ce l’ha fatta, visto che due mesi dopo è mancato. Ripensandoci, provo una grande malinconia, perché Piazzolla è stato capito a fondo solo vent’anni più tardi, come succede spesso a tanti geni, le cui rivoluzioni vengono apprezzate in maniera adeguata dopo la loro morte.
Hai alle spalle oltre una settantina di album e un’incredibile serie di incontri con grandi improvvisatori. Se tu dovessi consigliare a un neofita i dieci dischi essenziali per scoprire l’universo poetico di Richard Galliano, quali sceglieresti?
Ti rispondo senza rifletterci troppo. Oltre a «Viaggio», un disco cui sono particolarmente legato è «Bach», quello che ho registrato per la Deutsche Grammophon. Un altro è «Blow Up», l’album in duo con Michel Portal: peccato che lui, che a novembre compie novant’anni, si sia ritirato dalle scene a causa di problemi di salute. Anche «Face to Face», che testimonia il mio incontro con Eddy Louiss, è un lavoro di cui sono molto orgoglioso. In più, sempre per DG, mi è molto caro «Nino Rota», l’omaggio alle incredibili colonne sonore del maestro italiano, realizzato insieme a John Surman e Dave Douglas. E, questo, dato che amo profondamente le musiche di questo grande compositore e i film di Federico Fellini: a sette anni ho visto «La strada» e per me è stata una folgorazione. Infine non posso fare a meno di citare il progetto con Paolo Fresu e Jan Lundgren, «Mare Nostrum», appunto. In quest’ultimo ventennio è un’esperienza che mi ha dato tanto sia sotto il profilo musicale sia a livello umano. Sono persone semplici e vere: per me lavorare insieme è stata una grande lezione di vita.
Un filo rosso che attraversa la tua carriera è la passione per gli autori di colonne sonore. Al di là dell’omaggio a Nino Rota, nel 2019 hai firmato l’album «Tribute to Michel Legrand» insieme al Prague String Quintet. C’è qualcosa che ti attira in modo speciale nel rapporto tra musica e cinema o il tuo è solo un amore legato a questi compositori?
Il mio è più che altro un amore per Rota e Legrand. E tuttavia ho sempre avuto un rapporto particolare con il cinema, soprattutto con quello degli anni Sessanta: penso ai film con Jean Gabin, Alain Delon, Annie Girardot e altri divi del grande schermo. Certo, anche oggi esistono autori interessanti tra i giovani, c’è un nuovo cinema sia in Francia sia in Belgio che mi piace molto. Viceversa non trovo che ci siano compositori di colonne sonore all’altezza dei grandi del passato che ho citato e penso ovviamente anche a un genio come Ennio Morricone. Per lo più ho la sensazione che adesso – almeno in generale – la musica da film sia un semplice accompagnamento, non abbia un valore autonomo. Confesso che mi piacerebbe cimentarmi con la scrittura di una colonna sonora per il cinema, però finora non mi è mai capitata l’occasione. Comunque sono ancora vivo e in forma, quindi mai dire mai!
Mozart, Bach, Vivaldi: non ti sei fatto mancare il rapporto con la musica accademica e in più sei l’unico fisarmonicista da concerto che ha registrato per la prestigiosa Deutsche Grammophon. Hai in cantiere altri progetti del genere?
Ho fatto le mie brave esperienze in ambito classico, come pure quella di riprendere le partiture di Astor Piazzolla, Oggi invece sono concentrato sull’idea di riprendere il filo del rapporto tra la musica francese e il jazz, un po’ sulla falsariga del mio disco «Viaggio», ossia ripartire dal musette, dal valzer e anche dalla chanson française.
Insomma, come avevi fatto nel 2015 registrando – insieme al chitarrista Sylvain Luc – il disco in duo «La vie en rose»…
Sì, certo. E, devo dire, ho un ricordo magnifico di quell’album e al tempo stesso sento una grande nostalgia per Sylvain, che è scomparso all’improvviso l’anno scorso. Era un genio e una persona carina, un uomo speciale e di incredibile sensibilità. Ricordo che, quando era appena arrivato a Parigi da Bayonne – la sua città – lo avevo segnalato a Marcel Azzola, che cercava un giovane chitarrista per registrare in studio insieme al cantante argentino Jairo. Sylvain era molto amato tra i musicisti.
C’è un altro gigante del jazz, che purtroppo ci ha lasciato, e con il quale hai avuto il piacere di suonare: Charlie Haden. Ci regali un suo ricordo?
Eravamo a Los Angeles quando ho registrato il disco «Love Day» nel 2008. E con noi c’erano anche Gonzalo Rubalcaba al pianoforte e Mino Cinelu alle percussioni. Ho un gran bel ricordo di quella registrazione e anche dei concerti fatti insieme. Charlie era una persona dal carattere particolare, a volte spigoloso, un po’ come Michel Portal. Ma, superati certi ostacoli, era un signore squisito e amabile, oltre che un artista straordinario.

È invece ancora vivo e in attività un altro big del contrabbasso, cioè Ron Carter, insieme al quale hai firmato sia «Panamanhattan», nel lontano 1990, sia «An Evening With» nel 2016. Ci parli delle registrazioni e dei concerti con lui?
Quando ci siamo rivisti, quasi ventisette anni dopo il primo nostro incontro, gli ho detto: «Ho sempre la stessa fisarmonica». E Ron mi ha risposto: «E io ho sempre le stesse corde del contrabbasso!». Lui per me è un esempio perché ha una bella età, 88 anni, però non gli manca la voglia di suonare e di mettersi in gioco sempre. È un artista molto organizzato, ama fare una scaletta precisa prima del concerto e gli piacciono gli accordi semplici. Facevamo sempre poche prove prima dei concerti ma bastavano. E spesso mi diceva: «La grande difficoltà con il jazz è che ogni sera dobbiamo suonare in maniera differente». Insomma, per me collaborare con una leggenda della musica improvvisata è stata una esperienza incredibile, qualcosa di molto emozionante. Quando gliel’ho confessato, Ron ha ammesso che dal canto suo, fin da giovane, lui aveva una passione per il rapporto tra la fisarmonica e il contrabbasso. E mi ha raccontato che il suo disco de chevet (cioè quello che amava di più e che perciò teneva sempre a portata di mano per riascoltarlo) era l’album di Mat Mathews «The Modern Art of Jazz» in cui il leader, fisarmonicista di origine olandese, duetta con il contrabbassista e violoncellista Oscar Pettiford. Ma c’è di più. Un’altra cosa che mi accomuna a Ron Carter è l’amore per la musica di Johann Sebastian Bach: lui, come me. ascolta in continuazione le opere del maestro tedesco.
Hai detto in varie occasioni che il tuo desiderio più grande era quello di dare al tuo strumento, ingiustamente definito il «pianoforte dei poveri», lo spazio che meritava. E hai spiegato che per te la fisarmonica è sempre stata uno «Steinway con le cinghie». È stato difficile dare valore e dignità a questo strumento nell’ambito del jazz e anche della classica?
Sì, non è stato affatto facile perché la fisarmonica è da sempre considerata uno strumento della musica popolare, un simbolo del folclore in molti Paesi del mondo. C’è stato un periodo – penso agli anni in cui andava per la maggiore in Francia il jazz manouche – in cui il grande chitarrista Django Reinhardt ha suonato con i massimi virtuosi di fisarmonica, tra cui Gus Viseur, Tony Murena e altri. Poi, però, il mio strumento è sparito dal jazz, veniva considerato una specie di Cenerentola. Quando ero giovane, questo atteggiamento di scarsa considerazione nei confronti della fisarmonica mi pesava, tanto che ero costretto a suonare per lo più il trombone e il pianoforte. Per fortuna attualmente le cose sono cambiate e gli appassionati di jazz non hanno più alcun pregiudizio nei confronti della fisarmonica e del bandoneón. Oltre ad Astor Piazzolla, chi mi ha dato la forza di continuare è stato Toots Thielemans, che era un caro amico.
Oggi, oltre alla fisarmonica, suoni anche la melodica, sia in concerto sia in sala di registrazione.
Sì, a essere precisi si chiama melowtone ed è una sorta di armonica con la tastiera. Uno strumento che amo; e adesso, ogni volta che lo suono, ripenso al caro Toots.
Una domanda sul tuo strumento: chi sono oggi i virtuosi di fisarmonica o di bandoneón che ti piacciono?
Tra gli italiani mi piace molto Vince Abbracciante. Poi amo lo stile di Antonello Salis, che è pure un amico, e di Daniele Di Bonaventura. Anche in Francia ci sono tanti artisti di alto livello: tra questi vorrei segnalare in particolare Vincent Peirani, che tra l’altro è stato mio allievo durante una masterclass quando era giovane.
