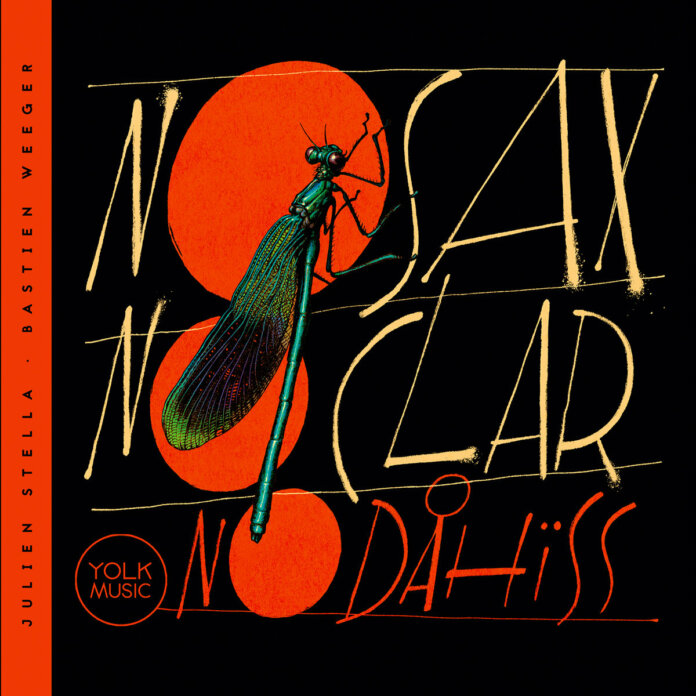Buongiorno Silvia. Parliamo subito del tuo nuovo progetto con Eric Mingus. Come vi siete conosciuti e come è nata l’idea di questo progetto?
Il progetto sulla musica di Gil Scott-Heron nasce circa un anno fa a Siena Jazz. Iacopo Guidi, il direttore artistico dell’accademia, vide in me la persona giusta per realizzare questo progetto, conoscendo già il mio interesse nei confronti del fenomeno Gil Scott-Heron. Mi propose quindi di guidare il mio gruppo di musica d’insieme del tempo verso la musica di Gil Scott-Heron, in vista della collaborazione estiva tra Siena Jazz e Accademia Chigiana. Considerato che il tema della parola era protagonista dell’evento, Gil Scott si presta molto, data la sua natura di cantante, poeta e scrittore. Partecipammo quindi al festival in una formazione che comprendeva non solo il gruppo da me curricularmente coadiuvato, ma inserimmo anche alcuni alunni ed ex alunni del SJU, tre alunni dalla Chigiana ed il cantante Michael Mayo (approfittando della presenza di quest’ultimo ai seminari estivi). Questa esperienza meravigliosa è stata il trampolino di lancio per selezionare il repertorio e, portando avanti e sviluppando il progetto, ho individuato la voce ideale per questo progetto: la voce di Eric Mingus.
Celebrating the influences of Gill Scott-Heron”. Quali sono le influenze del musicista di Chicago e qual è la sua eredità e chi l’ha raccolta, a tuo avviso?
Gil Scott Heron viene riconosciuto come il padre del rap, con il brano Revolution will not be Televised. Tenuto molto in considerazione dalla comunità afroamericana in quanto attivista dei movimenti sociali degli anni Settanta, ha larga considerazione anche nell’ambito jazzistico (a esempio il recente omaggio del batterista Makaya McCraven). A mio avviso, il fenomeno musicale e sociale non può e non ha potuto ignorare l’apporto che Gil Scott ha dato alla musica, facendo raccogliere la sua eredità a tutti senza differenze di stili e generi.
Qual è il tuo personale legame con Gil Scott-Heron?
Il mio personale legame con questo artista riguarda la vicinanza alla tradizione musicale afroamericana (blues, funk, gospel) di cui gli stilemi sono palpabili all’ascolto della sua musica. La sua provenienza geografica e culturale si riflette inesorabilmente all’interno delle sue opere, facendomi instaurare un senso di appartenenza e affinità.
Oltre a te ed Eric Mingus, chi altri c’è sul palco?
Giovani musicisti che hanno frequentato o frequentano tuttora i corsi di Siena Jazz: Noemi Fiorucci: (voce), Lusine Sargsyan (voce), Emanuele Marsico (voce e tromba), Isabel Simon Quintanar (sax tenore), Andrea Glockner (trombone), Gianni Franchi (chitarra), Santiago Fernandez (piano) e Matteo Stefani (batteria). Inoltre, musicisti già avviati: Simone Padovani (percussioni, voce) e Peewee Durante (tastiere, voce, trombone).
Come avete concepito il repertorio del concerto?
Il repertorio è stato selezionato da me, scegliendo come lait motif il brano Revolution will not be Televised e utilizzando connessioni testuali per sfociare in altri brani. Attraverso la narrazione musicale alcuni brani verranno eseguiti nella loro totalità, altri parzialmente, con inserti di improvvisazione e conduction.
Ci sarà anche un seguito discografico?
Sì, a breve ci sarà la registrazione del disco che ci impegnerà nella residenza al PARC di Firenze.
Silvia, diversi anni fa ti chiesi se l’essere donna e strumentista in Italia fosse ancora, diciamo, un problema. A distanza di anni, cosa rispondi a questa domanda?
È una domanda sempre molto particolare: com’è essere una donna musicista in Italia. A distanza di anni direi che la situazione è molto migliorata: si sono inserite molte più presenze femminili nel settore, evento che porta ad una crescente normalizzazione, anche se non in assenza di difficoltà. La premura di alcune musiciste e musicisti che guida verso la sensibilizzazione di questo fenomeno è e sarà la chiave di svolta del tema in questione.

Come va l’esperienza di Fonterossa?
L’esperienza Fonterossa procede bene. L’essere molto attiva musicalmente porta a non poca fatica a livello gestionale, però il lavoro singolo di ogni musicista si riversa nel collettivo, rendendo possibili ancora uscite di dischi e concerti. Questo fine settimana (20 e 21 aprile) si terrà il Fonterossa Day #8 grazie al supporto di Pisa Jazz e di Toscana Produzione Musica. Di questo evento ne vado molto fiera perché, oltre al crescente seguito, è uno strumento per rappresentare e far incontrare una fetta di musicisti italiani che opera nella musica originale, improvvisata e non convenzionale.
Quanto è importante per te il tuo strumento nella fase compositiva?
Per me il contrabbasso è molto importante nella fase compositiva, anche se non scrivo prettamente col mio strumento. Tendenzialmente mi piace comporre col pianoforte, perché mi aiuta ad avere una visione più ampia. Essendo molto affezionata al groove, il contrabbasso è sicuramente il veicolo migliore.
Per te l’improvvisazione è…
Questa domanda prevedrebbe un discorso molto ampio, ma cercherò di sviluppare una risposta esaustiva del mio pensiero. L’improvvisazione per me è “stare al mondo”, essere reattivi, preparati, in modo da poter reagire ad un impulso, saper accogliere, essere empatici. Capire, riconoscere ed elaborare: questo è un approccio ascrivibile sia alla musica formale che non, dalla quale può nascere la forma. In ogni caso, è una conscia risposta ad un impulso atta a creare musica. Per questi motivi penso che l’improvvisazione vada al di là degli stili.
Quali sono state le esperienze artistiche che reputi maggiormente formative?
Tutte. Ogni momento in cui ho potuto suonare il mio strumento, anche in contesti non tipicamente musicali, come quando ho lavorato con altre forme artistiche (arti visive, danza). Quando ho collaborato coi grandi maestri: ho avuto la fortuna di far parte dell’Art Ensemble of Chicago per gli ultimi due dischi. Sicuramente un’esperienza incredibile sia musicalmente che umanamente; tutte le esperienze fatte con Roscoe Mitchell, che ritengo il mio mentore. L’incontro nel 2005 con William Parker, che è stato per me un maestro della musica jazz e della musica improvvisata. L’incontro con Lawrence Butch Morris che mi cambiò la vita, scoprendo il sistema della conduction. Trovo estremamente formativo suonare coi miei studenti, perché mi ricordano che sono sempre uno studente: la musica è infinita e si impara sempre qualcosa di nuovo. Quindi ritengo importante rimanere nelle scarpe di un allievo ed essere sempre pronti ad evolvere, a mettersi in discussione.
Ci siamo conosciuti tanti anni fa a Siena, grazie a Franco Caroni. Qual è il ricordo che hai di lui?
Il dolore è ancora fresco, dovuto anche alla sorpresa della sua dipartita. Ho molti ricordi di Franco: sicuramente è il motivo per cui sono qui a parlare di me e di musica. Io suono jazz perché Franco mi ha supportato. Il primo ricordo che ho di lui risale a quando iniziai a suonare. Studiavo solo basso elettrico, e le domeniche pomeriggio mia madre mi accompagnava a casa di Franco che mi offriva lezioni gratuite di strumento. Questo per dire quanto lui teneva a dare la possibilità ai ragazzi di imparare.
Quali sono i tuoi prossimi impegni?
Mi piace fare piccoli passi, quindi al momento sto pensando al Fonterossa Day di questo fine settimana, alla residenza a Firenze e al concerto a Torino del progetto su Gil Scott con Eric: non vedo l’ora!
A quali altri progetti stai lavorando?
Attualmente sono a Berlino, dove sto per fare un concerto dedicato ad Ellington con Tomeka Reid, con cui recentemente ho registrato un disco negli Stati Uniti collaborando con lo Stringtet, due quintetti d’archi (uno di Chicago e uno di New York) e due batterie. Data la vincita di due anni fa del premio MacArthur ‘Genius’, Tomeka è riuscita a portare in studio questa formazione, facendo anche una serie di concerti e una residenza. Ad ora è il progetto da side man di cui sono più entusiasta. Parlando di Ellington, non posso non citare un disco di cui sono molto felice, registrato a fine marzo con giovani musicisti (Sergio Bolognesi, Emanuele Marsico, Guglielmo Santimone), vecchi amici (Emanuele Parrini, Tony Cattano), e un ospite da Chicago (Nick Mazzarella). Abbiamo eseguito un repertorio legato al periodo Jungle di Ellington. Appena usciranno sia il disco di Gil Scott che quello di Ellington, sarà la prima volta che faccio pubblicare due dischi di musica non originale, ma dediche a musiche di terzi. Non vedo l’ora di poter portare tutti questi progetti in giro!
Alceste Ayroldi