
Marty Ehrlich, nelle note di copertina di «A Trumpet In The Morning» si legge che per il Black Artist Group di St. Louis era molto importante, quasi imprescindibile, apprendere la storia della musica. Ma qual era la storia della musica per quei musicisti?
Eravamo alla fine degli anni Sessanta e, malgrado fossi ancora adolescente, ricordo bene che i musicisti del Bag consideravano il jazz in maniera molto ampia, come parte integrante della musica afroamericana. Stare con loro significava passare dal presente – e quindi John Coltrane, Cecil Taylor, Ornette Coleman, Sun Ra, che in quegli anni andavano per la maggiore – al passato del jazz. Mi stupiva anche l’interesse che il Bag nutriva nei confronti della musica accademica, anche europea. Dico questo perché negli Stati Uniti, contrariamente a quanto si pensa, né i cosiddetti tradizionalisti né tanto meno i cosiddetti sperimentatori conoscono davvero la storia della musica.
E tu, che musica ascoltavi?
La nuova musica di quegli anni, che trovavo per esempio nei dischi dell’Art Ensemble Of Chicago. Sentivo molto anche Coltrane ed Eric Dolphy. Per me quei musicisti davano senso al mondo in cui vivevo. Quando la scoperta del passato diventò un’esigenza, e in ciò fu decisiva la frequentazione del Bag, cominciai a ripercorrere la storia a ritroso: Charlie Parker, Louis Armstrong, lo Swing e via dicendo. Mi divertivo a tracciare connessioni cui potevo dare qualche senso logico, un continuo andirivieni tra passato e presente. Ma ci volle tempo prima che il mio percorso si definisse. Allora l’idea corrente era che si dovesse ascoltare prima la musica di New Orleans, poi il periodo Swing, poi il bebop e via dicendo. Il problema è che nessuno ascolta la musica in questo modo! Si può amare Beethoven senza per forza amare Haydn. O si possono amare le sinfonie di Beethoven prima di aver ascoltato quelle di Haydn. Il mio percorso procedette in autonomia.
Quindi non credi all’esistenza di una linea rossa che attraversa la storia del jazz?
Ha senso, soprattutto ripensando a quegli anni, ma la storia e ancor più la sua stesura lasciano sempre qualcosa alle spalle. Pensiamo a Charles Mingus o a George Russell. Se la storia fosse unica e lineare, dove li piazzeremmo? Certi artisti sono stati in grado di coprire più periodi contemporaneamente. Ciò significa che i periodi, tanto quanto le categorie, sono validi fino a un certo punto. Dal canto mio ho sempre cercato – e sono contento di averlo fatto – di mettere in relazione storie e ascolti tra di loro.
Sempre nelle note di «A Trumpet In The Morning» si legge che ti consideri «un panstilista che non crede negli stili musicali».
Ho preso in prestito il termine panstilista da Russell, con cui ho studiato e suonato. Mi spiego meglio: si tende a considerare una persona come fosse una cosa sola ma secondo me, se si è in grado di creare connessioni e di intravedere punti di contatto tra cose diverse, si diventa a propria volta tante cose diverse. Lester Bowie una volta disse che adorava suonare nell’Art Ensemble Of Chicago perché solo con quel gruppo poteva suonare tutta la musica che gli interessava. Perché? Perché era un gruppo di ampie vedute. È questo che intendo quando uso il termine panstilista. La creatività nasce pensando a tante storie diverse e non credo che certe storie siano finite solo perché appartengono al passato.Un esempio dal disco è forse Rundowns And Turnbacks, che offre uno spettro molto ampio di approcci musicali diversi tra loro.
 Come ti capitò di entrare nella New York Big Band di Russell?
Come ti capitò di entrare nella New York Big Band di Russell?
Fu lui a chiamarmi. George era stato mio insegnante al New England Conservatory. Una volta terminati gli studi mi chiese personalmente se volessi suonare il contralto nella sua big band. Mi diede un appuntamento e cominciammo a parlarne.
Potremmo quindi dire che quella versione dell’orchestra di Russell nacque con te. Non esageriamo, dai. George ebbe fiducia in me, questo sì. Con la sua band viaggiai molto e registrai due dischi: «George Russell New York Big Band» e «Live In An American Time Spiral». Fu una grande esperienza.
Russell è il tipico esempio di musicista che ha raggiunto maggiore successo in Europa che negli Stati Uniti.
Non è il solo. È semmai tutto il jazz ad aver raggiunto un pubblico più vasto in Europa che negli Stati Uniti. Meglio cambiare discorso perché finiremmo per parlare d’altro.
 Allora restiamo su «A Trumpet In The Morning», in cui utilizzi due sezioni ritmiche. Per quale motivo?
Allora restiamo su «A Trumpet In The Morning», in cui utilizzi due sezioni ritmiche. Per quale motivo?
Avevo già suonato con tutti i musicisti presenti nel disco e a dire il vero avrei potuto usare otto ritmiche diverse! Mi capita sempre più spesso di pensare ai brani in funzione dei musicisti, come se una specie di elemento interno guidasse la composizione e gli arrangiamenti. Per fare un esempio, in «A Trumpet In The Morning» credo di aver trovato alcune aree specifiche destinate a James Weidman, un pianista fenomenale. L’idea non è nuova: anche Duke Ellington scriveva spesso pensando ai suoi musicisti. Stesso discorso per le ritmiche, che avendo caratteristiche diverse rendono il disco più vario. E in Rundowns And Turnbacks mi tolgo lo sfizio di usarle entrambe.
Suoni il clarinetto in un solo brano.
Avevo altri obiettivi, anche se lo rimpiango un po’. Innanzitutto volevo concentrarmi sulla composizione e mi piaceva l’idea di poter usare tutti i solisti a disposizione. Per me si è trattato di una cosa nuova. In «The Long View», altro disco per orchestra, feci anche il solista ma la situazione era legata a presupposti diversi. «A Trumpet In The Morning» si prestava come banco di prova ideale per saggiare tutta la creatività dei musicisti. E poi c’è una ragione più pratica. Il disco è stato registrato in soli due giorni, seguendo ritmi a dir poco marziali. Neanche il tempo di riascoltare il materiale registrato e dovevamo passare subito alla sezione successiva. Se avessi dovuto fare anche il solista sarebbe stato ancora più difficile. Fortunatamente so come si lavora in studio e Oded Lev-Ari, un compositore e arrangiatore davvero eccellente, mi ha molto aiutato. Il mio prossimo disco sarà probabilmente pieno di miei assoli.
Il brano A Trumpet In The Morning, pezzo forte del disco, prende in prestito il titolo da una poesia di Arthur Brown. Quando hai scoperto il testo?
A St. Louis, quand’ero adolescente. Sentii Brown recitarlo almeno una volta. Purtroppo Brown scomparve troppo presto, a soli trentaquattro anni. Fortunatamente esiste una raccolta delle sue poesie.
Il brano era già stato eseguito in un’altra occasione.
Sì, una decina di anni fa ma, non mi convinse del tutto. Quella su disco è per me la vera première di A Trumpet In The Morning.
L’interpretazione del testo, che diventa una specie di concerto, è affidata a Jd Parran, ex membro del Bag.
Jd era un buon amico di Brown e, come molti altri membri del Bag, aveva l’abitudine di accompagnare la recitazione di poeti e scrittori. Per questo Jd è l’interprete di A Trumpet In The Morning.
Parliamo di un altro brano: Rundowns And Turnbacks. Il titolo proviene dalla descrizione che il bluesman Johnny Shines diede dello stile strumentale di Robert Johnson. Qual è il tuo rapporto con il blues?
Lo stesso rapporto che mi lega al jazz. Il blues è parte integrante della musica afroamericana e per questo l’ho studiato a fondo. Sono cresciuto a Louisville, nel Kentucky, e a St. Louis, in Missouri. Non posso dire di essere stato circondato dal blues, anche se in quei posti la presenza del blues, in un modo o nell’altro, è una costante. Rundowns And Turnbacks riflette sul fatto che i musicisti si sono sempre espressi in tante e diverse direzioni culturali. Crediamo che i cosiddetti country blues players suonassero solo blues ma se non è vero. Diversi studi hanno dimostrato che quei musicisti erano in grado di suonare molto altro: polke, gighe, musiche tradizionali e via dicendo. Il loro blues era una specie di risposta ai bianchi, un modo per accontentarli.
Sei un grande fan di Bob Dylan. Hai mai pensato di incidere un disco monografico dedicato a lui?
Altri l’hanno già fatto. Nel corso degli anni ho registrato tre brani di Dylan e due di essi sono per me molto importanti. In «Malinke’s Dance», Tears Of Rage di Dylan e Richard Manuel segue Pigskin di Julius Hemphill. E sono il primo ad aver registrato un brano di Dylan per la serie Radical Jewish Culture di John Zorn. «Sojourn» è un disco che mi rende ancor oggi orgoglioso, con una canzone di Dylan piazzata in mezzo a brani miei.
Hai menzionato Hemphill. Come l’hai conosciuto e perché è stato un’influenza così importante?
Conobbi Julius ai tempi delle scuole superiori ma diventammo amici solo dopo il mio trasferimento a New York, nel 1978; ero più grandicello e cominciammo a suonare insieme. Per un certo periodo vissi con Tim Berne in una specie di loft e Julius ci chiedeva spesso se potevamo ospitarlo. Fummo, per così dire, coinquilini. Quando negli anni Novanta decise di fondare il Julius Hemphill Saxophone Sextet, fui il primo – almeno credo – a essere chiamato. Mi disse: «Ho proprio voglia di creare un sestetto». Per circa cinque anni fu il mio datore di lavoro principale. Lavoravamo con la Bill T. Jones Dance Company; giravamo il mondo, partecipando ai festival. Poi Julius cominciò ad ammalarsi. A causa del diabete entrò in dialisi e il cuore cominciò a indebolirsi. Fu a quel punto che cominciai a passare più tempo con lui. Tra alti e bassi, andavo a trovarlo regolarmente. Si trattò di un’amicizia davvero preziosa. Questi ricordi non spiegano però il valore artistico di Julius, che considero uno tra i più grandi compositori del Ventesimo secolo. Dopo la sua scomparsa, nel 1995, ho continuato a suonare la sua musica in maniera forse più intensa e consapevole, e nel ruolo di direttore musicale ho proseguito il percorso con il sestetto. Ho registrato brani inediti per Tzadik, New World, Clean Feed, che testimoniano un lavoro di ricerca all’interno del catalogo di Julius. Una miniera che, a mio parere, dev’essere ancora esplorata.
In un certo senso hai mantenuto accessibile il catalogo di Hemphill?
Cerco di farlo. Vorrei che musicisti e altri artisti potessero accedere alla musica di Julius: questo aiuta a mantenere viva la sua opera. E poi trovo che il messaggio musicale di Julius debba essere ancora assorbito.
Perché lo definisci uno tra i più grandi compositori del secolo scorso?
Per tante ragioni. In generale per la qualità della scrittura. Le melodie di Julius erano impressionanti, legate ad armonie e idee ritmiche bellissime. È una musica compiuta, rifinita. Forse dipende dal fatto che Julius annotava e scriveva regolarmente su partitura: a differenza di altri era un vero compositore da carta e penna. Era anche una persona sentimentale; un autore molto poetico. Gli piacevano le cose semplici e scriveva in maniera semplice: non a tutti è concesso. Eppure, dietro quella semplicità apparente, si celava una profondità (e profondo era il suo modo di essere) comune a ogni grande compositore afroamericano. Come Ellington e Thelonious Monk – esempi tra i tanti – Julius era capace di guardare avanti e indietro nel tempo; poteva scrivere musica davvero originale e, qualche battuta dopo, evocare un mucchio di eventi storici e musicali. Oggi non lo ascolto più come qualche anno fa, perché conosco molto bene la sua musica. Ma quando mi capita di farlo rimango sempre sbalordito. E Hemphill era un vero compositore da carta e penna, molto poetico allo stesso tempo quando penso a Julius compositore non posso separarlo dall’improvvisatore.
Nel 1978 decidesti di trasferirti da Boston a New York. Fu un passo necessario per la tua carriera?
Sì, perché volevo far parte di ciò che stava accadendo a New York. Tutti i musicisti di Saint Louis che conoscevo si erano trasferiti laggiù e anche alcuni di quelli di Boston che più apprezzavo. All’inizio ero un po’ impaurito. New York era una città grande e non sapevo se ce l’avrei fatta. Ma alla fine andò tutto per il meglio e, nel giro di breve tempo, trovai il mio spazio in quella nascente scena jazz newyorkese per la quale nutrivo una vera passione. Il fatto di essere un polistrumentista mi permise di entrare in diverse big band. Suonai con Russell, Jaki Byard, Wadada Leo Smith, Leroy Jenkins, Muhal Richard Abrams, Oliver Lake. Ritrovai John Lindberg con cui avevo già suonato nel gruppo di Charles «Bobo» Shaw ai tempi dello Human Arts Ensemble. Proprio con Bobo tenni il mio primo concerto in Italia.
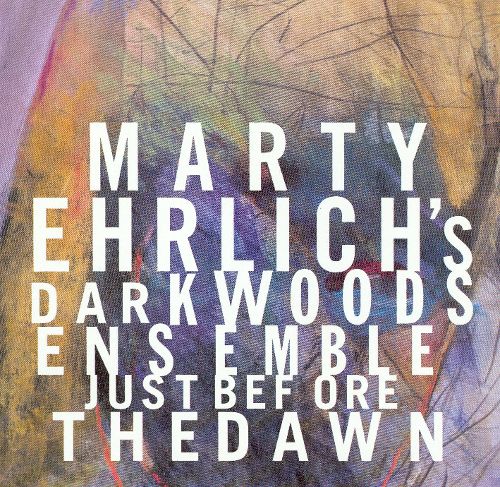 Tra i tanti gruppi che hai avuto, mi incuriosisce sapere se il Dark Woods Ensemble sia ancora in attività.
Tra i tanti gruppi che hai avuto, mi incuriosisce sapere se il Dark Woods Ensemble sia ancora in attività.
Non proprio. Ho suonato musica del periodo Dark Woods con Erik Friedlander, Drew Gress e Liberty Ellman allo Stone, nel novembre 2013, in occasione di una retrospettiva sulla mia carriera. E mi sono divertito molto. Spero un giorno di fare ancora qualcosa con quel gruppo. Vedremo.
La particolarità di quel gruppo era il ruolo centrale affidato a clarinetto, violoncello e contrabbasso.
Vero. E poi c’erano gli ospiti. In «Emergency Peace» chiesi a Muhal di suonare in un paio di brani. In «Just Before The Dawn» ci sono Vincent Chancey al corno e Don Alias alle percussioni e, in «Sojourn», Marc Ribot alla chitarra. Insomma, ho sempre aggiunto strumenti diversi.
Ho letto da qualche parte che anche tu hai scritto poesie.
E te lo confermo. Smisi di scrivere quando decisi di diventare musicista.
Le hai conservate?
Sì, tutte.
E magari un giorno ti verrà voglia di pubblicarle.
Non mi dispiacerebbe. Prima, però, vorrei trovare più concerti in Europa. Il Rites Quartet ha ricevuto buone recensioni ma la risposta presso i festival europei è stata debole. Mi piacerebbe molto scrivere nuova musica – e, perché no?, incidere un disco – per contralto e quartetto d’archi. E sto anche pensando a nuove piccole formazioni con contrabbasso e batteria.
Luca Civelli









